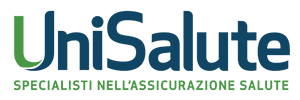14 Aprile 2016
Testo unico sul vino
Condividi
La Commissione agricoltura della Camera dei Deputati, ha dato il via libera alla disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Un percorso lungo e complesso, culminato con la stesura del Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto ed adottato come Testo base.
Di seguito, si riporta un'analisi illustrativa dei principali contenuti del provvedimento la cui architettura prevede 89 articoli, organizzati all'interno di 8 Titoli.
- Nel Titolo I (articoli 1-3), che reca le disposizioni introduttive, trovano spazio l'ambito di applicazione della norma e le singole definizioni.
- Il Titolo II (articoli 4-24) prevede la disciplina delle norme di produzione e commercializzazione del vino. Per quel che riguarda il potenziale produttivo, la norma si riferisce alle varietà di uva da vino iscritte al registro nazionale e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee alla coltivazione. Il dispositivo normativo interviene successivamente in materia di "Vitigno autoctono italiano" e "schedario vitivinicolo". All'interno del primo ambito, rientrano le viti di origine nazionale ed utilizzate per la produzione di vini di qualità certificata (DOP-IGP) mentre, le procedure, le condizioni e le caratteristiche necessarie per il riconoscimento dei vitigni, sono demandate ad un successivo decreto ministeriale. Sul fronte dello schedario, se ne prevede l'istituzione al fine di monitorare il potenziale produttivo nazionale. La sua gestione (che contiene informazioni sui vigneti idonei alla produzione di vini DOCG, DOC e IGT) è affidata alla Regioni che si avvalgono del SIAN mentre, la funzione di controllo, fa capo all'AGEA. Per quanto riguarda le uve diverse da quelle per la produzione di vini di qualità, il disegno di legge dispone che la resa massima per ettaro debba essere pari o inferiore a 50 tonnellate. In seguito, si introduce la disciplina che regola la produzione e le pratiche enologiche, a partire dalla definizione della planimetria dei locali (destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti), che dovrà rispondere a determinati requisiti ed essere trasmessa all'ufficio territoriale. I successivi articoli, intervengono per determinare il periodo vendemmiale e della fermentazione (dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno); per definire determinati prodotti, quali il "mosto cotto", il "filtrato dolce", il "mosto muto" e l'"enocianina"; per disciplinare la detenzione di vinacce e fecce e le sostanze vietate. Sempre nell'ambito della disciplina delle norme di produzione,, infine, trovano spazio le pratiche necessarie alla produzione di vini frizzanti e di vino biologico. L'ultima parte del Titolo II, riguarda le norme di commercializzazione. In tale ambito, attraverso gli articoli 23 e 24, sono introdotte, da un lato le disposizioni che distinguono la detenzione di vini a scopo commerciale da quella a scopo di consumo, dall'altro i principi che regolano i divieti di vendita e somministrazione.
- Il Titolo III (articoli 25-41), dispone in materia di tutela del sistema di denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Per quel che riguarda l'utilizzo, il Testo unico esclude i vini gassificati dal sistema DOP e IGP, così come tutti i casi d'induzione all'errore per i consumatori finali. La classificazione, invece, prevede che le produzioni DOP siano quelle che utilizzano le menzioni nazionali DOC e DOCG mentre, le IGP, comprendano la classificazione delle Indicazioni geografiche territoriali (IGT). L'ambito territoriale può includere specifiche sottozone e unità geografiche aggiuntive, nel caso dei vini DOP, espressamente delimitate. L'articolo 30, interviene per definire tutte le specificazioni e menzioni ("classico", "riserva", "superiore", "novello", "passito", etc..) espressamente previste all'interno dei disciplinari di produzione. In seguito, il dispositivo disciplina i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, prevedendo che le DOCG siano riservate ai vini già riconosciuti DOC per almeno 10 anni; le DOC, a prodotti già IGT da almeno 5 anni. Si passa poi ai requisiti obbligatori dei disciplinari di produzione tra cui, si segnalano: la delimitazione della zona di produzione; la descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche; le rese massime, l'indicazione delle varietà di uve utilizzate e le specifiche condizioni ambientali e di produzione. Importante, all'interno del Titolo III, è la disciplina dei Consorzi di tutela prevista all'articolo 40. Tra le finalità, sono indicate la consulenza, le attività di assistenza tecnica, la tutela e la salvaguardia delle produzioni certificate, le attività di promozione e d'informazione e le attività di vigilanza. Il riconoscimento, invece, deve rispondere al criterio minimo della rappresentatività (35% dei viticoltori e il 51% della produzione media certificata), includere uno statuto e prevedere strutture e risorse adeguate alle funzioni. Nel caso specifico in cui il Consorzio sia rappresentato da almeno il 40% dei viticoltori e dal 66% della produzione media certificata, le funzioni diventano più articolate (ad/ es politiche di gestione delle produzioni, organizzazione e coordinamento di attività di commercializzazione). In ogni caso, le attività di vigilanza e controllo, dovranno essere svolte in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF.
- All'interno del Titolo IV (articoli 42-47), trovano spazio le norme in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità. A tal riguardo, si prevede che l'utilizzo delle denominazioni d'origine debba risultare conforme ai rispettivi disciplinari di produzione mentre i nomi propri, le ragioni sociali di ditte, cantine, fattorie e simili non si considerano impiego di denominazioni di origine. Eccezioni sono previste per l'uso dei marchi commerciali registrati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, limitatamente ad alcune fattispecie. Inoltre, il nome della regione o della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica, può figurare in etichetta a condizione che sia separata dalle indicazioni obbligatorie e rientri tra le informazioni complementari. Continuando, il testo di legge prevede che qualora in etichetta siano nominate due o più varietà di vite, queste debbano figurare in ordine decrescente di percentuale (rispetto all'effettivo apporto delle uve); con caratteri aventi le stesse dimensioni e rappresentare almeno il 15 % del totale delle uve utilizzate. Di rilievo, infine, le disposizioni sui recipienti e contrassegni dei vini DOP e IGP che prevedono l'esclusivo utilizzo della chiusura con "tappo a fungo" per i vini spumanti e, in deroga, per il confezionamento dei "vini frizzanti". Nel caso dei vini DOCG, invece, l'immissione al consumo deve avvenire in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a quindici litri. Entrambi i recipienti, devono essere muniti di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (utilizzato, anche per il confezionamento dei vini DOC) e le cui caratteristiche, modalità di fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, sono demandati ad un decreto ministeriale.
- La disciplina degli aceti, è contenuta all'interno del Titolo V. Si prevede innanzitutto che la denominazione "aceto di…" sia riservata a prodotti ottenuti dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, con un'acidità totale, compresa tra 5 e 12 grammi di acido acetico per 100 millilitri e una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 % in volume (derogabile fino a 1,5 per prodotti definiti dalla normativa comunitaria vigente). In secondo luogo, il disegno di legge introduce una serie di divieti nell'ambito della produzione, detenzione e trasporto di aceto che riguardano, ad esempio, i prodotti alterati all'esame organolettico, quelli che contengono aggiunte di particolari sostanze liquide (alcol etilico, acido acetico sintetico, etc) oppure ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti. In ogni caso, resta vietata la distillazione dell'aceto. Per quel che riguarda le pratiche e trattamenti consentiti, sono ammesse quelle autorizzate dall'Unione Europea, nonché l'aggiunta di acqua, la decolorazione con il carbone per uso enologico e l'aggiunta di caramello. Le sostanze aromatizzanti, invece, possono essere aggiunte fino al 5% in volume. Importante la disciplina dei registri di carico e scarico (obbligatori e tenuti in ambito SIAN) dove, tra le principali annotazioni, dovranno esserci la data dell'operazione; il quantitativo in entrata e in uscita delle materie prime; la trasformazione e lo scarico del prodotto. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. Infine, l'utilizzo delle certificazioni DOP e IGP consentito a condizione che l'elaborazione avvenga esclusivamente a partire da vini di qualità certificati.
- Il Titolo VI (articoli 57-68) reca la disciplina degli adempimenti amministrativi e dei controlli. Sul primo fronte, si prevede che nell'ambito del SIAN debbano essere inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti delle imprese. Per quel che concerne i registri, l'articolo 60 del disegno di legge obbliga i produttori alla tenuta di un registro (in ambito SIAN e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale) aggiornato di carico e scarico (stesso obbligo per gli utilizzatori dei prodotti). Sul fronte dei controlli, si dispone innanzitutto che sia il Mipaaf l'autorità nazionale incaricata di controllare l'osservanza con la normativa UE. Spettano invece alle autorità pubbliche e agli organismi di controllo, le verifiche annuali del rispetto dei disciplinari di prodotti DOP e IGP. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni di qualità certificata sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo. Per ottenere l'autorizzazione al controllo (che ha durata quadriennale), gli organismi devono presentare al Mipaaf un piano di controllo, il tariffario e il certificato di accreditamento (se organismo privato). La stessa autorizzazione, può essere sospesa o revocata in seguito al verificarsi di circostanze negative (mancato rispetto procedure, carenze generalizzate, comportamenti discriminatori, etc…). Di rilievo l'articolo (60) che interviene per definire gli elementi dell'analisi chimico-fisica e organolettica necessaria ai fini della rivendicazione e all'utilizzo delle denominazioni DOP (DOCG-DOC). Saranno apposite commissioni di degustazione ad effettuare l'esame organolettico, i cui criteri di riconoscimento sono demandati ad un decreto del Mipaaf. Lo stesso decreto dovrà disciplinare le procedure generali delle analisi nonché le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti.
- Nel successivo Titolo (VII) (articoli 69-86), il disegno di legge disciplina il sistema sanzionatorio. In considerazione della moltitudine e varietà delle sanzioni previste, di seguito si riportano, esclusivamente, le informazioni riguardanti le principali violazioni (per le sanzioni specifiche si rimanda all'articolato). In quest'ottica, le prime violazioni prese in considerazione dal Testo unico, riguardano il potenziale vitivinicolo e, in particolare, quelle relative al non rispetto delle autorizzazioni per nuovi impianti introdotte dall'ultima riforma della politica agricola comune. Successivamente, sono riportate le sanzioni per comportamenti non conformi in materia di vinificazione e distillazione tra cui, per citare alcuni esempi, l'introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino; la vinificazione di uve non classificate da vino; la violazione dell'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da superfici abusivamente piantate con uve classificate come uve da vino. Negli articoli 71 e 72, invece, trovano spazio le sanzioni per l'utilizzo di prodotti non consentiti (ad/ es zuccheri diversi da quelli provenienti da uve da vino e/o destinati all'alimentazione umana) e non giustificati (prodotti vitivinicoli che non trovano riscontro dalla documentazione di cantina). Passando alle violazioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti, si segnalano la produzione e la vendita di vini certificati (DOP e IGP) che non rispettano i requisiti dei disciplinari; usurpazioni, imitazioni e evocazioni dei marchi di qualità; indicazioni non consentite e ingannevoli (sempre relative ai vini DOP e IGP) poste sulle confezioni o nella pubblicità; contraffazione e alterazione dei contrassegni di qualità. Tra le violazioni di carattere amministrativo, rientrano: l'impedimento del libero accesso agli agenti preposti alla vigilanza, l'assenza di dichiarazioni di raccolta, produzione e giacenza di prodotti vitivinicoli; la dichiarazione di un quantitativo maggiore di quello realmente prodotto; la violazione di tutti gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento e alla tenuta dei registri. Inoltre, sanzioni sono previste anche per gli organismi di controllo inadempienti rispetto agli obblighi impartiti dalle autorità pubbliche; e per i soggetti che, impropriamente, svolgono attività rientranti tra quelle attribuite dalla normativa ai Consorzi di tutela (gli stessi Consorzi sono passibili di sanzioni, nel caso in cui risultino inadempienze rispetto alle prescrizioni previste nel decreto di riconoscimento). Si segnala, infine, che in caso di reiterata violazione, il prefetto competente può disporre la chiusura temporanea dello stabilimento di produzione e che l'erogazione delle sanzioni amministrative, fa capo all'ICQRF.
- Le norme transitorie e finali, sono collocate all'interno degli ultimi tre articoli (dall'87 all'89) che compongono il Titolo (VIII) del disegno di legge.