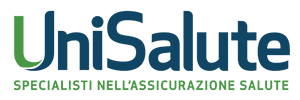21 Giugno 2013
Il presidente Politi alla VII Conferenza economica della Cia: l'agroalimentare è un volano per la ripresa. Ora investire nel settore primario puntando sui giovani
Investire nell'agroalimentare, rafforzare le imprese, superare le inefficienze del mercato, accelerare e promuovere il ricambio generazionale. Sono queste le linee-guida che la Cia-Confederazione italiana agricoltori seguirà per cercare di dare una svolta che apra nuove prospettive al settore primario e contribuisca alla ripresa e alla crescita economica del Paese. A indicarle è stato il presidente nazionale Giuseppe Politi nella relazione tenuta alla VII Conferenza economica che si è aperta oggi a Lecce.
I giovani e l'agricoltura. Disoccupazione giovanile e ricambio generazionale sono i principali problemi da affrontare per costruire il futuro dell'agricoltura. L'esigenza del ricambio generazionale si inserisce in un quadro di continua erosione delle imprese che operano nel settore. Bisogna, infatti, considerare che dal 2009 a 2012, come affermato anche nel rapporto del Censis, le imprese agricole iscritte alle Camere di Commercio sono diminuite di circa 60.000 unità.
I positivi segnali di nuovi ingressi nel settore, soprattutto per quanto riguarda le società agricole e giovani imprenditori, non compensano, purtroppo, la moria delle imprese.
Vi sono deboli segnali positivi di ripresa della presenza di giovani nelle campagne, ma è ancora troppo presto per parlare di una consolidata inversione. A ben vedere sono proprio i dati sulla scarsa presenza di giovani che evidenziano la fragilità della nostra agricoltura rispetto agli altri Paesi europei.
L'agricoltura vive due tendenze contrastanti. La prima è un'elevata mobilità sociale dovuta alle profonde modifiche che hanno interessato il mercato del lavoro. Sono soprattutto i figli degli occupati nel settore agricolo che hanno cambiato classe sociale rispetto a quella dei genitori. La seconda tendenza è che, al netto della struttura generale dell'occupazione, le famiglie agricole tendono a trattenere maggiormente, rispetto alle altre classi sociali, buona parte dei propri figli.
Le proposte per favorire l'ingresso dei giovani sono: istituire la Banca della terra; approvare la legge per la difesa del suolo e dell'agricoltura; inserire nei piani di sviluppo regionali un "pacchetto giovani" obbligatorio e dotato di adeguate risorse; favorire l'accesso al credito; promuovere l'innovazione, la ricerca e la formazione; promuovere la diffusione delle tecnologie informatiche nelle aree rurali.
La riforma della Pac. In queste ore a Bruxelles e Lussemburgo si decide su una parte importante del nostro futuro.
Per quanto ci riguarda ribadiamo con forza la nostra posizione tesa al raggiungimento di alcuni obiettivi, ad iniziare dalla possibilità di decidere a livello nazionale le specifiche per la definizione di agricoltore attivo, la semplificazione del greening, la possibilità di disporre del 15% del budget del primo pilastro per i pagamenti accoppiati allo scopo di poter definire interventi di politica agricola nazionale sulla base di esigenze particolari di settori e di territori.
Sulle decisioni inerenti la Pac ormai siamo in dirittura di arrivo. Ancora però non riusciamo a intravedere il nastro della partenza per ciò che riguarda le decisioni da assumere a livello nazionale.
Non vorremmo ancora una volta trovarci di fronte ai tanti annunci in Parlamento, in occasione di convegni, o nelle riunioni a livello comunitario, ma poi di concreto nulla viene fatto. Abbiamo condiviso molte dichiarazioni e impegni assunti o meglio annunciati da parte delle ministro De Girolamo, ma, per esempio, non conosciamo quale sarà la posizione del governo italiano nella trattativa a livello comunitario sul futuro della Pac e, soprattutto nulla sappiamo nel merito degli orientamenti da decidere a livello nazionale.
Dobbiamo difendere la Pac e le risorse finanziarie a essa destinate, ma dobbiamo anche guardare più in alto per verificare la strada percorsa e non fare riferimento solo a essa. Le politiche europee devono essere accompagnate da forti e credibili scelte nazionali capaci di adattare la Pac alle nostre specificità esaltando le grandi capacità presenti nel nostro settore e nei diversi territori.
Una nuova Pac, ma per quale agricoltura? L'evoluzione della Pac, dalle sue origini all'attuale proposta, mostra il passaggio da una visione essenzialmente produttiva dell'agricoltura ad una più ampia che associa al settore agricolo funzioni economiche, principalmente la produzione di beni alimentari, la generazione di reddito e occupazione nelle aree rurali; la funzione ambientale, cioè la conservazione del paesaggio e della biodiversità, la salvaguardia idrogeologica e, più in generale, la valorizzazione delle risorse naturali locali; la funzione sociale, cioè il mantenimento delle tradizioni e del tessuto socio-culturale locale.
A esse aggiungo la funzione culturale: la collettività riscopre il territorio e il mondo agricolo attraverso la bellezza del paesaggio e del cibo che esprimono, con le loro forme concrete, il rapporto che ciascuna comunità ha saputo stabilire con l'ambiente nel quale è insediata.
Come già dissi alla Conferenza economica del 2009, oggi non si parla solo di "agricoltura" e di "agricoltori", ma si tende ad accentuare, quasi contrapponendole, diverse agricolture: convenzionale e biologica, multifunzionale e pluriattiva, produttiva e sociale, di mercato o a km0, rivendicando ognuna un proprio primato nelle politiche e nel riconoscimento della pubblica opinione. Non il frutto di diversità, che è ricchezza, ma di visioni alternative.
Occorre superare questa contrapposizione che nasce da un contrasto ideologico che nasconde, ancora oggi, un'ostilità nei confronti dell'agricoltura produttiva. Come se agricoltura competitiva e sostenibile fosse un ossimoro, indicando caratteristiche e obiettivi antagonisti e incompatibili.
Consorzi Agrari. E' tempo di riaprire il capitolo Consorzi agrari. La legge n.99 del 2009 ha riconosciuto ai Consorzi agrari la mutualità prevalente. Il Governo ha riconosciuto la legittimità del credito di 400 milioni vantato dalla Federconsorzi per le passate attività di gestione degli ammassi.
La legge riconosce ai Consorzi agrari funzioni pubblicistiche nell'interesse dell'intera agricoltura: "I Consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione e al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura".
I Consorzi agrari appartengono alla storia e al patrimonio degli agricoltori. Sono nati per operare nell'interesse di tutta l'agricoltura. Per gran parte della loro storia sono, invece, stati considerati strumenti di parte.
Questo ha minato la loro solidità ed è stato uno dei motivi del loro tracollo all'inizio degli anni Novanta.
La storia si sta ripetendo: i Consorzi agrari sono nuovamente piegati a un progetto di parte. Un progetto che si chiama "Filiera agricola tutta italiana", ma si traduce nella costituzione della sesta centrale cooperativa. Il cui presidente è contemporaneamente anche presidente della Coldiretti.
Alla fine del 2011 i Consorzi agrari hanno costituito il fondo immobiliare chiuso AGRIS, al quale hanno conferito una parte del patrimonio immobiliare non strumentale di loro proprietà, con un portafogli iniziale di 45 immobili per un valore di 100 milioni.
Vi sono state molte proteste da parte di soci e consiglieri di minoranza dei Consorzi agrari che hanno contestato soprattutto la mancanza di trasparenza delle operazioni.
Per quali fini, per quali investimenti, a quali progetti è destinata tutta questa liquidità?
La legge assegna, congiuntamente, ai ministri dello Sviluppo economico e dell'Agricoltura, i compiti di vigilanza sui Consorzi agrari.
Poniamo una sola questione. Chiediamo che i ministri impongano il rispetto della lettera e dello spirito della legge di riforma: i Consorzi agrari devono essere un patrimonio di tutta l'agricoltura e non di una parte.
Chiediamo anche un pronunciamento delle forze politiche presenti nel Parlamento, soprattutto di quelle che, indipendentemente dalle posizioni assunte, molto hanno discusso e contribuito alla legge di riforma e alla successiva concessione ai Consorzi agrari della mutualità' prevalente.
Insomma, in una situazione così critica dell'economia e dei bilanci pubblici (dello Stato e delle Regioni) non possiamo permettere che centinaia di milioni siano gestiti in modo non trasparente.
Oggi assistiamo a un processo di riorganizzazione del mondo cooperativo e associativo che coinvolge le imprese e le loro stesse rappresentanze. Il sistema dei Consorzi agrari non può essere estraneo a questo processo: non possiamo permettere che esso sia usato per una strategia di divisione e contrapposizione tra gli agricoltori e le loro rappresentanze.
Noi ci proponiamo di valorizzare quel sistema con le nostre idee, contribuendo a un progetto con l'obiettivo di includere e non di escludere. Su questo progetto metteremo alla prova la nostra capacità di lavorare per l'unità degli agricoltori, in nome degli interessi di tutti i produttori agricoli. Su questo progetto chiediamo il sostegno delle istituzioni, Parlamento, Governo e Regioni.
Consumo del suolo agricolo. Dal 1970 a oggi, in Italia abbiamo perso 5 milioni di ettari di Sau. L'Italia oggi produce poco più dell'80 per cento delle risorse alimentari necessarie a coprire il fabbisogno dei propri abitanti. Il tasso sta subendo una progressiva diminuzione. Il più alto grado di dipendenza si ha per prodotti considerati strategici, quali i cereali e le carni, 72-73 per cento, e semi oleosi, 30 per cento, alla base dell'alimentazione del bestiame.
Per soddisfare il fabbisogno della propria popolazione, l'Italia si trova in una condizione di profonda dipendenza dalle dinamiche economiche, demografiche e sociali dei Paesi di approvvigionamento. Ciò rende inderogabile la limitazione dei processi di consumo dei terreni agricoli e la preservazione della loro produttività. Da queste motivazioni discende il disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo approvato dal Governo alla fine della scorsa legislatura. Una proposta coraggiosa e condivisa che dovrebbe diventare una delle priorità del Parlamento.
La crisi e le politiche per la crescita. Al presidente del Consiglio e al ministro De Girolamo è giunto da Agrinsieme, il coordinamento Cia, Confagricoltura e Alleanza cooperative agroalimentari l'impegno a una leale e fattiva collaborazione, perché finalmente si possano realizzare le condizioni di una ripresa che fondi le sue radici nell'economia reale e, dunque, anche sull'agricoltura e l'agroalimentare. Le nostre priorità sono contenute nel documento "I principali temi agricoli per la XVII legislatura" che è nelle mani del Presidente Letta e dei ministri.
L'Italia sta, infatti, attraversando la più grave recessione della sua storia. La crisi globale iniziata nel 2007-2008 ha colpito l'economia italiana più severamente di molti altri paesi avanzati. Fra il 2008 e il 2012, in Italia il Pil è sceso del 6,5 per cento, in Germania è aumentato del 3,7 per cento.
Anche l'agricoltura ha pagato pesantemente il prezzo della crisi: il valore aggiunto è diminuito del 5,5 per cento (-4,4 per cento solo nel 2012).
Nei prossimi mesi avremo molto da lavorare sui temi fiscali. Il presidente ha indicato l'agenda dei lavori del suo Governo: riduzione della pressione fiscale, a partire dal costo del lavoro; revisione della tassazione vigente sugli immobili; prosecuzione degli interventi di pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese; allentamento del patto di stabilità interno; rinuncia all'aumento dell'Iva; aumento del fondo di garanzia per la piccola e media impresa e del fondo di solidarietà per i mutui; ampliamento degli incentivi fiscali per gli investimenti in innovazione; sostegno all'aggregazione e all'internazionalizzazione delle imprese; semplificazione e rimozione degli ostacoli burocratici alla attività delle imprese.
È stato confermato il ministero delle politiche agricole e le due Commissioni parlamentari. Non era scontato. Si sono evitate scorciatoie e soluzioni pasticciate al tema di grande attualità della revisione delle disposizioni a suo tempo introdotte con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Come abbiamo scritto nel documento di Agrinsieme, essa "dovrà costituire impegno prioritario del nuovo Parlamento. È una riforma essenziale per rendere più efficiente il sistema istituzionale del nostro Paese".
Le correzioni che proponiamo dovranno superare le criticità che si sono manifestate nella regolazione dei rapporti tra Stato e Regioni anche in materia di agricoltura. Esse dovranno, inoltre, intervenire sulla struttura del Governo. Come è scritto nel documento di Agrinsieme: "il settore agricolo non trova più corrispondenza in termini progettuali e di sviluppo nella configurazione attuale del Ministero delle Politiche Agricole: è decisivo affidare ad una Amministrazione di riferimento la competenza sul comparto agroalimentare nel suo complesso, in termini di strategie agroindustriali, sanitarie e con una visione internazionale del comparto. Lo stesso andrebbe pensato ai livelli regionali, dove anche la capacità di spesa delle risorse europee va inserita in progetti ampi di sviluppo".
Il tema del cambiamento è una costante della politica: salvo poi rifugiarsi nell'interpretazione del Gattopardo di un mondo che cambia per rimanere uguale a se stesso.
Anche "rendita" è un termine relativamente nuovo nel lessico della politica, ma non per noi. Nel documento per la V Assemblea nazionale elettiva del 2010 si legge: "Vogliamo difendere gli imprenditori agricoli e non i percettori di rendita fondiaria". La terra non deve essere "bene rifugio ed elemento di speculazione finanziaria".
A ben vedere, la nostra stessa idea di unità della rappresentanza agricola può essere letta come un voler mettere in discussione quella particolare forma di rendita che deriva dall'occupare posizioni consolidate e particolarmente favorevoli nella rappresentanza. La volontà di mettersi in gioco, senza annullare la propria storia e identità, ma calare sul tavolo le proprie idee e proposte, discuterne, proporre una sintesi che diventa patrimonio comune d'impegno sindacale. Con l'ambizione di allargare il confronto all'insieme delle rappresentanze delle piccole e medie imprese per rafforzare la nostra proposta.