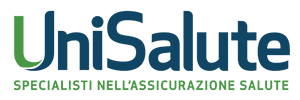17 Gennaio 2012
Alleanza Contadini in Veneto: la parola ai protagonisti che hanno fatto la storia della Cia
Le radici della Cia in terra veneta. Non il racconto d'altri tempi, bensì la viva testimonianza degli uomini e delle donne che sono stati protagonisti della storia della Confederazione agricola fin dagli albori. Un viaggio che ha inizio alla fine degli anni '50, quando nasce l'Alleanza Contadini.
Per ripercorrere la strada fatta da allora ad oggi, la Cia del Veneto ha voluto organizzare tre incontri "ad hoc", il primo dei quali si è svolto venerdì 13 gennaio presso la sede della Cia di Padova. Nessuno slancio nostalgico sull'onda del "come eravamo". Piuttosto la volontà espressa dal presidente della Cia del Veneto, Daniele Toniolo, di "capire da dove veniamo per definire dove andare" in prospettiva della prossima 'Conferenza dello sviluppo' del sistema Cia in calendario il 22 marzo a Roma.
Protagonisti di questa pagina di storia della Cia sono stati Emilio Pegoraro, deputato e senatore della Repubblica, già presidente di Cia Padova; Damiano Rech, presidente a Belluno dell'allora Cic-Confederazione italiana coltivatori; Giovanna Gazzetta, ex direttore del patronato Inac e oggi presidente dell'Associazione pensionati Veneto; Danilo Riello, storico segretario della sezione di Camposanpiero. Ognuno di loro ha contribuito a portare un tassello, un pezzo di storia dell'associazione.
Più in dettaglio, Emilio Pegoraro, classe 1922, lucido e saldo testimone di un'intera vita dedita all'impegno sindacale e politico, nel suo racconto è partito da molto lontano. Ripercorrendo i primi passi dell'organizzazione con un excursus storico che si è spinto ben più in là del giorno in cui l'Alleanza Contadini ha messo radici. E non a caso la strada comincia dall'ultimo tratto del percorso che portò all'Unità d'Italia: allora i contadini rappresentavano una massa di manovra in senso antiliberale contro il modello piemontese. La prima ragione dell'avversione al processo di unificazione? La mancata riforma agraria. Figlia della miseria fu poi l'emigrazione. "Un milione di persone ha lasciato il Veneto e il Friuli alla fine dell'Ottocento, ha puntualizzato Pegoraro nel suo impeccabile racconto. Una partenza di massa dalle dimensioni mai viste. Esodo, pellagra, vaiolo solcano gli anni a cavallo della fine dell'Ottocento fino allo sfociare della crisi agraria dei primi anni del Novecento. E' da quella lotta che ha inizio la storia moderna del movimento contadino. Nel 1893, nel padovano a Loreggia, nasce la prima cooperativa contadina: è un embrione di organizzazione. Sempre nel 1893 in seno alla Camera del lavoro patavina è la volta di Federterra, la prima unione professionale dei lavoratori della terra che raccoglieva sotto lo stesso tetto coltivatori diretti e mezzadri, coloni e contadini in affitto (fittavoli). Fino alla Grande Guerra si lotta per contratti agrari più civili e per i diritti di prelazione. Dopo la seconda Guerra mondiale e il ventennio fascista, gli anni della Resistenza e la liberazione per le campagne inizia una nuova era. Dal '44 al '46 cambiano i nomi e le organizzazioni: si assiste alla trasformazione di Federterra in Confederterra e infine in Associazione Coltivatori diretti. L'attività di Alleanza Contadini, nata da una costola di Federterra, a Padova fa la sua apparizione nel 1951: "Il primo atto fu quello di marcare la nostra autonomia -ha ricordato Pegoraro- e non voler copiare la Coltivatori diretti". Lotta alla mezzadria e politica della professionalità furono le fondamenta: "Era il punto di partenza necessario per rispondere alle esigenze di assistenza e previdenza degli associati e affrontare i problemi agricoli che si presentavano". I pilastri dell'Alleanza Contadini erano ormai gettate. La costruzione dell'organizzazione prende forma e fin da subito si afferma per la capacità di differenziare la rappresentanza degli agricoltori associati. E' del 1959 l'Associazione ortolani. In seguito l'Alleanza Contadini dei Colli Euganei. All'interno dell'Alleanza germogliavano sezioni che potrebbero assomigliare in tutto e per tutto agli attuali gruppi di interesse.
Un capitolo a parte merita la vicenda dell'"Arca del Santo" della quale Emilio Pegoraro fu diretto protagonista. L'Arca del Santo fu sì una pagina di storia veneta, ma ancor prima italiana. La cronaca della protesta contadina e il continuo "braccio di ferro" per ottenere il diritto di vivere e lavorare quelle terre tennero banco tra la fine degli anni '60 e il '76 sulle pagine dei principali quotidiani nazionali. Il racconto costellato di dovizia di particolari lo ha consegnato lo stesso Pegoraro nel suo libro: "Agricoltura, i protagonisti del cambiamento", pubblicato da Cia Padova nel 2005, dal quale durante l'incontro sono stati letti alcuni brani. Nel 1405 Francesco II da Carrara, quale risarcimento dei debiti contratti per sostenere la guerra contro i veneziani, cedette la gastaldia di Anguillara alla Basilica del Santo di Padova. Si trattava di circa tremilacinquecento campi padovani, utilizzati per le necessità del sacro edificio. L'Arca del Santo aveva mantenuto pressoché inalterata la proprietà fin dal 1405, non avendo consentito alcuna cessione se non in rari ed eccezionali casi per motivi di pubblica utilità. Inaspettatamente si privò della tenuta il 23 gennaio 1974, vendendo in blocco a certi Balzarini e Corvi, commercianti bresciani, suscitando la ribellione dei cittadini di Anguillara che si vedevano strappare la terra su cui avevano vissuto per tanti anni, generazione dopo generazione.