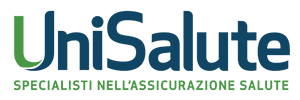03 Dicembre 2003
Tracciabilità e rintracciabilità nel settore agro-alimentare
Archivio
Condividi
Dal 25 al 28 novembre scorsi si è svolto a Bruxelles, presso la sede della regione Umbria al Parlamento europeo, un workshop di aggiornamento e professionalizzazione sulla "Tracciabilità e rintracciabilità nel settore agro-alimentare". Incontro riservato a dirigenti e amministratori di mercati all'ingrosso e centri agro-alimentari funzionari pubblici preposti ai controlli di qualità, responsabili di associazioni di produttori, operatori. Il workshop,con il patrocinio della regione Umbria e del comune di Foligno, è stato organizzato da Arulef Belgio in collaborazione con la Confederazione italiana agricoltori, Andmi (Associazione nazionale direttori mercati italiani), Fedagro (Federazione grossisti alimentari), Informercati e con il contributo di Sistema mercati e Mercati associati.
Ai lavori hanno partecipato anche il presidente della Cia Massimo Pacetti e il presidente dalla Cia dell'Umbria Walter Trivellizzi. Pacetti, nel suo intervento, ha sottolineato l'impegno dell'agricoltura italiana nella valorizzazione della qualità e la sicurezza alimentare. La tracciabilità e la rintracciabilità, in tale contesto, assumono un ruolo di grande importanza.
Il presidente della Cia ha anche evidenziato la necessità di rafforzare il rapporto fra agricoltura e consumatori e rendere più incisiva la filiera agro-alimentare. Pacetti ha rilevato inoltre l'esigenza di una difesa della tipicità dei prodotti agricoli, troppe volte penalizzati sui mercati.
Ai lavori è intervenuto anche Pino La Rocca, responsabile Cia dei rapporti con la grande distribuzione, mercati e consumatori, che ha svolto una relazione che di seguito riportiamo.
Negli ultimi tempi si fa un gran parlare di tracciabilità, rintracciabilità, di sicurezza alimentare, di qualità, di sistemi di qualità, di prodotti certificati, di autocertificazioni, ecc.
Non sempre a proposito e con cognizione di causa, visto che non sono solo gli addetti ai lavori a parlarne, questi termini sono divenuti comunque di uso comune ed il loro entrare nella vita di tutti i giorni dimostra come ci sia un bisogno ed una richiesta di prodotti alimentari con requisiti che vanno oltre i tradizionali canoni di bontà.
Le norme dell'UE e le leggi nazionali disciplinano le procedure e dettano obblighi comportamentali per determinare la sicurezza alimentare che è un pre-requisito comunque atteso dal consumatore negli alimenti; questo della sicurezza possiamo considerarlo un primo aspetto della qualità , quello che attiene ad una qualità igienico-sanitaria, che garantisce l'assenza di residui chimici o di sostanze proibite, che assicuri l'igiene.
La qualità, o meglio le qualità, sono invece quell'insieme di azioni e di comportamenti volontari che l'imprenditore mette in opera per qualificare il suo prodotto e per avere una propria visibilità sul mercato; da parte del consumatore la qualità può essere definita come il grado di percezione dei requisiti , impliciti ed espliciti al prodotto, e che sommariamente possono essere indicati in piacere sensoriale, attese nutrizionali e salutistiche, soddisfazione psicologica e culturale, tutela, valori etici ed infine servizi connessi al prodotto.
Sicuramente nel settore agro-alimentare il profilo della qualità è molto complesso proprio perché l'alimentazione rappresenta la base di uno dei diritti fondamentali dell'uomo: il diritto ad una vita sana ed al benessere.
Ritornerò successivamente per approfondire il punto di vista della CIA su una questione, quella della qualità e dei sistemi di qualità, che riteniamo fondamentale per la nostra agricoltura, per svilupparla e per affrontare le sfide che il mercato globale già da ora ci impone.
La situazione della filiera agricola italiana è quanto di più variegato si possa immaginare; ci sono alcuni settori che hanno compiuto passi in avanti negli ultimi anni ed oggi danno tranquillità agli agricoltori, per quanto si sa che non è possibile vivere sugli allori e che bisogna sempre essere pronti ad innovarsi per non essere superati, altri che si stanno movendo nella direzione giusta , altri ancora non riescono a individuare una strategia che consenta loro di guardare al futuro con tranquillità.
Se prendiamo ad esempio il settore vitivinicolo, vediamo che ha subito negli ultimi anni una ristrutturazione profonda che ha tagliato molti rami secchi, che ha inciso molto sia sulla struttura produttiva che su quella di trasformazione, ma che ha raggiunto ormai livelli di competitività impensabili solo qualche decina di anni addietro.
Gli scandali che hanno colpito questo segmento importante della nostra agricoltura negli anni addietro, hanno accelerato un processo di cambiamento che ha messo al primo posto la questione della qualità e ne ha fatto l'elemento vincente di un percorso che partendo dagli impianti dei vigneti, passando per tecniche di coltivazione innovative, migliorando gli impianti e le tecniche di trasformazione fino ad un sistema distributivo moderno, è riuscito a raggiungere l'obiettivo di valorizzare un prodotto che non ha alcun timore riverenziale a confrontarsi con i più agguerriti concorrenti esteri.
La stessa cosa si sta verificando nel settore delle carni dove, dopo la vicenda della BSE , con i consumi azzerati e con il reddito degli allevatori seriamente compromesso, si è ripartiti con dei progetti di qualità che hanno visto premiato l'impegno che il mondo agricolo ha profuso in tema di tracciabilità e di qualità legata al territorio; in un momento in cui bisognava riconquistare la fiducia dei consumatori e dare loro certezze , il nesso tra alimentazione, salute, sicurezza alimentare, tutela ambientale e valorizzazione delle risorse territoriali si è rivelato determinante.
In questi due settori oltre alla scommessa vincente fatta sulla qualità, vi è un ulteriore fattore comune: il processo di ristrutturazione che ha portato inevitabilmente ad una concentrazione del prodotto che di conseguenza ha facilitato l'adozione di sistemi di qualità più avanzati oltre che consentire un più moderno sistema di commercializzazione e la possibilità di acquisire nuovi clienti.
Un discorso a parte merita la filiera ortofrutticola. L'ortofrutta rappresenta una notevole fetta dell'agricoltura italiana: 950.000 aziende tra orticole, frutticole ed agrumarie, una produzione di circa 32 milioni di tonnellate e l'utilizzo di 1,4 milioni di ettari. L'Italia è il primo paese europeo per produzione sia di frutta che di ortaggi nonché per valore aggiunto di tali produzioni; superiamo sia la Spagna che la Francia detenendo una quota di circa il 20% del totale europeo per gli ortaggi e del 31% per la frutta.
Questo dato non trova però corrispondenza nella capacità di essere partner privilegiati di altri paesi per l'esportazione dei nostri prodotti, anzi la nostra bilancia dei pagamenti vede assottigliarsi anno dopo anno il saldo attivo proprio nel settore ortofrutticolo.
Volendo fare una riflessione approfondita non possiamo che partire dalla indiscussa capacità di produrre, a volte anche in condizioni di difficoltà, da parte dell'agricoltura italiana, di ortofrutta di grande qualità.
Le condizioni climatiche, i terreni vocati, alcuni ecotipi che tramandano dei sapori antichi, le innovazioni che hanno saputo sposare le nuove richieste a livello di aspetto del prodotto con la bontà tradizionale, sono fattori che ci vengono riconosciuti ma non sono bastati a farci acquisire un ruolo adeguato nell'esportazione verso i mercati del nord-europa; gli olandesi, i francesi e per ultimo anche gli spagnoli hanno conquistato questi mercati e noi troviamo difficoltà ad inserirci ed acquisire spazi che, pure in teoria, dovrebbero essere alla nostra portata anzi, come detto prima, continuiamo a perdere quote di mercato.
La globalizzazione dei mercati inoltre ci mette in concorrenza con nuovi emergenti paesi produttori che si stanno affermando anche sul piano qualitativo. Tutto ciò ci ha fatto perdere negli ultimi anni, come accennavo prima, una parte del saldo commerciale attivo; da uno studio dell'ISMEA si nota come a fronte di una esportazione di ortaggi pari al 12% ne importiamo per il 9,5% e questo per il primo paese produttore di ortaggi in Europa francamente è un risultato poco brillante.
A mio avviso due sono i principali fattori che impediscono di accrescere le nostre esportazioni:
§ Scarso livello dei sistemi organizzativi e logistici;
§ Frammentazione della base produttiva che impedisce la possibilità di avere un'offerta adeguata alla domanda delle grandi centrali di acquisto, nonché per lo stesso motivo, la possibilità di poter passare a sistemi di qualità che possano avere il gradimento dei mercati di riferimento.
La conferma la si può trovare in un altro studio ISMEA che riporta un'indagine svolta in alcuni Paesi europei con interviste ai responsabili della grande distribuzione organizzata, importatori e buyer. Ne esce fuori un quadro non certamente positivo per quanto riguarda i fornitori italiani che perdono il confronto con i colleghi olandesi, francesi e spagnoli soprattutto per l'organizzazione, il servizio, il pakaging ed il rispetto dei contratti di fornitura, il tutto mentre viene, dagli stessi intervistati, ribadito il primato italiano nella qualità associata al sapore oltre che alla notevole varietà ed alla tipicità dei prodotti stessi.
Anche la mancanza di una adeguata concentrazione del prodotto e quindi la possibilità di poter effettuare la fornitura con regolarità è vista come un elemento negativo. Del resto la produzione ortofrutticola italiana organizzata nelle varie forme, non rappresenta più del 25% e questa condizione oltre ad impedire la possibilità di porsi come interlocutore credibile nei confronti dei clienti esteri, impedisce anche di acquisire rapidamente, ed in tempo utile, i mutamenti della domanda e quindi di poter programmare utilmente le colture ed i propri investimenti.
La riforma dell'OCM, che doveva dare un impulso al settore con una valorizzazione delle OP, non ha raggiunto, almeno in Italia, completamente l'obiettivo che doveva e deve essere quello di aggregare il più possibile il prodotto. Il limite posto dal regolamento europeo di fatto consente di costituire in quasi tutta l'Italia una OP con un fatturato pari a 3 miliardi delle vecchie lire: non è certo l'esempio di un'aggregazione che possa affrontare i problemi dell'ortofrutta in maniera determinante e risolutiva. Credo che si possa e si debba andare ad una modifica del regolamento aprendo la porta anche al mondo degli imprenditori commerciali, ponendo ovviamente dei limiti che impediscano a quest'ultimi di acquisire il governo della società, in modo da poter realmente creare organismi associativi di dimensioni tali da essere in grado di dare guida ed indirizzi a questo settore che deve necessariamente unire alle indiscusse capacità produttive dimostrate finora, un'affermazione nella commercializzazione globale tale da toglierlo da una precarietà che mortifica l'impegno e la passione dei produttori. Questo significa pensare a nuovi soggetti che operino esclusivamente per affermare i prodotti sul mercato, che in questo progetto investino risorse proprie e contemporaneamente ricerchino eventuali risorse pubbliche; soggetti che siano veramente utili agli agricoltori , che si occupino di prodotto e non di carte che elaborino strategie e progetti per la difesa e la valorizzazione delle produzioni di qualità e non siano ulteriori strutture burocratiche che pesino sui produttori.
Se questo si verificherà sarà più facile parlare di sistemi di qualità che possono essere adottati da una parte consistente della produzione agroalimentare italiana. Oggi 1/3 del fatturato dell'industria alimentare italiana risponde comunque ad una qualità codificata evidenziando come non sia impossibile potenziare i sistemi di qualità e renderli adeguati a politiche commerciali che trovino penetrazione e successo tra i consumatori.
I produttori spesso sono frenati dall'intraprendere politiche di questo genere perché è indubbio che la qualità costa, costa produrla, costa certificarla, costa veicolarla e spesso non viene adeguatamente remunerata. Le ragioni di ciò possono essere molteplici ma derivano tutte dalla poca forza contrattuale che gli agricoltori hanno nei confronti degli altri soggetti della filiera agricola. Un'indagine di Nomisma ci dice che i 3/4 dei consumatori italiani sono disposti a spendere il 10% in più per l'acquisto di un prodotto che abbia dei requisiti qualitativi maggiori di quello tradizionale; più del 50% è disposto a spendere un 20% in più sempre per produzioni di qualità ed 1/4 addirittura il 50% in più. Vi è quindi un ampio bacino di utenza che è orientato verso dei prodotti che abbiano dei requisiti, ovviamente certificati, di qualità a patto che questa possa essere percepita e riconosciuta al di là della certificazione.
Perché allora, visto le peculiarità delle nostre produzioni, si incontrano numerose difficoltà a giungere alla certificazione di prodotto? Perché la qualità costa e spesso l'agricoltore non riesce a farsela pagare.
Le produzioni di qualità rappresentano, a mio avviso, una grande opportunità per l'agricoltura italiana; occorre però che l'intera filiera stabilisca regole condivise e che ciascuno poi rispetti i patti.
Poiché il consumatore paga solo se percepisce la qualità e molto dipende dalle strategie commerciali, dal marchio e dalla capacità di mandare un messaggio che venga recepito; il mondo agricolo, in alcuni settori e per alcuni prodotti, pur lavorando per ottenere una qualità riconosciuta, non ricava nulla in più rispetto al prodotto tradizionale perché il valore aggiunto rimane ad esclusivo vantaggio dell'anello commerciale della filiera. Posso citare casi di aziende che preferiscono vendere il loro prodotto biologico come tradizionale perché almeno risparmiano il costo della certificazione. Ovviamente sono casi limite ma esistono e debbono indurre ad una seria riflessione.
Queste difficoltà non possono e non debbono fermare il lavoro di tanti che hanno scommesso su processi ed orientamenti che vanno nella direzione di affrontare il mercato puntanto non solo sulla salubrità dei prodotti, ma anche su una qualità "sensoriale"; i consumatori infatti hanno diritto ad avere sempre prodotti sani e garantiti, ma hanno lo stesso il diritto di cercare e trovare prodotti diversi che rispondono alle proprie personali attese. Il primo diritto deve essere garantito dalla legge e per i produttori rappresenta un obbligo; il secondo è invece una grande opportunità: interpretando e rispondendo alle richieste dei consumatori, il produttore trova i valori e la soddisfazione economica del proprio agire. E' ovvio che questa seconda qualità pur se volontaria, una volta scelta, deve rispettare norme e percorsi certi.
Questo concetto lo troviamo anche sul tema della tracciabilità, così come previsto dal regolamento CE 178/2002, cioè sulla capacità di individuare o ricostruire la storia di un alimento mediante l'identificazione dei flussi materiali, delle fasi produttive e degli operatori della filiera. L'impostazione comunitaria, riconoscendo l'enorme variabilità e complessità delle filiera agroalimentare, non detta norme prescrittive, ma ne fissa i principi, lasciando liberi i produttori di adottare i sistemi di rintracciabilità più idonei, purchè efficaci e documentati.
Quante sono le strategie di qualità che si possono praticare nel settore agroalimentare? Certamente sono molte e possono divenire addirittura un problema se non si rivedono visioni e logiche di riferimento ormai superate.
Ci sono strategie legate alla vendita diretta degli agricoltori a consumatori locali, con i quali si instaurano spesso relazioni di conoscenza ed amicizia; molte aziende raggiungono livelli di assoluta eccellenza. Si tratta di una tipologia da non sottovalutare perché fornisce livelli di reddito molto soddisfacenti per molti imprenditori, ma neanche da enfatizzare perché rappresenta comunque un segmento limitato di imprese.
Vi sono strategie legate alla vendita di prodotto tipico trasformato e confezionato a negozi particolari, a ristoranti e catene specializzate. E' un segmento in forte evoluzione: prodotti tradizionali, strade del vino, strade di prodotti tipici, gastronomia di nicchia. In ogni caso vi è una forte identità territoriale; si tratta qui di valorizzare, con marchi garantiti, un esteso patrimonio di saperi perfezionati nel tempo e di tecnologie adattate a specifici ambiti locali. Un grande ruolo, trattandosi di prodotti che debbono essere tutelati da denominazioni registrate a livello comunitario, è demandato ai consorzi di tutela che debbono pianificare efficaci programmi di azione.
Per le strategie legate al comparto dell'ortofrutta e della carne appare molto appropriata la certificazione volontaria di prodotto. Sono certificazioni fondata su disciplinari che indicano l'origine, il controllo dei residui, la conformità varietale, la ricchezza di elementi nutritivi, l'uso delle tecniche di agricoltura integrata che valorizzano il territorio e l'ambiente.
Se tralasciamo i prodotti di nicchia, la strategia del mondo agricolo deve essere finalizzata a migliorare le relazioni intersettoriali e a ricercare il reciproco beneficio tra tutti i soggetti della filiera; occorre quindi, prima di tutto, che le imprese agricole si associno ed attraverso questi organismi associativi implementino i sistemi di gestione per la qualità con il risultato di ridurre i costi dei controlli di filiera ed aumentare il potere contrattuale.
Oggi la globalizzazione ha indotto ad elaborare strategie che sembravano impossibili pensare solo dieci anni fa; ci si è reso conto che nessun produttore singolo, che nessuna struttura associativa esistente può rinchiudersi in se stessa e pensare di poter affrontare il mercato con le sole proprie forze. Sono sempre più numerose le iniziative che vedono più soggetti della filiera associarsi per meglio affrontare, con progetti mirati, un futuro dove si corre il rischio di essere schiacciati tra la GDO e le grandi marche internazionali.
Nei mesi scorsi aziende tra loro concorrenti si sono unite in progetti che mirano a creare una concentrazione di prodotto tale da poter competere a livello internazionale con organizzazioni che hanno una lunga tradizione associativa. A Fondi è stata creata COMITALY, una SpA, che promossa dall'Ente Gestore del Centro Agroalimentare di Fondi, vede la partecipazione della locale Camera di Commercio e di 40 operatori del mercato tra grossisti, commissionari e cooperative agricole. Questa società con un capitale di 2 milioni di Euro si propone appunto di riuscire dove le singole imprese, pur significative, non sono arrivate: aggregare una produzione che consenta di realizzare volumi tali da poter consentire una pianificazione non solo commerciale ma che interessi tutta la filiera. Si tratta di coordinare strategie di programmazione delle produzioni con attenzione alle specie ed alle varietà, della definizione di processi di qualità aziendali e di prodotto, di passare da un individualismo atavico ad un concetto di sinergia che abbassa i costi, apre nuovi scenari prima preclusi e in definitiva produce un reddito maggiore. L'obiettivo dichiarato è quello dell'internazionalizzazione dell'ortofrutta italiana mediante creazione di piattaforme distributive in ambito europeo. Un analoga iniziativa è stata varata anche da 27 aziende che hanno creato Mediterranean Fruit Company, società consortile che partendo dalle stesse esigenze si propone di creare le condizioni per sviluppare, a favore delle imprese socie, attività commerciale all'estero.Tra i soci vi sono realtà già molto significative a livello nazionale come Apofruit e questo conferma che la necessità di creare nuove aggregazioni è un sentito comune e che nessuno in questo settore ed in questo momento può dormire sugli allori.
Sono progetti ambiziosi e di grande profilo che puntano:
§ A gestire grandi quantità di prodotto
§ A fare una politica di marchio unico che identifichi l'intera gamma della produzione ortofrutticola commercializzata dalla società
§ Ad ottenere produzioni di elevato standard qualitativo
§ Ad un sistema logistico adeguato con un packaging che sia all'altezza delle produzioni commercializzate
§ Ad una gestione della qualità mediante l'applicazione di rigidi manuali che prevedano dei disciplinari di produzione integrata, controlli di filiera e tracciabilità
§ Infine un ufficio commerciale che sappia tradurre in contratti vantaggiosi tutto questo impegno
Non è una scommessa facile e occorre che non ci si aspetti di vedere da subito i risultati di tanto impegno. Il percorso non è semplice ed occorre investire anche molte risorse, umane ed economiche. L'alternativa è di continuare a perdere di competitività nei mercati esteri e di dover subire anche sui nostri mercati la concorrenza di produzioni provenienti da paesi comunitari e non.
Non credo che questi processi possono comunque essere lasciati soltanto a singole iniziative, occorre che tutti i soggetti che a vario titolo attengono al settore agroalimentare si adoperino perché ci sia una adesione convinta a queste strategie; la difesa della nostra agricoltura passa anche attraverso la promozione dei nostri prodotti e questa può essere effettuata, da una parte incentivando le politiche di qualità volontaria e dall'altra mettendo a disposizione, da parte degli enti competenti, strumenti e risorse finalizzati allo scopo.
Volendo sintetizzare per punti si può affermare:
- che sempre maggiori sono le motivazioni che inducono i vari soggetti della filiera agricola a creare aggregazioni per poter competere nel mercato globale;
- che queste aggregazioni sono costruite su progetti di sviluppo che tengono conto, per ciascun anello della filiera, delle condizioni esistenti e delle potenzialità in prospettiva. Il progetto tenderà a collocare la nuova impresa in un contesto più ampio che apre prospettive di maggior soddisfazione economica;
- che il mercato è oggi dominato dalla GDO e dalle grandi marche; è ovvio che il mondo agricolo deve cambiare le proprie strategie ed attrezzarsi per non essere schiacciato dalle politiche commerciali di questi soggetti;
- che uno degli elementi che può giocare a suo favore è la gestione della qualità; non lasciare cioè che della qualità da esso prodotta ci sia un'appropriazione da parte di altri soggetti: appropriazione di immagine, di fidelizzazione del cliente, di ritorno economico;
- che non vi è una sola qualità, ma esse sono molteplici come numerose sono le certificazioni possibili;
- che esiste una qualità di base senza la quale il prodotto non ha mercato, penso ovviamente a quella che chiamiamo salubrità del prodotto o qualità sanitaria;
- che esiste una buona percentuale di consumatori che sono disposti a pagare per una qualità riconosciuta e riconoscibile;
- che i costi per produrre la qualità possono essere ampiamente recuperati a condizione di essere soggetti con potere contrattuale nei confronti della distribuzione;
- che la qualità ha bisogno di essere percepita dal consumatore e quindi, dopo averla progettata, realizzata, occorre anche pubblicizzarla e renderla identificabile;
- che i marchi commerciali che identificano prodotti di qualità debbono essere il più possibile in mano ai produttori;
- che bisogna investire quindi, non solo nel realizzare progetti di qualità ma anche per pubblicizzarla;
- che i soggetti in grado di realizzare tutto ciò sono preferibilmente società in grado di vedere al loro interno la partecipazione di più soggetti: la produzione, i servizi (dal packaging alla logistica a quelli finanziari ecc.), la commercializzazione e perché no, anche la ricerca e la sperimentazione.
Questo incontro, così interessante e ben organizzato, è stato ideato tra l'altro dall'associazione dei direttori di mercato, e prima di concludere voglio accennare brevemente al ruolo che i nuovi Centri Agroalimentari possono svolgere in questo ambito.
Non possiamo nascondere che la crisi che negli ultimi anni ha colpito il settore ortofrutticolo si riverbera anche nei mercati all'ingrosso. Le difficoltà hanno determinato processi di ristrutturazione nel settore, le aziende più piccole tendono ad essere espulse dal sistema e vediamo che lo scenario si modifica rapidamente.
Il calo dei consumi ortofrutticoli, l'Ismea ha parlato per lo scorso anno del 10%, è comunque un dato oggettivo e non contestabile; le ragioni sono molteplici: la dinamica dei prezzi, le abitudini alimentari, l'arretratezza a volte del sistema distributivo e così via.
Io credo che i Centri Agroalimentari o mercati all'ingrosso, se ci piace di più chiamarli ancora in questo modo, hanno un ruolo importante, di stimolo e di indirizzo, da giocare in questo momento e su questi problemi. Coinvolgere gli operatori di mercato sugli scenari che si stanno aprendo nel panorama internazionale, prevedere addirittura dei seminari per discutere sui temi dell'internazionalizzazione, dei processi e dei mutamenti in atto, potrà servire a far avanzare il livello di comprensione di un fenomeno che prima o poi interesserà tutti noi.
Anche nella gestione dei servizi di mercato si dovrà mettere più attenzione verso questi aspetti con la creazione, dove non esistono, o con il potenziamento se già esistenti, degli uffici qualità che non debbono servire solo a reprimere ma anche ad indirizzare ed orientare.
La creazione, dove possibile, di laboratori di analisi all'interno dei mercati è utile soprattutto per incentivare una politica di attenzione verso i consumatori e serve anche a dare un'immagine diversa di un mondo che, spesso a torto, è identificato come poco sensibile a questioni di grande impatto sociale.
Posso portare a testimonianza della bontà delle cose sopra accennate l'esempio del C.A.A. di Fondi dove tutto ciò è stato realizzato e dove quotidianamente si lavora su queste problematiche. Non siamo un'isola felice, anche da noi si verificano le difficoltà che tutti conoscete, ma con costanza, superando i mugugni di chi è refrattario all'innovazione, pian piano si sta modificando una situazione che poteva sembrare statica; come vi dicevo, abbiamo promosso la costituzione di una società che tende a conquistare nuovi mercati e che ha messo in primo piano la questione della qualità e su questo ci crede a tal punto che tutte le aziende socie si sono impegnate ad intraprendere la strada della certificazione di sistema oltre che prevedere la certificazione di alcuni dei più significativi prodotti commercializzati.
Il futuro ci dirà se raggiungeremo l'obiettivo prefissato, certo è che non si può stare fermi mentre tutto, intorno a noi, si muove e cambia rapidamente.
<a name=_msocom_1></a>
Dal 25 al 28 novembre scorsi si è svolto a Bruxelles, presso la sede della regione Umbria al Parlamento europeo, un workshop di aggiornamento e professionalizzazione sulla "Tracciabilità e rintracciabilità nel settore agro-alimentare". Incontro riservato a dirigenti e amministratori di mercati all'ingrosso e centri agro-alimentari funzionari pubblici preposti ai controlli di qualità, responsabili di associazioni di produttori, operatori. Il workshop,con il patrocinio della regione Umbria e del comune di Foligno, è stato organizzato da Arulef Belgio in collaborazione con la Confederazione italiana agricoltori, Andmi (Associazione nazionale direttori mercati italiani), Fedagro (Federazione grossisti alimentari), Informercati e con il contributo di Sistema mercati e Mercati associati.
Ai lavori hanno partecipato anche il presidente della Cia Massimo Pacetti e il presidente dalla Cia dell'Umbria Walter Trivellizzi. Pacetti, nel suo intervento, ha sottolineato l'impegno dell'agricoltura italiana nella valorizzazione della qualità e la sicurezza alimentare. La tracciabilità e la rintracciabilità, in tale contesto, assumono un ruolo di grande importanza.
Il presidente della Cia ha anche evidenziato la necessità di rafforzare il rapporto fra agricoltura e consumatori e rendere più incisiva la filiera agro-alimentare. Pacetti ha rilevato inoltre l'esigenza di una difesa della tipicità dei prodotti agricoli, troppe volte penalizzati sui mercati.
Ai lavori è intervenuto anche Pino La Rocca, responsabile Cia dei rapporti con la grande distribuzione, mercati e consumatori, che ha svolto una relazione che di seguito riportiamo.
Negli ultimi tempi si fa un gran parlare di tracciabilità, rintracciabilità, di sicurezza alimentare, di qualità, di sistemi di qualità, di prodotti certificati, di autocertificazioni, ecc.
Non sempre a proposito e con cognizione di causa, visto che non sono solo gli addetti ai lavori a parlarne, questi termini sono divenuti comunque di uso comune ed il loro entrare nella vita di tutti i giorni dimostra come ci sia un bisogno ed una richiesta di prodotti alimentari con requisiti che vanno oltre i tradizionali canoni di bontà.
Le norme dell'UE e le leggi nazionali disciplinano le procedure e dettano obblighi comportamentali per determinare la sicurezza alimentare che è un pre-requisito comunque atteso dal consumatore negli alimenti; questo della sicurezza possiamo considerarlo un primo aspetto della qualità , quello che attiene ad una qualità igienico-sanitaria, che garantisce l'assenza di residui chimici o di sostanze proibite, che assicuri l'igiene.
La qualità, o meglio le qualità, sono invece quell'insieme di azioni e di comportamenti volontari che l'imprenditore mette in opera per qualificare il suo prodotto e per avere una propria visibilità sul mercato; da parte del consumatore la qualità può essere definita come il grado di percezione dei requisiti , impliciti ed espliciti al prodotto, e che sommariamente possono essere indicati in piacere sensoriale, attese nutrizionali e salutistiche, soddisfazione psicologica e culturale, tutela, valori etici ed infine servizi connessi al prodotto.
Sicuramente nel settore agro-alimentare il profilo della qualità è molto complesso proprio perché l'alimentazione rappresenta la base di uno dei diritti fondamentali dell'uomo: il diritto ad una vita sana ed al benessere.
Ritornerò successivamente per approfondire il punto di vista della CIA su una questione, quella della qualità e dei sistemi di qualità, che riteniamo fondamentale per la nostra agricoltura, per svilupparla e per affrontare le sfide che il mercato globale già da ora ci impone.
La situazione della filiera agricola italiana è quanto di più variegato si possa immaginare; ci sono alcuni settori che hanno compiuto passi in avanti negli ultimi anni ed oggi danno tranquillità agli agricoltori, per quanto si sa che non è possibile vivere sugli allori e che bisogna sempre essere pronti ad innovarsi per non essere superati, altri che si stanno movendo nella direzione giusta , altri ancora non riescono a individuare una strategia che consenta loro di guardare al futuro con tranquillità.
Se prendiamo ad esempio il settore vitivinicolo, vediamo che ha subito negli ultimi anni una ristrutturazione profonda che ha tagliato molti rami secchi, che ha inciso molto sia sulla struttura produttiva che su quella di trasformazione, ma che ha raggiunto ormai livelli di competitività impensabili solo qualche decina di anni addietro.
Gli scandali che hanno colpito questo segmento importante della nostra agricoltura negli anni addietro, hanno accelerato un processo di cambiamento che ha messo al primo posto la questione della qualità e ne ha fatto l'elemento vincente di un percorso che partendo dagli impianti dei vigneti, passando per tecniche di coltivazione innovative, migliorando gli impianti e le tecniche di trasformazione fino ad un sistema distributivo moderno, è riuscito a raggiungere l'obiettivo di valorizzare un prodotto che non ha alcun timore riverenziale a confrontarsi con i più agguerriti concorrenti esteri.
La stessa cosa si sta verificando nel settore delle carni dove, dopo la vicenda della BSE , con i consumi azzerati e con il reddito degli allevatori seriamente compromesso, si è ripartiti con dei progetti di qualità che hanno visto premiato l'impegno che il mondo agricolo ha profuso in tema di tracciabilità e di qualità legata al territorio; in un momento in cui bisognava riconquistare la fiducia dei consumatori e dare loro certezze , il nesso tra alimentazione, salute, sicurezza alimentare, tutela ambientale e valorizzazione delle risorse territoriali si è rivelato determinante.
In questi due settori oltre alla scommessa vincente fatta sulla qualità, vi è un ulteriore fattore comune: il processo di ristrutturazione che ha portato inevitabilmente ad una concentrazione del prodotto che di conseguenza ha facilitato l'adozione di sistemi di qualità più avanzati oltre che consentire un più moderno sistema di commercializzazione e la possibilità di acquisire nuovi clienti.
Un discorso a parte merita la filiera ortofrutticola. L'ortofrutta rappresenta una notevole fetta dell'agricoltura italiana: 950.000 aziende tra orticole, frutticole ed agrumarie, una produzione di circa 32 milioni di tonnellate e l'utilizzo di 1,4 milioni di ettari. L'Italia è il primo paese europeo per produzione sia di frutta che di ortaggi nonché per valore aggiunto di tali produzioni; superiamo sia la Spagna che la Francia detenendo una quota di circa il 20% del totale europeo per gli ortaggi e del 31% per la frutta.
Questo dato non trova però corrispondenza nella capacità di essere partner privilegiati di altri paesi per l'esportazione dei nostri prodotti, anzi la nostra bilancia dei pagamenti vede assottigliarsi anno dopo anno il saldo attivo proprio nel settore ortofrutticolo.
Volendo fare una riflessione approfondita non possiamo che partire dalla indiscussa capacità di produrre, a volte anche in condizioni di difficoltà, da parte dell'agricoltura italiana, di ortofrutta di grande qualità.
Le condizioni climatiche, i terreni vocati, alcuni ecotipi che tramandano dei sapori antichi, le innovazioni che hanno saputo sposare le nuove richieste a livello di aspetto del prodotto con la bontà tradizionale, sono fattori che ci vengono riconosciuti ma non sono bastati a farci acquisire un ruolo adeguato nell'esportazione verso i mercati del nord-europa; gli olandesi, i francesi e per ultimo anche gli spagnoli hanno conquistato questi mercati e noi troviamo difficoltà ad inserirci ed acquisire spazi che, pure in teoria, dovrebbero essere alla nostra portata anzi, come detto prima, continuiamo a perdere quote di mercato.
La globalizzazione dei mercati inoltre ci mette in concorrenza con nuovi emergenti paesi produttori che si stanno affermando anche sul piano qualitativo. Tutto ciò ci ha fatto perdere negli ultimi anni, come accennavo prima, una parte del saldo commerciale attivo; da uno studio dell'ISMEA si nota come a fronte di una esportazione di ortaggi pari al 12% ne importiamo per il 9,5% e questo per il primo paese produttore di ortaggi in Europa francamente è un risultato poco brillante.
A mio avviso due sono i principali fattori che impediscono di accrescere le nostre esportazioni:
§ Scarso livello dei sistemi organizzativi e logistici;
§ Frammentazione della base produttiva che impedisce la possibilità di avere un'offerta adeguata alla domanda delle grandi centrali di acquisto, nonché per lo stesso motivo, la possibilità di poter passare a sistemi di qualità che possano avere il gradimento dei mercati di riferimento.
La conferma la si può trovare in un altro studio ISMEA che riporta un'indagine svolta in alcuni Paesi europei con interviste ai responsabili della grande distribuzione organizzata, importatori e buyer. Ne esce fuori un quadro non certamente positivo per quanto riguarda i fornitori italiani che perdono il confronto con i colleghi olandesi, francesi e spagnoli soprattutto per l'organizzazione, il servizio, il pakaging ed il rispetto dei contratti di fornitura, il tutto mentre viene, dagli stessi intervistati, ribadito il primato italiano nella qualità associata al sapore oltre che alla notevole varietà ed alla tipicità dei prodotti stessi.
Anche la mancanza di una adeguata concentrazione del prodotto e quindi la possibilità di poter effettuare la fornitura con regolarità è vista come un elemento negativo. Del resto la produzione ortofrutticola italiana organizzata nelle varie forme, non rappresenta più del 25% e questa condizione oltre ad impedire la possibilità di porsi come interlocutore credibile nei confronti dei clienti esteri, impedisce anche di acquisire rapidamente, ed in tempo utile, i mutamenti della domanda e quindi di poter programmare utilmente le colture ed i propri investimenti.
La riforma dell'OCM, che doveva dare un impulso al settore con una valorizzazione delle OP, non ha raggiunto, almeno in Italia, completamente l'obiettivo che doveva e deve essere quello di aggregare il più possibile il prodotto. Il limite posto dal regolamento europeo di fatto consente di costituire in quasi tutta l'Italia una OP con un fatturato pari a 3 miliardi delle vecchie lire: non è certo l'esempio di un'aggregazione che possa affrontare i problemi dell'ortofrutta in maniera determinante e risolutiva. Credo che si possa e si debba andare ad una modifica del regolamento aprendo la porta anche al mondo degli imprenditori commerciali, ponendo ovviamente dei limiti che impediscano a quest'ultimi di acquisire il governo della società, in modo da poter realmente creare organismi associativi di dimensioni tali da essere in grado di dare guida ed indirizzi a questo settore che deve necessariamente unire alle indiscusse capacità produttive dimostrate finora, un'affermazione nella commercializzazione globale tale da toglierlo da una precarietà che mortifica l'impegno e la passione dei produttori. Questo significa pensare a nuovi soggetti che operino esclusivamente per affermare i prodotti sul mercato, che in questo progetto investino risorse proprie e contemporaneamente ricerchino eventuali risorse pubbliche; soggetti che siano veramente utili agli agricoltori , che si occupino di prodotto e non di carte che elaborino strategie e progetti per la difesa e la valorizzazione delle produzioni di qualità e non siano ulteriori strutture burocratiche che pesino sui produttori.
Se questo si verificherà sarà più facile parlare di sistemi di qualità che possono essere adottati da una parte consistente della produzione agroalimentare italiana. Oggi 1/3 del fatturato dell'industria alimentare italiana risponde comunque ad una qualità codificata evidenziando come non sia impossibile potenziare i sistemi di qualità e renderli adeguati a politiche commerciali che trovino penetrazione e successo tra i consumatori.
I produttori spesso sono frenati dall'intraprendere politiche di questo genere perché è indubbio che la qualità costa, costa produrla, costa certificarla, costa veicolarla e spesso non viene adeguatamente remunerata. Le ragioni di ciò possono essere molteplici ma derivano tutte dalla poca forza contrattuale che gli agricoltori hanno nei confronti degli altri soggetti della filiera agricola. Un'indagine di Nomisma ci dice che i 3/4 dei consumatori italiani sono disposti a spendere il 10% in più per l'acquisto di un prodotto che abbia dei requisiti qualitativi maggiori di quello tradizionale; più del 50% è disposto a spendere un 20% in più sempre per produzioni di qualità ed 1/4 addirittura il 50% in più. Vi è quindi un ampio bacino di utenza che è orientato verso dei prodotti che abbiano dei requisiti, ovviamente certificati, di qualità a patto che questa possa essere percepita e riconosciuta al di là della certificazione.
Perché allora, visto le peculiarità delle nostre produzioni, si incontrano numerose difficoltà a giungere alla certificazione di prodotto? Perché la qualità costa e spesso l'agricoltore non riesce a farsela pagare.
Le produzioni di qualità rappresentano, a mio avviso, una grande opportunità per l'agricoltura italiana; occorre però che l'intera filiera stabilisca regole condivise e che ciascuno poi rispetti i patti.
Poiché il consumatore paga solo se percepisce la qualità e molto dipende dalle strategie commerciali, dal marchio e dalla capacità di mandare un messaggio che venga recepito; il mondo agricolo, in alcuni settori e per alcuni prodotti, pur lavorando per ottenere una qualità riconosciuta, non ricava nulla in più rispetto al prodotto tradizionale perché il valore aggiunto rimane ad esclusivo vantaggio dell'anello commerciale della filiera. Posso citare casi di aziende che preferiscono vendere il loro prodotto biologico come tradizionale perché almeno risparmiano il costo della certificazione. Ovviamente sono casi limite ma esistono e debbono indurre ad una seria riflessione.
Queste difficoltà non possono e non debbono fermare il lavoro di tanti che hanno scommesso su processi ed orientamenti che vanno nella direzione di affrontare il mercato puntanto non solo sulla salubrità dei prodotti, ma anche su una qualità "sensoriale"; i consumatori infatti hanno diritto ad avere sempre prodotti sani e garantiti, ma hanno lo stesso il diritto di cercare e trovare prodotti diversi che rispondono alle proprie personali attese. Il primo diritto deve essere garantito dalla legge e per i produttori rappresenta un obbligo; il secondo è invece una grande opportunità: interpretando e rispondendo alle richieste dei consumatori, il produttore trova i valori e la soddisfazione economica del proprio agire. E' ovvio che questa seconda qualità pur se volontaria, una volta scelta, deve rispettare norme e percorsi certi.
Questo concetto lo troviamo anche sul tema della tracciabilità, così come previsto dal regolamento CE 178/2002, cioè sulla capacità di individuare o ricostruire la storia di un alimento mediante l'identificazione dei flussi materiali, delle fasi produttive e degli operatori della filiera. L'impostazione comunitaria, riconoscendo l'enorme variabilità e complessità delle filiera agroalimentare, non detta norme prescrittive, ma ne fissa i principi, lasciando liberi i produttori di adottare i sistemi di rintracciabilità più idonei, purchè efficaci e documentati.
Quante sono le strategie di qualità che si possono praticare nel settore agroalimentare? Certamente sono molte e possono divenire addirittura un problema se non si rivedono visioni e logiche di riferimento ormai superate.
Ci sono strategie legate alla vendita diretta degli agricoltori a consumatori locali, con i quali si instaurano spesso relazioni di conoscenza ed amicizia; molte aziende raggiungono livelli di assoluta eccellenza. Si tratta di una tipologia da non sottovalutare perché fornisce livelli di reddito molto soddisfacenti per molti imprenditori, ma neanche da enfatizzare perché rappresenta comunque un segmento limitato di imprese.
Vi sono strategie legate alla vendita di prodotto tipico trasformato e confezionato a negozi particolari, a ristoranti e catene specializzate. E' un segmento in forte evoluzione: prodotti tradizionali, strade del vino, strade di prodotti tipici, gastronomia di nicchia. In ogni caso vi è una forte identità territoriale; si tratta qui di valorizzare, con marchi garantiti, un esteso patrimonio di saperi perfezionati nel tempo e di tecnologie adattate a specifici ambiti locali. Un grande ruolo, trattandosi di prodotti che debbono essere tutelati da denominazioni registrate a livello comunitario, è demandato ai consorzi di tutela che debbono pianificare efficaci programmi di azione.
Per le strategie legate al comparto dell'ortofrutta e della carne appare molto appropriata la certificazione volontaria di prodotto. Sono certificazioni fondata su disciplinari che indicano l'origine, il controllo dei residui, la conformità varietale, la ricchezza di elementi nutritivi, l'uso delle tecniche di agricoltura integrata che valorizzano il territorio e l'ambiente.
Se tralasciamo i prodotti di nicchia, la strategia del mondo agricolo deve essere finalizzata a migliorare le relazioni intersettoriali e a ricercare il reciproco beneficio tra tutti i soggetti della filiera; occorre quindi, prima di tutto, che le imprese agricole si associno ed attraverso questi organismi associativi implementino i sistemi di gestione per la qualità con il risultato di ridurre i costi dei controlli di filiera ed aumentare il potere contrattuale.
Oggi la globalizzazione ha indotto ad elaborare strategie che sembravano impossibili pensare solo dieci anni fa; ci si è reso conto che nessun produttore singolo, che nessuna struttura associativa esistente può rinchiudersi in se stessa e pensare di poter affrontare il mercato con le sole proprie forze. Sono sempre più numerose le iniziative che vedono più soggetti della filiera associarsi per meglio affrontare, con progetti mirati, un futuro dove si corre il rischio di essere schiacciati tra la GDO e le grandi marche internazionali.
Nei mesi scorsi aziende tra loro concorrenti si sono unite in progetti che mirano a creare una concentrazione di prodotto tale da poter competere a livello internazionale con organizzazioni che hanno una lunga tradizione associativa. A Fondi è stata creata COMITALY, una SpA, che promossa dall'Ente Gestore del Centro Agroalimentare di Fondi, vede la partecipazione della locale Camera di Commercio e di 40 operatori del mercato tra grossisti, commissionari e cooperative agricole. Questa società con un capitale di 2 milioni di Euro si propone appunto di riuscire dove le singole imprese, pur significative, non sono arrivate: aggregare una produzione che consenta di realizzare volumi tali da poter consentire una pianificazione non solo commerciale ma che interessi tutta la filiera. Si tratta di coordinare strategie di programmazione delle produzioni con attenzione alle specie ed alle varietà, della definizione di processi di qualità aziendali e di prodotto, di passare da un individualismo atavico ad un concetto di sinergia che abbassa i costi, apre nuovi scenari prima preclusi e in definitiva produce un reddito maggiore. L'obiettivo dichiarato è quello dell'internazionalizzazione dell'ortofrutta italiana mediante creazione di piattaforme distributive in ambito europeo. Un analoga iniziativa è stata varata anche da 27 aziende che hanno creato Mediterranean Fruit Company, società consortile che partendo dalle stesse esigenze si propone di creare le condizioni per sviluppare, a favore delle imprese socie, attività commerciale all'estero.Tra i soci vi sono realtà già molto significative a livello nazionale come Apofruit e questo conferma che la necessità di creare nuove aggregazioni è un sentito comune e che nessuno in questo settore ed in questo momento può dormire sugli allori.
Sono progetti ambiziosi e di grande profilo che puntano:
§ A gestire grandi quantità di prodotto
§ A fare una politica di marchio unico che identifichi l'intera gamma della produzione ortofrutticola commercializzata dalla società
§ Ad ottenere produzioni di elevato standard qualitativo
§ Ad un sistema logistico adeguato con un packaging che sia all'altezza delle produzioni commercializzate
§ Ad una gestione della qualità mediante l'applicazione di rigidi manuali che prevedano dei disciplinari di produzione integrata, controlli di filiera e tracciabilità
§ Infine un ufficio commerciale che sappia tradurre in contratti vantaggiosi tutto questo impegno
Non è una scommessa facile e occorre che non ci si aspetti di vedere da subito i risultati di tanto impegno. Il percorso non è semplice ed occorre investire anche molte risorse, umane ed economiche. L'alternativa è di continuare a perdere di competitività nei mercati esteri e di dover subire anche sui nostri mercati la concorrenza di produzioni provenienti da paesi comunitari e non.
Non credo che questi processi possono comunque essere lasciati soltanto a singole iniziative, occorre che tutti i soggetti che a vario titolo attengono al settore agroalimentare si adoperino perché ci sia una adesione convinta a queste strategie; la difesa della nostra agricoltura passa anche attraverso la promozione dei nostri prodotti e questa può essere effettuata, da una parte incentivando le politiche di qualità volontaria e dall'altra mettendo a disposizione, da parte degli enti competenti, strumenti e risorse finalizzati allo scopo.
Volendo sintetizzare per punti si può affermare:
- che sempre maggiori sono le motivazioni che inducono i vari soggetti della filiera agricola a creare aggregazioni per poter competere nel mercato globale;
- che queste aggregazioni sono costruite su progetti di sviluppo che tengono conto, per ciascun anello della filiera, delle condizioni esistenti e delle potenzialità in prospettiva. Il progetto tenderà a collocare la nuova impresa in un contesto più ampio che apre prospettive di maggior soddisfazione economica;
- che il mercato è oggi dominato dalla GDO e dalle grandi marche; è ovvio che il mondo agricolo deve cambiare le proprie strategie ed attrezzarsi per non essere schiacciato dalle politiche commerciali di questi soggetti;
- che uno degli elementi che può giocare a suo favore è la gestione della qualità; non lasciare cioè che della qualità da esso prodotta ci sia un'appropriazione da parte di altri soggetti: appropriazione di immagine, di fidelizzazione del cliente, di ritorno economico;
- che non vi è una sola qualità, ma esse sono molteplici come numerose sono le certificazioni possibili;
- che esiste una qualità di base senza la quale il prodotto non ha mercato, penso ovviamente a quella che chiamiamo salubrità del prodotto o qualità sanitaria;
- che esiste una buona percentuale di consumatori che sono disposti a pagare per una qualità riconosciuta e riconoscibile;
- che i costi per produrre la qualità possono essere ampiamente recuperati a condizione di essere soggetti con potere contrattuale nei confronti della distribuzione;
- che la qualità ha bisogno di essere percepita dal consumatore e quindi, dopo averla progettata, realizzata, occorre anche pubblicizzarla e renderla identificabile;
- che i marchi commerciali che identificano prodotti di qualità debbono essere il più possibile in mano ai produttori;
- che bisogna investire quindi, non solo nel realizzare progetti di qualità ma anche per pubblicizzarla;
- che i soggetti in grado di realizzare tutto ciò sono preferibilmente società in grado di vedere al loro interno la partecipazione di più soggetti: la produzione, i servizi (dal packaging alla logistica a quelli finanziari ecc.), la commercializzazione e perché no, anche la ricerca e la sperimentazione.
Questo incontro, così interessante e ben organizzato, è stato ideato tra l'altro dall'associazione dei direttori di mercato, e prima di concludere voglio accennare brevemente al ruolo che i nuovi Centri Agroalimentari possono svolgere in questo ambito.
Non possiamo nascondere che la crisi che negli ultimi anni ha colpito il settore ortofrutticolo si riverbera anche nei mercati all'ingrosso. Le difficoltà hanno determinato processi di ristrutturazione nel settore, le aziende più piccole tendono ad essere espulse dal sistema e vediamo che lo scenario si modifica rapidamente.
Il calo dei consumi ortofrutticoli, l'Ismea ha parlato per lo scorso anno del 10%, è comunque un dato oggettivo e non contestabile; le ragioni sono molteplici: la dinamica dei prezzi, le abitudini alimentari, l'arretratezza a volte del sistema distributivo e così via.
Io credo che i Centri Agroalimentari o mercati all'ingrosso, se ci piace di più chiamarli ancora in questo modo, hanno un ruolo importante, di stimolo e di indirizzo, da giocare in questo momento e su questi problemi. Coinvolgere gli operatori di mercato sugli scenari che si stanno aprendo nel panorama internazionale, prevedere addirittura dei seminari per discutere sui temi dell'internazionalizzazione, dei processi e dei mutamenti in atto, potrà servire a far avanzare il livello di comprensione di un fenomeno che prima o poi interesserà tutti noi.
Anche nella gestione dei servizi di mercato si dovrà mettere più attenzione verso questi aspetti con la creazione, dove non esistono, o con il potenziamento se già esistenti, degli uffici qualità che non debbono servire solo a reprimere ma anche ad indirizzare ed orientare.
La creazione, dove possibile, di laboratori di analisi all'interno dei mercati è utile soprattutto per incentivare una politica di attenzione verso i consumatori e serve anche a dare un'immagine diversa di un mondo che, spesso a torto, è identificato come poco sensibile a questioni di grande impatto sociale.
Posso portare a testimonianza della bontà delle cose sopra accennate l'esempio del C.A.A. di Fondi dove tutto ciò è stato realizzato e dove quotidianamente si lavora su queste problematiche. Non siamo un'isola felice, anche da noi si verificano le difficoltà che tutti conoscete, ma con costanza, superando i mugugni di chi è refrattario all'innovazione, pian piano si sta modificando una situazione che poteva sembrare statica; come vi dicevo, abbiamo promosso la costituzione di una società che tende a conquistare nuovi mercati e che ha messo in primo piano la questione della qualità e su questo ci crede a tal punto che tutte le aziende socie si sono impegnate ad intraprendere la strada della certificazione di sistema oltre che prevedere la certificazione di alcuni dei più significativi prodotti commercializzati.
Il futuro ci dirà se raggiungeremo l'obiettivo prefissato, certo è che non si può stare fermi mentre tutto, intorno a noi, si muove e cambia rapidamente.
<a name=_msocom_1></a>