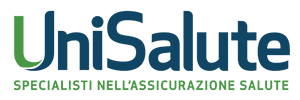17 Febbraio 2005
La qualità come fattore di competitività
Archivio
Condividi
Il successo delle produzioni agroalimentari di qualità rappresenta un punto di forza dell'agricoltura italiana; più in generale, in un mondo sempre più globalizzato, la scelta della qualità, su cui la Cia insiste da tempo, è, per la nostra agricoltura, la scelta obbligata e vincente.
Questa scelta non nasce solo dalla difficoltà, per le imprese, di competere sul fronte dei costi, ma anche dal crescente ruolo dei consumatori nel sistema economico e dalla centralità che le tematiche della salute e del benessere dei cittadini hanno giustamente assunto nelle valutazioni e nelle scelte private e pubbliche.
In questo contesto è quindi centrale non solo il rapporto tra agricoltori e consumatori, ma anche il legame, che diviene sempre più evidente, tra agricoltura e qualità della vita dei cittadini, dal punto di vista igienico-sanitario, della qualità dell'alimentazione e della qualità dell'ambiente.
La qualità agroalimentare è l'elemento che crea un nesso forte tra sviluppo del mondo produttivo e crescita del benessere dei cittadini.
La qualità quindi non va intesa come un fatto limitato, confinato in nicchie di mercato o in situazioni di eccellenza; essa va invece considerata come tratto distintivo di un sistema al quale ogni operatore contribuisce nell'affermazione di marchi legati all'origine e ad altri tratti distintivi di identità e nella costruzione di filiere di qualità differenziate sia per processo che per prodotto.
La strategia della qualità deve riuscire a coniugare efficacemente il rispetto per la tradizione produttiva con lo sviluppo dell'innovazione attraverso adeguate strategie di marketing, di comunicazione e di organizzazione.
Sono molteplici le strategie ed i percorsi della qualità: è importante che essi possano dialogare tra loro sulla base di un linguaggio comune, ma essere distinti ed aderenti alle varie esigenze delle imprese agricole e delle loro proprie strategie aziendali.
La gamma e la complessità dei profili di qualità di un alimento permettono inoltre a diverse strategie di coesistere nello stesso territorio, nelle stesse filiere, nelle stesse aziende; si tratta di una ricchezza di opportunità offerta alle imprese ed ai sistema agricoli territoriali.
Le principali strategie di valorizzazione della qualità legata al territorio percorrono la strada delle denominazioni di origine registrate e tutelate a livello comunitario: le Dop e le Igp. L'importanza di queste strategie è nota, ma sono note anche le difficoltà che molte denominazioni incontrano prima di essere attivate, commercializzate e valorizzate.
Nell'ultimo periodo vi è stata una forte crescita di riconoscimenti di denominazioni a marchio Dop ed Igp italiane, che hanno raggiunto quota 148, consentendo così al nostro Paese di collocarsi in testa alla graduatoria europea davanti alla Francia.
Dati Ismea riferiti al 2003 attribuiscono alle Dop ed Igp un giro d'affari di oltre il 10% della produzione ai prezzi di base dell'agricoltura italiana, percentuale che è invece del 6,3% se si considera solo il valore della produzione direttamente imputabile all'attività agricola. E' un settore inoltre caratterizzato da una forte concentrazione della produzione e dei fatturati: solo i primi 10 prodotti (tutti appartenenti ai comparti dei formaggi e delle preparazioni a base di carne) rappresentano una quota dell'89,6% del fatturato al consumo dell'intero settore.
Il quadro normativo di tale comparto si sta completando, con il decreto legislativo 297 del 19.11.2004, che ha definito l'aspetto sanzionatorio, e, precedentemente, con il regolamento CE 692/03 (modifica del reg. CE 2081/92) che ha rafforzato gli strumenti di tutela delle denominazioni ed indicazioni geografiche estendendo tra l'altro, in condizioni di reciprocità, la tutela delle denominazioni di origine anche ai paesi terzi.
Ma quella delle Dop ed Igp (ed Stg, come la mozzarella) non è l'unica strada percorribile; ci sono - anche se riguardano un segmento limitato di imprese italiane - le strategie legate alla vendita diretta degli agricoltori, negli agriturismi, a consumatori locali o a soggetti qualificati (ristoranti, catene specializzate).
Questi canali possono interessare particolarmente i prodotti tradizionali (introdotti dal decreto legislativo 173/98).
Anche le produzioni biologiche, a tal proposito, risultano essere molto valorizzate in questi segmenti, in special modo attraverso il canale delle mense scolastiche, che distribuiscono ormai 920 mila pasti biologici al giorno in circa 600 mense. Se consideriamo che questo segmento di consumo è stato da sempre alimentato da produzioni indistinte, ci possiamo rendere conto di quale potenziale esso rappresenti per le produzioni di qualità.
Insomma è un mondo in evoluzione: prodotti tradizionali, strade del vino o del prodotto tipico, mense scolastiche, gastronomia specializzata; è una tipologia da non trascurare.
Ci sono poi le strategie legate ai prodotti, sia freschi che trasformati, della filiera agricolo-distributiva ed agricolo-industriale, con sistemi di tracciabilità, di qualità di prodotto e di visibilità della filiera, tali da permettere l'individuazione del produttore o dell'area di produzione e la garanzia di specifici requisiti predefiniti.
Anche per queste produzioni, pur con modalità diverse da quelle del prodotto tipico, la qualità legata al territorio rappresenta una strategia di successo; non solo, ma – in relazione al livello di competitività raggiunto con la globalizzazione dei mercati – l'assicurazione di standard definiti di qualità risulta ormai indispensabile per poter innestare politiche di valorizzazione commerciale dei prodotti.
Tra i più importanti fattori da valorizzare infatti vi sono:
- l'origine, la tracciabilità delle materie prime e la visibilità della filiera, che rappresentano elementi di rassicurazione per i consumatori e fattori di preferenza;
- la relazione tra origine e dieta mediterranea;
- la logistica ed i servizi;
- l'ecocompatibilità dei processi.
All'interno di questa tipologia poi, un caso particolare, di rilevante interesse – anche in considerazione del numero di aziende interessate e delle superfici dedicate (oltre un milione di ettari) - è dato dai prodotti ottenuti con metodi biologici; i dati ISMEA fissano nel 2003 il valore delle produzioni biologiche direttamente imputabili alle attività di sola coltivazione, ad una percentuale del 3,2% del totale delle produzioni vegetali per un valore di 886 milioni di Euro, al quale va aggiunto il valore del latte commercializzato (unico prodotto zootecnico per il quale è stato finora possibile il calcolo) che porta la produzione complessiva ad 1,02 Miliardi di Euro.
La particolare vocazione del nostro Paese (per le condizioni pedoclimatiche che lo distinguono), alla produzione biologica di molte colture e allevamenti di pregio, la particolare perizia dei nostri agricoltori, possono fare del biologico italiano un punto di forza notevole per la nostra agricoltura di qualità..
La diffusione di opinioni favorevoli al biologico tra i cittadini e tra la classe politica e dirigente del nostro Paese, rappresentano senz'altro un punto di forza del settore.
Le forti sinergie con qualità e multifunzionalità, le valenze ambientali universalmente riconosciute al biologico sono un altro punto di forza che andrà necessariamente valorizzato nei prossimi programmi di Sviluppo Rurale.
Inoltre le strategie di valorizzazione della qualità legata all'origine o ai processi produttivi non escludono, anzi possono essere in sinergia con quelle legate all'affermazione di marchi commerciali.
E' comunque necessario che l'intero processo di filiera sia valorizzato, a partire dal prodotto agricolo che ne è la base, e la cui qualità rende la marca competitiva.
E' quindi necessario che nella pianificazione della qualità il mondo agricolo agisca da protagonista.
L'autodeterminazione e la partecipazione degli agricoltori sono fondamentali non solo perché mantengono una quota del valore aggiunto della qualità nel settore primario, ma anche perché valorizzano l'indotto e favoriscono lo sviluppo rurale.
Senza la partecipazione del mondo agricolo alla pianificazione della qualità si rischia di avere una sorta di qualità senza sviluppo.
Negli ultimi anni si è sviluppato un ampio dibattito sul tema della tracciabilità, cioè sulla capacità di individuare o ricostruire la storia di un alimento mediante l'identificazione dei flussi materiali, delle fasi produttive e degli operatori della filiera.
Il regolamento CE 178/2002 ha introdotto, a partire dall'inizio dell'anno in corso, l'obbligatorietà della rintracciabilità ai fini igienico-sanitari. L'impostazione comunitaria, riconoscendo l'enorme variabilità e complessità delle filiere agricolo-alimentari, non detta norme prescrittive, ma ne fissa i principi, lasciando liberi i produttori di adottare i sistemi di rintracciabilità più idonei, purchè efficaci e documentati.
I sistemi di tracciabilità possono avere però anche altri valori. Essi sono necessari per l'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima e per qualsiasi strategia della qualità garantita, obiettivi che la Cia, non da oggi, persegue attivamente.
Vanno quindi favorite ed incentivate esperienze di tracciabilità, proposte ed attivate volontariamente dalle filiere organizzate o da loro pezzi, che partano comunque dal prodotto agricolo e finalizzate alla sicurezza degli alimenti, al diritto di informazione del consumatore, alla valorizzazione dell'origine e delle caratteristiche qualitative delle produzioni, allo stimolo verso migliori performance aziendali nei fattori chiave dell'organizzazione, del lavoro e dell'innovazione tecnologica.
Ma sopra tutto è necessaria l'autodeterminazione dell'imprenditore agricolo, la cui adesione a progetti di tracciabilità e di percorsi di qualità garantita deve essere convinta e finalizzata.
La rintracciabilità deve essere, oltre che essere percepita, come una opportunità in più nella strada della valorizzazione della qualità.
La risposta alla domanda di sicurezza del prodotto alimentare può quindi diventare la molla per una crescita organizzativa dell'impresa che miri a trarre, nel mercato, vantaggio competitivo da una maggiore consapevolezza dei suoi punti di forza qualitativi.
La sfida della qualità si deve però basare su interprofessioni credibili e su un sistema economico agricolo organizzato in cui i produttori siano protagonisti e primi responsabili.
A tale proposito, per la Cia, è necessario che:
- Il mondo agricolo deve essere protagonista nello sforzo di promuovere l'associazionismo dei produttori, finalizzato a far crescere associazioni che acquisiscano un effettivo controllo del prodotto ed un forte orientamento al mercato, e che svolgano un ruolo di interfaccia tra aziende agricole e settori economici a valle.
La collocazione di un prodotto all'industria deve infatti avvenire su specifiche contrattuali che siano predefinite, e che al tempo stesso siano conformi alle reali produzioni sul campo; produzioni che a loro volta devono evolvere in funzione delle effettive esigenze di mercato.
I contratti, nelle politiche di qualità, assumono quindi un ruolo determinante e rappresentano dei riferimenti essenziali per la definizione dei sistemi qualità. Essi devono definire le principali specifiche di prodotto, i servizi connessi ai prodotti e quelli di tipo logistico, alcuni eventuali elementi relativi ai controlli, le responsabilità, la gestione delle non conformità.
- Contratti così complessi difficilmente possono essere stipulati se non come atti specifici all'interno di un contesto generale di regole e principi fissati da grandi accordi interprofessionali.
Per la Cia quindi riveste carattere prioritario la necessità di far crescere le relazioni interprofessionali e gli accordi di filiera. In tale contesto trovano collocazione la costituzione o il rafforzamento di organismi interprofessionali.
- Altro punto essenziale, per la Cia, è il rafforzamento del sistema delle Dop – Igp. I Consorzi di tutela, di cui va confermata la centralità nel sistema di gestione di questi prodotti, devono però avere un effettivo carattere interprofessionale, poiché la gestione delle Dop ed Igp non può che essere di filiera, anche se le scelte organizzative possono variare in funzione della tipologia di prodotto ed alle caratteristiche del distretto produttivo.
Per la Cia quindi va garantita negli organi dei consorzi la presenza paritaria di tutte le rappresentanze della filiera; la capacità di una Dop o Igp di affermarsi sul mercato dipende in gran parte proprio dalla capacità di aggregare i diversi soggetti della filiera e di concentrare il maggior quantitativo di prodotto possibile.
In questo contesto vanno promossi sostenuti accordi e progetti di filiera nell'ambito dei Consorzi.
Inoltre, per la Cia, va superata la logica che impone un solo Consorzio per prodotto a denominazione, in quanto questo diviene spesso un ostacolo alla concentrazione di una massa critica di prodotti, che è la condizione per poter innescare una reale valorizzazione dei prodotti stessi sia sui mercati nazionali che su quelli internazionali.
- La Cia ritiene prioritaria la crescita di servizi che orientino e sostengano le imprese agricole nella scelta di strategie di qualità. Queste infatti se a volte richiedono una "riscoperta" di prodotti e tecniche tradizionali, sempre però sicuramente richiedono all'impresa agricola di adottare moderne procedure organizzative, gestionali e relazionali, di tracciabilità, di controllo, di garanzia, di certificazione e di marketing.
In questo senso inoltre la Cia ritiene necessaria l'incentivazione, da parte del pubblico, di sistemi premiali a sostegno dell'intrapresa di strategie volontarie della qualità da parte degli agricoltori.
- E' importante potenziare e razionalizzare il sistema di certificazione ed accreditamento, favorendo ed accelerando la creazione dell'ente unico di accreditamento, partecipato da tutti i ministeri interessati e dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale.
La razionalizzazione del sistema di accreditamento e certificazione dovrà puntare alla qualificazione degli operatori, all'efficienza organizzativa ed alla riduzione dei costi delle imprese.
- Affinché la qualità diventi fattore certo di competizione, è infine necessario che essa sia percepita dal cittadino-consumatore; a tale proposito lo sviluppo del mercato dei prodotti di qualità non può prescindere da programmi continui e mirati di comunicazione e informazione. Particolari progetti dovranno essere indirizzati al mondo della scuola e ai decisori di acquisto delle famiglie e degli acquisti collettivi.
Il successo delle produzioni agroalimentari di qualità rappresenta un punto di forza dell'agricoltura italiana; più in generale, in un mondo sempre più globalizzato, la scelta della qualità, su cui la Cia insiste da tempo, è, per la nostra agricoltura, la scelta obbligata e vincente.
Questa scelta non nasce solo dalla difficoltà, per le imprese, di competere sul fronte dei costi, ma anche dal crescente ruolo dei consumatori nel sistema economico e dalla centralità che le tematiche della salute e del benessere dei cittadini hanno giustamente assunto nelle valutazioni e nelle scelte private e pubbliche.
In questo contesto è quindi centrale non solo il rapporto tra agricoltori e consumatori, ma anche il legame, che diviene sempre più evidente, tra agricoltura e qualità della vita dei cittadini, dal punto di vista igienico-sanitario, della qualità dell'alimentazione e della qualità dell'ambiente.
La qualità agroalimentare è l'elemento che crea un nesso forte tra sviluppo del mondo produttivo e crescita del benessere dei cittadini.
La qualità quindi non va intesa come un fatto limitato, confinato in nicchie di mercato o in situazioni di eccellenza; essa va invece considerata come tratto distintivo di un sistema al quale ogni operatore contribuisce nell'affermazione di marchi legati all'origine e ad altri tratti distintivi di identità e nella costruzione di filiere di qualità differenziate sia per processo che per prodotto.
La strategia della qualità deve riuscire a coniugare efficacemente il rispetto per la tradizione produttiva con lo sviluppo dell'innovazione attraverso adeguate strategie di marketing, di comunicazione e di organizzazione.
Sono molteplici le strategie ed i percorsi della qualità: è importante che essi possano dialogare tra loro sulla base di un linguaggio comune, ma essere distinti ed aderenti alle varie esigenze delle imprese agricole e delle loro proprie strategie aziendali.
La gamma e la complessità dei profili di qualità di un alimento permettono inoltre a diverse strategie di coesistere nello stesso territorio, nelle stesse filiere, nelle stesse aziende; si tratta di una ricchezza di opportunità offerta alle imprese ed ai sistema agricoli territoriali.
Le principali strategie di valorizzazione della qualità legata al territorio percorrono la strada delle denominazioni di origine registrate e tutelate a livello comunitario: le Dop e le Igp. L'importanza di queste strategie è nota, ma sono note anche le difficoltà che molte denominazioni incontrano prima di essere attivate, commercializzate e valorizzate.
Nell'ultimo periodo vi è stata una forte crescita di riconoscimenti di denominazioni a marchio Dop ed Igp italiane, che hanno raggiunto quota 148, consentendo così al nostro Paese di collocarsi in testa alla graduatoria europea davanti alla Francia.
Dati Ismea riferiti al 2003 attribuiscono alle Dop ed Igp un giro d'affari di oltre il 10% della produzione ai prezzi di base dell'agricoltura italiana, percentuale che è invece del 6,3% se si considera solo il valore della produzione direttamente imputabile all'attività agricola. E' un settore inoltre caratterizzato da una forte concentrazione della produzione e dei fatturati: solo i primi 10 prodotti (tutti appartenenti ai comparti dei formaggi e delle preparazioni a base di carne) rappresentano una quota dell'89,6% del fatturato al consumo dell'intero settore.
Il quadro normativo di tale comparto si sta completando, con il decreto legislativo 297 del 19.11.2004, che ha definito l'aspetto sanzionatorio, e, precedentemente, con il regolamento CE 692/03 (modifica del reg. CE 2081/92) che ha rafforzato gli strumenti di tutela delle denominazioni ed indicazioni geografiche estendendo tra l'altro, in condizioni di reciprocità, la tutela delle denominazioni di origine anche ai paesi terzi.
Ma quella delle Dop ed Igp (ed Stg, come la mozzarella) non è l'unica strada percorribile; ci sono - anche se riguardano un segmento limitato di imprese italiane - le strategie legate alla vendita diretta degli agricoltori, negli agriturismi, a consumatori locali o a soggetti qualificati (ristoranti, catene specializzate).
Questi canali possono interessare particolarmente i prodotti tradizionali (introdotti dal decreto legislativo 173/98).
Anche le produzioni biologiche, a tal proposito, risultano essere molto valorizzate in questi segmenti, in special modo attraverso il canale delle mense scolastiche, che distribuiscono ormai 920 mila pasti biologici al giorno in circa 600 mense. Se consideriamo che questo segmento di consumo è stato da sempre alimentato da produzioni indistinte, ci possiamo rendere conto di quale potenziale esso rappresenti per le produzioni di qualità.
Insomma è un mondo in evoluzione: prodotti tradizionali, strade del vino o del prodotto tipico, mense scolastiche, gastronomia specializzata; è una tipologia da non trascurare.
Ci sono poi le strategie legate ai prodotti, sia freschi che trasformati, della filiera agricolo-distributiva ed agricolo-industriale, con sistemi di tracciabilità, di qualità di prodotto e di visibilità della filiera, tali da permettere l'individuazione del produttore o dell'area di produzione e la garanzia di specifici requisiti predefiniti.
Anche per queste produzioni, pur con modalità diverse da quelle del prodotto tipico, la qualità legata al territorio rappresenta una strategia di successo; non solo, ma – in relazione al livello di competitività raggiunto con la globalizzazione dei mercati – l'assicurazione di standard definiti di qualità risulta ormai indispensabile per poter innestare politiche di valorizzazione commerciale dei prodotti.
Tra i più importanti fattori da valorizzare infatti vi sono:
- l'origine, la tracciabilità delle materie prime e la visibilità della filiera, che rappresentano elementi di rassicurazione per i consumatori e fattori di preferenza;
- la relazione tra origine e dieta mediterranea;
- la logistica ed i servizi;
- l'ecocompatibilità dei processi.
All'interno di questa tipologia poi, un caso particolare, di rilevante interesse – anche in considerazione del numero di aziende interessate e delle superfici dedicate (oltre un milione di ettari) - è dato dai prodotti ottenuti con metodi biologici; i dati ISMEA fissano nel 2003 il valore delle produzioni biologiche direttamente imputabili alle attività di sola coltivazione, ad una percentuale del 3,2% del totale delle produzioni vegetali per un valore di 886 milioni di Euro, al quale va aggiunto il valore del latte commercializzato (unico prodotto zootecnico per il quale è stato finora possibile il calcolo) che porta la produzione complessiva ad 1,02 Miliardi di Euro.
La particolare vocazione del nostro Paese (per le condizioni pedoclimatiche che lo distinguono), alla produzione biologica di molte colture e allevamenti di pregio, la particolare perizia dei nostri agricoltori, possono fare del biologico italiano un punto di forza notevole per la nostra agricoltura di qualità..
La diffusione di opinioni favorevoli al biologico tra i cittadini e tra la classe politica e dirigente del nostro Paese, rappresentano senz'altro un punto di forza del settore.
Le forti sinergie con qualità e multifunzionalità, le valenze ambientali universalmente riconosciute al biologico sono un altro punto di forza che andrà necessariamente valorizzato nei prossimi programmi di Sviluppo Rurale.
Inoltre le strategie di valorizzazione della qualità legata all'origine o ai processi produttivi non escludono, anzi possono essere in sinergia con quelle legate all'affermazione di marchi commerciali.
E' comunque necessario che l'intero processo di filiera sia valorizzato, a partire dal prodotto agricolo che ne è la base, e la cui qualità rende la marca competitiva.
E' quindi necessario che nella pianificazione della qualità il mondo agricolo agisca da protagonista.
L'autodeterminazione e la partecipazione degli agricoltori sono fondamentali non solo perché mantengono una quota del valore aggiunto della qualità nel settore primario, ma anche perché valorizzano l'indotto e favoriscono lo sviluppo rurale.
Senza la partecipazione del mondo agricolo alla pianificazione della qualità si rischia di avere una sorta di qualità senza sviluppo.
Negli ultimi anni si è sviluppato un ampio dibattito sul tema della tracciabilità, cioè sulla capacità di individuare o ricostruire la storia di un alimento mediante l'identificazione dei flussi materiali, delle fasi produttive e degli operatori della filiera.
Il regolamento CE 178/2002 ha introdotto, a partire dall'inizio dell'anno in corso, l'obbligatorietà della rintracciabilità ai fini igienico-sanitari. L'impostazione comunitaria, riconoscendo l'enorme variabilità e complessità delle filiere agricolo-alimentari, non detta norme prescrittive, ma ne fissa i principi, lasciando liberi i produttori di adottare i sistemi di rintracciabilità più idonei, purchè efficaci e documentati.
I sistemi di tracciabilità possono avere però anche altri valori. Essi sono necessari per l'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima e per qualsiasi strategia della qualità garantita, obiettivi che la Cia, non da oggi, persegue attivamente.
Vanno quindi favorite ed incentivate esperienze di tracciabilità, proposte ed attivate volontariamente dalle filiere organizzate o da loro pezzi, che partano comunque dal prodotto agricolo e finalizzate alla sicurezza degli alimenti, al diritto di informazione del consumatore, alla valorizzazione dell'origine e delle caratteristiche qualitative delle produzioni, allo stimolo verso migliori performance aziendali nei fattori chiave dell'organizzazione, del lavoro e dell'innovazione tecnologica.
Ma sopra tutto è necessaria l'autodeterminazione dell'imprenditore agricolo, la cui adesione a progetti di tracciabilità e di percorsi di qualità garantita deve essere convinta e finalizzata.
La rintracciabilità deve essere, oltre che essere percepita, come una opportunità in più nella strada della valorizzazione della qualità.
La risposta alla domanda di sicurezza del prodotto alimentare può quindi diventare la molla per una crescita organizzativa dell'impresa che miri a trarre, nel mercato, vantaggio competitivo da una maggiore consapevolezza dei suoi punti di forza qualitativi.
La sfida della qualità si deve però basare su interprofessioni credibili e su un sistema economico agricolo organizzato in cui i produttori siano protagonisti e primi responsabili.
A tale proposito, per la Cia, è necessario che:
- Il mondo agricolo deve essere protagonista nello sforzo di promuovere l'associazionismo dei produttori, finalizzato a far crescere associazioni che acquisiscano un effettivo controllo del prodotto ed un forte orientamento al mercato, e che svolgano un ruolo di interfaccia tra aziende agricole e settori economici a valle.
La collocazione di un prodotto all'industria deve infatti avvenire su specifiche contrattuali che siano predefinite, e che al tempo stesso siano conformi alle reali produzioni sul campo; produzioni che a loro volta devono evolvere in funzione delle effettive esigenze di mercato.
I contratti, nelle politiche di qualità, assumono quindi un ruolo determinante e rappresentano dei riferimenti essenziali per la definizione dei sistemi qualità. Essi devono definire le principali specifiche di prodotto, i servizi connessi ai prodotti e quelli di tipo logistico, alcuni eventuali elementi relativi ai controlli, le responsabilità, la gestione delle non conformità.
- Contratti così complessi difficilmente possono essere stipulati se non come atti specifici all'interno di un contesto generale di regole e principi fissati da grandi accordi interprofessionali.
Per la Cia quindi riveste carattere prioritario la necessità di far crescere le relazioni interprofessionali e gli accordi di filiera. In tale contesto trovano collocazione la costituzione o il rafforzamento di organismi interprofessionali.
- Altro punto essenziale, per la Cia, è il rafforzamento del sistema delle Dop – Igp. I Consorzi di tutela, di cui va confermata la centralità nel sistema di gestione di questi prodotti, devono però avere un effettivo carattere interprofessionale, poiché la gestione delle Dop ed Igp non può che essere di filiera, anche se le scelte organizzative possono variare in funzione della tipologia di prodotto ed alle caratteristiche del distretto produttivo.
Per la Cia quindi va garantita negli organi dei consorzi la presenza paritaria di tutte le rappresentanze della filiera; la capacità di una Dop o Igp di affermarsi sul mercato dipende in gran parte proprio dalla capacità di aggregare i diversi soggetti della filiera e di concentrare il maggior quantitativo di prodotto possibile.
In questo contesto vanno promossi sostenuti accordi e progetti di filiera nell'ambito dei Consorzi.
Inoltre, per la Cia, va superata la logica che impone un solo Consorzio per prodotto a denominazione, in quanto questo diviene spesso un ostacolo alla concentrazione di una massa critica di prodotti, che è la condizione per poter innescare una reale valorizzazione dei prodotti stessi sia sui mercati nazionali che su quelli internazionali.
- La Cia ritiene prioritaria la crescita di servizi che orientino e sostengano le imprese agricole nella scelta di strategie di qualità. Queste infatti se a volte richiedono una "riscoperta" di prodotti e tecniche tradizionali, sempre però sicuramente richiedono all'impresa agricola di adottare moderne procedure organizzative, gestionali e relazionali, di tracciabilità, di controllo, di garanzia, di certificazione e di marketing.
In questo senso inoltre la Cia ritiene necessaria l'incentivazione, da parte del pubblico, di sistemi premiali a sostegno dell'intrapresa di strategie volontarie della qualità da parte degli agricoltori.
- E' importante potenziare e razionalizzare il sistema di certificazione ed accreditamento, favorendo ed accelerando la creazione dell'ente unico di accreditamento, partecipato da tutti i ministeri interessati e dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale.
La razionalizzazione del sistema di accreditamento e certificazione dovrà puntare alla qualificazione degli operatori, all'efficienza organizzativa ed alla riduzione dei costi delle imprese.
- Affinché la qualità diventi fattore certo di competizione, è infine necessario che essa sia percepita dal cittadino-consumatore; a tale proposito lo sviluppo del mercato dei prodotti di qualità non può prescindere da programmi continui e mirati di comunicazione e informazione. Particolari progetti dovranno essere indirizzati al mondo della scuola e ai decisori di acquisto delle famiglie e degli acquisti collettivi.