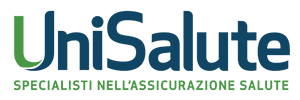15 Giugno 2005
Assemblea nazionale: un nuovo Patto tra agricoltura e società
Archivio
Condividi
Premessa
I paesi dell'Unione europea celebrano, nel 2005, 60 anni consecutivi di pace. Il primo obiettivo dei fondatori è stato realizzato. È un fatto straordinario. L'Europa si pone, oggi, l'obiettivo di diventare, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.
Cogliamo un legame tra questi due avvenimenti, soprattutto oggi che la frattura tra la realtà e le visioni dell'Europa si è ampliata. L'agricoltura, con le regole della PAC che hanno anticipato l'idea del mercato e della moneta unica, ha rappresentato un laboratorio per la costruzione dell'Europa, entità politica ed economica insieme.
La nostra dimensione è l'Europa. L'economia globale ha bisogno d'istituzioni e di regole condivise. Misuriamo oggi quanto grande è ancora la distanza tra i processi di globalizzazione e le istituzioni sopranazionali che sono chiamate a governarla. I risultati dei referendum in Francia ed in Olanda sul Trattato costituzionale europeo hanno portato allo scoperto sia il malessere e la sfiducia di vasti strati di popolazione verso le istituzioni dell'Unione europea ed il processo d'integrazione, sia il malcontento verso i governi nazionali e la loro incapacità di affrontare i nodi della situazione economica e sociale e dell'immigrazione. Hanno fatto emergere il dilemma tra identità nazionali, molto forti e faticosamente costruite, ed un'identità europea ancora tutta da conquistare e realizzare. Per milioni di persone, l'Europa non è ancora considerata un'istituzione a loro vicina; ciò soprattutto a causa di un'inadeguata democratizzazione delle strutture. L'Europa non è esente dalla crisi di democrazia rappresentativa che investe tutti i paesi occidentali, alle prese con un mondo sempre più globale e sempre meno regolato. E' prevalsa la concezione di un'Europa come mercato, sostanzialmente incapace di raccogliere le inquietudini dei suoi cittadini, e contemporaneamente protesa ad un allargamento che l'ha, progressivamente, resa ingestibile.
Il progetto europeo ha subito una battuta d'arresto, ma sbagliano coloro che, per antico scetticismo o, peggio, per calcolo opportunistico, leggono in ciò la fine dell'idea di Europa politica ed il fallimento di tutto ciò che è stato fatto lungo quella strada, a partire dall'istituzione della moneta unica, l'euro. Sbaglia, soprattutto, chi persevera nell'attribuire all'Europa le colpe delle proprie inefficienze e dell'incapacità di varare le riforme strutturali necessarie per recuperare la perdita di competitività del nostro sistema produttivo.
L'unica strada percorribile, ora, è continuare il processo di ratifica. In questa posizione di coerenza, l'Italia ha una grande responsabilità, la stessa che, dopo la crisi del 1954, con il veto della Francia alla Comunità Europea di Difesa, la spinse ad ospitare la Conferenza di Messina che portò, nel 1957, alla firma del Trattato istitutivo della CEE. Una cosa è certa: un'Unione europea ferma al Trattato di Nizza, con la PESC quale massima espressione di politica estera, e con l'attuale assetto istituzionale, di fatto, rinuncerebbe a giocare un ruolo significativo, sia nelle relazioni transatlantiche, sia nello scenario internazionale. Sarebbe la vera sconfitta del progetto di costruzione di un'Europa utile ai cittadini, perché sarebbe ancora più difficile garantire i livelli di benessere e sicurezza che gli Stati nazionali sono sempre meno in grado di assicurare da soli.
L'Europa non deve rimanere paralizzata dalle sue paure. Essa deve affrontare con decisione, e con successo, i temi principali che ha di fronte. L'attuazione delle strategie definite dai Consigli di Lisbona e di Goteborg per la crescita e lo sviluppo sostenibile attraverso la cooperazione tra istituzioni nazionali e comunitarie, e le decisioni sulle prospettive finanziarie dell'Unione fino al 2013 saranno il banco di prova della credibilità delle istituzioni europee. Una soluzione di basso profilo, che portasse ad una riduzione dei finanziamenti per la coesione e gli investimenti per la competitività, avrebbe, come immediato effetto, un'ulteriore caduta del consenso all'Europa. Proporre la riduzione della spesa europea vuol dire, infatti, proporre di ridurre gli ambiti d'intervento dell'Unione; vuol dire minare tutto ciò che è stato costruito attorno al progetto di Costituzione europea.
È interesse dell'agricoltura e dell'Italia mantenere il tetto di spesa delle risorse per l'Unione e rafforzare le competenze comunitarie. Ciò potrà contribuire sia all'adeguamento del nostro potenziale d'innovazione, sia alla crescita delle regioni in ritardo di sviluppo.
È su questo tema che s'impone la massima chiarezza. Anche per questo confermiamo la nostra contrarietà all'ipotesi di parziale rinazionalizzazione della spesa agricola. Questa scelta accentuerebbe gli squilibri all'interno dell'Unione e la condizione di precarietà delle risorse finanziarie a disposizione dell'agricoltura. Abbiamo condiviso l'impostazione della riforma della PAC perché favorisce l'orientamento dell'agricoltura al mercato, ne abbiamo criticato i limiti, il consolidamento degli squilibri e le ancora scarse risorse destinate allo sviluppo rurale. Vogliamo che la PAC contribuisca sempre più e meglio a realizzare gli obiettivi di crescita dell'Unione europea: destinare quote degli aiuti a sostegno dei comportamenti e delle azioni orientati all'innovazione è il modo migliore e più efficace per difendere la PAC.
L'agricoltura assume la responsabilità, grande, di contribuire a costruire l'Europa come soggetto politico e, insieme, strumento che promuova lo sviluppo, offra maggiori garanzie di sicurezza ai cittadini, porti ad una reale modernizzazione dell'economia, riduca le sacche di povertà ed emarginazione dalle quali anche il nostro Paese non è esente.
L'agricoltura ha soddisfatto una quota significativa della domanda interna; oggi non esistono più barriere geo-politiche ai flussi di prodotti agricoli. L'agricoltura ha contribuito a porre un freno ai fenomeni incontrollati dell'esodo e dell'urbanizzazione; oggi costituisce un'occasione per migliaia di lavoratori dell'Est Europa e del Nord Africa. Nel quadro delle relazioni e della divisione internazionale del lavoro, l'agricoltura, nelle economie sviluppate, ha obiettivamente perso ruolo e peso nella composizione del prodotto interno lordo. L'agricoltura è stata considerata per un lungo periodo arma strategica nel conflitto tra Est ed Ovest del mondo; oggi è strumento per contribuire alla crescita del Sud del mondo. Nelle economie sviluppate, proiettate al terziario avanzato, una forte agricoltura, produttiva e competitiva, si affianca ai settori produttivi ad elevata tecnologia.
In questa dinamica collochiamo la proposta del nuovo Patto. La collochiamo con l'orgoglio di un settore che rivendica e assume una "responsabilità storica" di fronte alla collettività.
Abbiamo di fronte due principali interlocutori: le persone, che utilizzano i beni ed i servizi che l'agricoltura produce, alle quali ci lega l'antico Patto di lealtà; le istituzioni di governo e della rappresentanza, con le quali poniamo l'obiettivo di realizzare migliori livelli di benessere senza peggiorare la condizione di nessuno.
Poiché nulla è più come prima, anche i caratteri della nostra responsabilità mutano. Da quanto detto emerge ciò di cui parliamo:
- perché un Patto: la situazione dell'economia chiede a tutti un'assunzione di responsabilità su obiettivi condivisi per accrescere la competitività delle imprese e per il rilancio dello sviluppo;
- perché nuovo: sono mutati gli scenari e le condizioni di competitività;
- perché con la società: si rivolge all'insieme delle istituzioni di governo e della rappresentanza sociale e d'interessi.
Esso è rivolto in primo luogo ai cittadini, e non di meno alle istituzioni ed alle altre rappresentanze d'imprese e dei lavoratori. Ai cittadini, ai quali proponiamo un'agricoltura che pone la responsabilità etica tra le condizioni di successo, capace di soddisfare la domanda alimentare, di tutelare l'ambiente ed il territorio, di offrire prospettive di lavoro qualificato ai giovani. Alle rappresentanze delle imprese, per dare continuità alle intese raggiunte con i due documenti sul Mezzogiorno e sul rilancio dell'economia sottoscritti alla fine dello scorso anno. Al Governo, perché rispetti e dia continuità e contenuto agli impegni assunti al Forum di Parma ed al Tavolo agroalimentare del 2001, al Tavolo sulla previdenza agricola. Alle Regioni perché traducano le loro primarie competenze in materia di agricoltura in progetti per accrescere la competitività delle imprese, puntando sulla diffusione delle innovazioni, sulla formazione e sulla consulenza aziendale, sui servizi alle imprese e sul rafforzamento delle organizzazioni economiche degli agricoltori. Alle organizzazioni sindacali, perché il successo dell'agricoltura deriva anche dalla capacità di contribuire ad innalzare il benessere sociale. La proposta di Patto si rivolge alle rappresentanze agricole in Italia ed in Europa, perché riteniamo sia possibile e necessario trovare, nel rispetto delle identità, ed anche delle diversità d'idee, significative posizioni comuni su obiettivi di interesse per le imprese agricole.
L'antico Patto
Negli ultimi quindici anni del secolo scorso si è chiuso un ciclo storico per l'agricoltura europea. Si è esaurito l'antico Patto che aveva delineato la missione dell'agricoltura nel secondo dopoguerra: aumentare la produttività per rispondere al fabbisogno alimentare; essere strumento di coesione sociale nelle aree rurali; sostenere lo sviluppo attraverso un aumento della domanda di mezzi tecnici. Questa missione è stata favorita e sostenuta dalle politiche nazionali (la riforma fondiaria, il regime di contribuzione, i piani verdi e la legge quadrifoglio) e comunitarie (la PAC ed i negoziati GATT, nei due aspetti: sostegno del mercato interno ed elevato protezionismo). Quella fase ha registrato indubbi successi per l'agricoltura italiana ed europea. L'Unione europea è diventata il primo esportatore mondiale di prodotti agricoli. L'agricoltura europea non è fatta solo di commodities che competono nel mondo con la forza della quantità e dei prezzi, ma vanta, l'Italia in particolare, un giacimento di prodotti di qualità che non ha eguali nel mondo. Le imprese agricole hanno raggiunto elevati livelli di efficienza e produttività che, in molti casi, compensano i vincoli strutturali, dalla dimensione fondiaria alla limitata dotazione di capitali.
L'antico Patto ha anche evidenziato limiti. Non si è risolto il problema del riequilibrio territoriale (Nord-Sud, città-campagna, zone interne e marginali, di montagna e di pianura). Non sono stati colti in tempo i segnali dell'apertura dei mercati; atteggiamenti di chiusura protezionistica hanno negativamente condizionato le politiche, i comportamenti degli agricoltori, la stessa "credibilità" dell'agricoltura. Le politiche dei prezzi e dei mercati hanno sostenuto, per le principali commodities, aumenti di produzione ben oltre i fisiologici incrementi legati alle innovazioni tecnologiche. Ciò ha avuto, come effetto indesiderato, in taluni casi, un negativo impatto sull'ambiente, dovuto all'eccessivo apporto di prodotti chimici ed alle pratiche di monocoltura estensiva. Permangono squilibri tra settori e tra aree. I finanziamenti della PAC hanno privilegiato le regioni e le produzioni del Nord Europa. I differenziali di reddito e le condizioni sociali e civili nelle campagne rappresentano freni allo sviluppo. È mancata una politica nazionale capace di superare i punti di debolezza della nostra agricoltura (dalla questione fondiaria e generazionale, all'assenza di economie di rete), di valorizzarne i punti di forza (a partire dal valore delle produzioni di qualità), di sostenere il rafforzamento delle strutture aziendali.
Le imprese, nei settori meno tutelati dall'ombrello protettivo della PAC, affrontano ora la crescente concorrenza in condizioni obiettivamente più difficili.
Nella fase di cambiamento, che è durata circa venti anni, possiamo affermare con orgoglio che la Confederazione italiana agricoltori ha intuito le nuove esigenze della società europea ed i cambiamenti dello scenario internazionale. La parola d'ordine "dalla protezione alla competizione"; il deciso "no" alle quote fisiche alla produzione, sostenuto con la Marcialonga di Bruxelles; la scelta della qualità, "produrre meglio, produrre meno", sono il segno di un'organizzazione che ha saputo cogliere le novità ed avanzare conseguenti proposte in campo economico e sociale, a partire dalle tesi delle Conferenze sull'impresa, sui servizi e sulla competitività.
I cambiamenti e dunque i motivi del nuovo Patto
La liberalizzazione dei mercati ed i negoziati commerciali in sede WTO, l'emergere di nuovi protagonisti della produzione e del commercio mondiale, la diminuzione dei costi di trasporto e delle comunicazioni, le nuove tecnologie proposte dall'ingegneria genetica e dalla società dell'informazione ci hanno posto di fronte ad un processo di analoga intensità di quelli che diedero origine alle economie nazionali. Non abbiamo, tuttavia, un governo mondiale, responsabile di fronte ai cittadini, capace di sovrintendere al processo di globalizzazione con la stessa autorità con la quale gli stati nazione governano le rispettive economie. Abbiamo, in sostanza, una governance globale senza un governo globale.
Cambia la dimensione del "conflitto" in agricoltura: dalla questione fondiaria e dei contratti agrari ai rapporti di forza nelle filiere agroalimentari. Oggi, anche come effetto della liberalizzazione dei mercati, la competizione si dilata dalle filiere ai sistemi territoriali. In una situazione di accresciuta concorrenza, nella quale spesso prevale la competizione di costo, le filiere non riescono a produrre sufficiente ricchezza per tutti. I soggetti più forti (ieri l'industria alimentare, oggi sempre più la grande distribuzione) riescono a mantenere inalterati i margini di accumulazione trasferendo sull'agricoltura condizioni contrattuali (prezzi, termini di pagamento, costi logistici) particolarmente onerose che provocano l'erosione dei redditi degli agricoltori e riducono la loro capacità d'investire. Il risultato è che il vantaggio relativo di una parte si traduce in uno svantaggio per alcuni e per la collettività nel suo insieme.
Il sottosviluppo in molte aree del mondo frena il progresso dell'economia mondiale. La povertà non è solo carenza di risorse, ma ostacoli all'accesso ai benefici dello sviluppo. I meccanismi di sviluppo, avviati da alcuni paesi nel secondo dopoguerra, non sono stati capaci di innescare un equilibrato e generalizzato progresso nei paesi più poveri. Essi rischiano, considerata la scarsità di risorse naturali (a partire dall'acqua) e la fragilità degli ecosistemi, di aggravare le condizioni ambientali. Lo sviluppo del terzo mondo favorirà il processo d'integrazione delle economie, la globalizzazione dei mercati, il miglioramento delle relazioni internazionali e diventerà lo strumento principale di benessere e di pace. L'Italia agricola assume un ruolo importante per la sua collocazione geografica nei flussi di traffico tra l'Est e l'Ovest del mondo, per la consolidata storia di relazioni con i paesi della sponda meridionale ed orientale del mare Mediterraneo, per la somiglianza delle specializzazioni colturali, per la comune domanda di ricerca agronomica, per il comune obiettivo di creare una massa critica di prodotto per rispondere alla domanda dei paesi ad elevato reddito.
I consumatori, anche grazie all'aumento del benessere, sono più sensibili ai temi dell'ambiente, della salubrità, della qualità e della varietà degli alimenti. La qualità e la tipicità, il rispetto dell'ambiente, la tutela del paesaggio, l'etica della produzione assumono un peso sempre più rilevante nelle strategie d'impresa e diventano obiettivi delle politiche.
L'agricoltura, oggi, corrisponde solo in parte a questi cambiamenti. Essa, certamente, risponde alle "nuove sensibilità" della società. Non risponde in modo adeguato ai nuovi scenari della competitività, facendo registrare preoccupanti esempi di redditività negativa in molti comparti produttivi. Per anni l'ambiente intorno all'agricoltura è cambiato lentamente, permettendo agli agricoltori di adattarsi progressivamente; poi, all'improvviso, il cambiamento ha assunto velocità inimmaginabile, ponendo gli agricoltori nella condizione di inseguire i cambiamenti. Da qui derivano le incertezze ed il diffuso malessere nelle campagne.
Nel dopoguerra, le politiche hanno accompagnato e sostenuto la missione dell'agricoltura. L'opinione pubblica aveva una chiara percezione dei termini del problema. Oggi ciò non avviene con altrettanta linearità. Non vi è coerenza tra ciò che la società chiede all'agricoltura e ciò che la società fa perché l'agricoltura sia messa nelle condizioni di corrispondere alla domanda sociale.
Si diversifica la destinazione d'uso della terra, dall'attività agricola agli insediamenti industriali ed urbani, all'attività turistica e ricreativa, al mero investimento. Il patrimonio fondiario si contrae con l'allargamento dei centri urbani. Questa tendenza contrasta con la "ruralità efficiente e viva" che esprime valori sia produttivi, sia sociali ed ambientali. La rappresentanza agricola ed i Governi locali devono interloquire con l'obiettivo di difendere la destinazione agricola del territorio, riconoscendo le finalità produttive e di sviluppo delle aree rurali. Si ampliano gli interessi sul bene fondiario, con l'effetto di incrementarne i valori a livello insostenibile per chi si dedica all'attività agricola. Il costo della terra, in proprietà o in affitto, deve essere congruo rispetto ai benefici che provengono dall'attività produttiva e dal contesto territoriale.
Il mercato globale porta sulle tavole alimenti provenienti da ogni parte del mondo ed in ogni stagione. Le tecnologie offrono alimenti elaborati nei quali viene sempre meno l'identità del prodotto agricolo da cui originano. Nell'immaginario collettivo aumenta la distanza tra il cibo e la produzione agricola. L'uso improprio di marchi consolidati è, sempre più, forma di concorrenza sleale; ancora troppo debole è l'impegno per la definizione di norme internazionali di tutela delle denominazioni di origine.
In questa globalizzazione, che rende il prodotto agricolo sempre meno distinguibile nelle sue caratteristiche e nella sua origine, e rende l'impresa agricola sempre più sottoposta alla concorrenza, l'agricoltura è chiamata a rivendicare il suo ruolo nell'economia, ed il suo peso nelle strategie e nelle politiche di sviluppo. Essa, dunque, ridisegna la propria identità, che è fatta, principalmente, di insediamenti, cioè di persone e di luoghi. Nelle economie sviluppate il valore dell'agricoltura produttiva, non mera testimonianza storica, custode della tradizione e del paesaggio agrario, non si misura solo come componente del PIL, ma nella capacità di trasformare la ricchezza del prodotto agricolo, con la sua storia, la sua tradizione, la sua cultura, in una leva strategica che consenta agli agricoltori di mantenere elevati livelli di benessere, soddisfacendo bisogni collettivi.
Ecco i motivi del nuovo Patto: ricollocare l'agricoltura nelle dinamiche dello sviluppo; allineare missione dell'impresa agricola e politiche; proporre le imprese agricole come parte attiva di un sistema di relazioni a tutto campo, economiche, sociali, istituzionali.
Il Patto si sostanzia, da un lato, con la capacità dell'agricoltura di agire in un mercato concorrenziale, ponendo la responsabilità etica come componente della propria reputazione; dall'altro, con il riconoscimento del contributo dell'agricoltura al benessere sociale nella sua accezione più ampia: qualità della vita, biodiversità, ambiente, paesaggio.
Evidenziamo un nesso forte tra il Patto, il progetto e le politiche: il Patto vale perché è sostenuto da un progetto di agricoltura e perché propone politiche e comportamenti coerenti con tale progetto.
Poniamo in evidenza quattro aspetti:
- la dimensione delle politiche che si collocano nelle sedi internazionali delle relazioni e degli accordi multilaterali, nell'Unione europea, nello Stato, nelle Regioni e nel sistema delle autonomie locali;
- gli obiettivi delle politiche: migliorare le condizioni di redditività e sostenere le imprese nella sfida del mercato, creare un ambiente favorevole all'attività d'impresa;
- i riscontri delle politiche nei prossimi mesi: il DPEF, la legge finanziaria, la programmazione dello Sviluppo rurale, il programma nazionale di attuazione della strategia di Lisbona;
- le priorità:
- l'organizzazione economica: l'associazionismo economico, le relazioni di filiera, le interprofessioni, la promozione dei prodotti sui mercati, le denominazioni geografiche, i sistemi di qualità;
- l'innovazione ed il capitale umano: la formazione e la consulenza aziendale, la ricerca e la diffusione delle innovazioni, il sostegno dell'imprenditoria giovanile, il riconoscimento del ruolo crescente delle imprenditrici, il sostegno della pluriattività e della diversificazione produttiva, la diffusione di nuovi strumenti finanziari e servizi assicurativi;
- lo stato sociale e le regole: il sistema fiscale, previdenziale e contributivo, la sussidiarietà orizzontale e la semplificazione amministrativa;
le infrastrutture: il sistema irriguo, le direttrici di traffico, le reti di comunicazione, cioè l'insieme delle opere che qualificano il territorio e lo rendono fruibile alle attività economiche ed agli insediamenti umani.
I contenuti del Patto
Alla base del nuovo Patto poniamo un progetto di agricoltura:
- basata sull'impresa professionale;
- relazionale;
- motore dello sviluppo delle aree rurali.
Agricoltura basata sull'impresa professionale
Questo concetto sottende alcuni caratteri.
L'impresa diffusa sul territorio. Non è solo una questione di localizzazione. L'impresa agricola entra in relazione con soggetti ed istituzioni che operano in un territorio sempre più vasto. Essa si avvale delle conoscenze e dei valori presenti nel contesto rurale, ed è sempre più condizionata dall'ambiente che la circonda: dai fornitori di servizi al sistema delle reti (la viabilità e le comunicazioni) e della conoscenza (le istituzioni di ricerca, di formazione e di diffusione delle innovazioni), al sistema produttivo (le imprese della filiera). Un prodotto agricolo tipico porta con sé un pezzo della storia e della cultura del territorio che l'ha generato. Qui si colloca la "cultura del distretto" rurale, come luogo nel quale si realizzano processi innovativi che mettono insieme le capacità degli imprenditori locali e le conoscenze che provengono dall'ambiente esterno. Alla base del distretto vi sono processi spontanei di sviluppo che pongono il problema del coordinamento e del governo del processo di trasformazione. Una risposta è la creazione di "istituzioni intermedie" che, come espressione degli attori locali, s'inseriscono tra l'impresa ed il mercato e si candidano a svolgere una funzione di autogoverno dello sviluppo.
L'etica d'impresa come strategia di successo e non solo come vincolo. La reputazione nel mercato, la fiducia dei consumatori, la trasparenza dei processi produttivi costituiscono una componente importante del valore economico dell'impresa e del suo vantaggio competitivo. Qui si colloca il tema delicato: noi e gli organismi geneticamente modificati. Il dibattito che si è aperto in Italia ha trovato linfa nella diffusa domanda di sicurezza alimentare. Confermiamo il nostro impegno a centrare la nostra azione sui seguenti capisaldi: produzioni di qualità, cioè un'offerta differenziata, con alto contenuto di tradizioni e di servizio; sicurezza alimentare e principio di precauzione, cioè rispetto delle norme e dei principi della salute pubblica, informazione e tracciabilità; certezze per gli agricoltori, cioè regole per la coesistenza e sistema dei controlli, perché gli agricoltori siano messi in grado di programmare gli ordinamenti colturali; tutela della biodiversità e dell'ambiente, cioè recupero e salvaguardia delle varietà tradizionali che rischiano, per difficoltà produttive e di mercato, di scomparire dagli ordinamenti colturali, innovazione delle tecniche produttive orientate, tra l'altro, ad un più razionale uso della chimica; ricerca e diffusione delle innovazioni. Il nostro Paese è stato per lungo tempo all'avanguardia per il miglioramento genetico delle piante coltivate. Le varietà di grano duro uscite dai nostri laboratori di ricerca sono tra le più diffuse. Oggi questo patrimonio di conoscenze rischia di disperdersi. La ricerca deve essere sostenuta ed orientata per dare risposte alle domande che la nostra agricoltura pone: principalmente varietà resistenti ai parassiti ed agli stress termici ed idrici; ridurre la nostra dipendenza dall'estero di materiale genetico. Da qui la richiesta di un piano sementiero nazionale. Ancora una volta, come fu con la rivoluzione verde, i sentieri della ricerca biotecnologica si rivolgono, prevalentemente, a sistemi produttivi che ci sono sostanzialmente estranei. Per questo, consideriamo che gli ogm non servano alla nostra agricoltura.
La diversificazione delle attività e delle forme giuridiche. La nuova versione dell'articolo 2135 del codice civile prende atto che l'impresa agricola è un insieme di professionalità e specializzazioni, cioè un'istituzione in grado di valorizzare l'apporto economico e la capacità professionale dell'insieme dei soggetti che "vivono sotto lo stesso tetto". Pensiamo ai giovani ed alle imprenditrici che trovano nella diversificazione delle attività produttive motivazione e riconoscimento economico al loro lavoro in azienda. In questo quadro gli anziani possono giocare un ruolo significativo: titolari d'attività d'impresa, nelle zone ove maggiore è l'importanza della presenza dell'uomo per salvaguardare il valore storico e paesaggistico; partecipi di progetti di ricomposizione fondiaria nei quali si combinano l'apporto della terra dell'anziano proprietario, l'iniziativa professionale del giovane imprenditore, il capitale dell'istituzione finanziaria, una volta posto il progetto e non solo la garanzia reale alla base delle motivazioni di finanziamento.
L'impresa agricola si diversifica dalla produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli alla fornitura di servizi ad elevato contenuto sociale secondo modelli di gestione basati sulla sussidiarietà (servizi di prossimità, di assistenza domiciliare, di accoglienza e recupero); dallo svolgimento di attività economiche legate alla tutela del territorio e dell'ambiente (produzione di energia da fonti rinnovabili, manutenzione e gestione del patrimonio fondiario pubblico…) alle attività ricreative, a partire dall'accoglienza turistica. Ancora troppi sono, tuttavia, gli ostacoli burocratici che rallentano la diversificazione delle imprese, soprattutto nel caso dell'accesso agli appalti pubblici.
Agricoltura relazionale
L'impresa agricola evolve. L'evoluzione e la modernità dell'impresa non sono solo un fatto tecnico produttivo. Per troppo tempo il settore agricolo è stato costretto a visioni settoriali ed anguste. Bisogna uscire dagli steccati: l'impresa, il settore agricolo e le organizzazioni di rappresentanza debbono divenire protagonisti del sistema di relazioni economiche, politiche, culturali, istituzionali, sociali, nelle quali sono coinvolte. Questa proposta si lega al Patto alla pari del 1986: oggi quel concetto si modifica, si rielabora, non si applica più soltanto lungo la filiera, ma si estende al territorio,
Dobbiamo ragionare e operare in termini di sistema. Progressivamente si allineano i comportamenti, le strategie ed i bisogni delle imprese agricole e quelli dell'insieme delle piccole e medie imprese. I mercati dei prodotti e dei capitali, i rapporti con la pubblica amministrazione ed il sistema dei servizi all'impresa, la logistica, il marketing ecc. sono tutte funzioni comuni del mondo della piccola e media impresa. Questo allineamento delle strategie e delle domande di politiche impone un'azione concertata tra le organizzazioni di rappresentanza dell'agricoltura e degli altri settori nei confronti dei governi sui temi di comune interesse. Il successo del nuovo Patto sta principalmente nella nostra capacità di proporre, costruire e consolidare relazioni.
Le relazioni economiche. L'impresa evolve nelle relazioni di mercato. La nostra agricoltura è caratterizzata da un persistente gap organizzativo, che si traduce in una minore capacità di trattenere quote di reddito. L'inefficienza di talune filiere apre la strada a comportamenti speculativi che portano alla minima trasparenza dei processi di formazione dei prezzi ed alla diffusione di azioni malavitose. Le strade finora percorse si sono mosse nella logica della concentrazione dell'offerta. Essa non è, tuttavia, l'unica forma utile per rafforzare la presenza degli agricoltori sul mercato. Ad essa si affiancano nuove opportunità fondate sulla conoscenza e sui nuovi strumenti informatici di comunicazione e vendita, sulla diffusione dei marchi e dei sistemi di qualità, sull'organizzazione contrattuale, sul potenziamento delle strutture e dei servizi logistici. L'economia diventa più relazionale, è legata a fattori non di mercato, meno governabili con le tradizionali relazioni contrattuali e più basata su condizioni di contesto che favoriscono la cooperazione tra soggetti individuali e collettivi. Quest'evoluzione colloca l'impresa orientata al mercato in un sistema di relazioni nel quale interagiscono soggetti economici, industria di trasformazione e distribuzione, istituzioni scientifiche e di ricerca, con le quali intendiamo progettare la costituzione di poli d'eccellenza per la diffusione delle innovazioni, i soggetti erogatori di servizi, dei quali fa parte il nostro "sistema Cia".
Le relazioni sociali. Qui si collocano i rapporti con le altre rappresentanze d'impresa. Si sono progressivamente allineate le domande di politica del complesso delle piccole imprese. Cambia la dimensione della lobby. Da qui nasce la nostra adesione ai documenti per il rilancio dello sviluppo e sul Mezzogiorno sottoscritti insieme alle rappresentanze d'impresa alla fine dello scorso anno. Con quei documenti abbiamo inteso avviare un percorso comune che mira ad identificare obiettivi e strumenti di un'azione volta ad ottenere risultati concreti e verificabili, nella piena consapevolezza che le nuove sfide chiedono un impegno deciso delle forze sociali e produttive a confrontarsi e lavorare insieme in modo coeso e solidale. Quei documenti rappresentano, per noi, una scelta politica da perseguire con coerenza, e soprattutto da riempire di contenuti. Da questo punto di vista, le intese con le rappresentanze delle imprese sono una necessità finalizzata al successo competitivo del sistema Italia.
Qui si colloca la nostra iniziativa finalizzata a creare le condizioni per sviluppare azioni concertate tra le organizzazioni professionali agricole. Essa è, per noi, una necessità per difendere il valore dell'agricoltura e per rafforzare la capacità d'azione della rappresentanza agricola. Su questo intendiamo misurarci e lavorare per il progresso dell'agricoltura e degl'interessi di cui siamo portatori. Su questi obiettivi chiediamo alle organizzazioni agricole, Coldiretti e Confagricoltura di manifestare la loro disponibilità.
L'esigenza di allargare il fronte della nostra azione deve impegnarci a sviluppare una specifica azione verso la cooperazione e l'associazionismo di prodotto. Il nostro impegno è valorizzare l'esperienza svolta dalla cooperazione e dall'associazionismo ai quali va riconosciuto il merito di avere, pur con storie e forme organizzative diverse, svolto un ruolo positivo per l'agricoltura e la difesa del reddito degli agricoltori. Il nostro impegno a costruire e rafforzare queste esperienze come libera scelta degli agricoltori muove dalla convinzione che esse possono dare risposte ai tanti problemi delle nostre imprese che, in molti casi, non possono essere affrontati singolarmente.
Dobbiamo contribuire a rafforzare la fiducia verso i beni ed i servizi che gli agricoltori producono. Qui si pone il tema delle intese tra gli agricoltori ed i soggetti, dalle associazioni ambientaliste a quelle dei consumatori, che sono, in diversi modi e forme, coinvolti nei temi della tutela della salute e della qualità dei prodotti, della salvaguardia dell'ambiente e della difesa del territorio, della valorizzazione delle comunità rurali, della difesa delle tradizioni e dei giacimenti culturali dei quali le nostre campagne sono ricche.
Le relazioni istituzionali. Cambia lo scenario istituzionale di riferimento. I processi decisionali sono "delocalizzati" verso istituzioni sopranazionali, da un lato, e verso il territorio, le istituzioni regionali e sub-regionali dall'altro. Il processo di decentramento di compiti e funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali e funzionali delinea una nuova architettura istituzionale attorno alla quale si definiranno le strategie d'intervento. Ciò pone un problema di coerenza tra le scelte di politica generale ed i programmi attuati nelle singole Regioni. È una fase delicata ed ancora in transi-zione nella quale, a nuovi livelli di governo, corrisponderanno diversi livelli di partecipazione alle decisioni. È un processo non reversibile rispetto al quale dobbiamo rafforzare la nostra capacità di confronto a tutti i livelli decentrati: il sistema delle autonomie locali e delle relative strutture di rappresentanza, gli enti funzionali (dalle Camere di Commercio agli Enti di bonifica). Siamo convinti che, per promuovere lo sviluppo, siano necessari, da un lato, un'azione della Pubblica amministrazione rinnovata nei contenuti, negli strumenti e nella capacità di agire, coraggiosa nel delineare processi di delegificazione e nello snellimento delle procedure; dall'altro, un rapporto di partecipazione con le rappresentanze degli interessi.
La concertazione negli anni '90 fu, insieme, strumento di coesione, la responsabilità condivisa tra Governo e parti sociali, e sviluppo, il risanamento dei conti pubblici e l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro. La concertazione è stata messa in discussione: l'esecutivo ha dato priorità alla rapidità del processo decisionale rispetto alla ricerca del più largo consenso. Ciò è avvenuto, in particolare, con la legge finanziaria 2005 e con i provvedimenti per la competitività. Questo non è ammissibile quando si definiscono le condizioni e le prospettive di crescita del sistema delle imprese, che è, oggi, l'obiettivo prioritario che ci poniamo come condizione della ripresa economica del Paese. Certo, movimenti politici, governo ed organizzazioni di rappresentanza hanno compiti, responsabilità ed obiettivi diversi. Solo partendo dal riconoscimento di questa diversità, e rispettandola, è possibile un rapporto corretto tra Governo e sistema delle rappresentanze. La concertazione costituisce il metodo più efficace per regolare l'apporto originale ed autonomo delle organizzazioni rappresentative di interessi nella formazione delle scelte di governo.
La concertazione deve essere rilanciata, non come pratica per i periodi difficili, ma come scelta politica alla quale devono essere uniformate le azioni del Governo ed i comportamenti delle Organizzazioni di rappresentanza. Essa deve essere regolata, secondo gli schemi condivisi sul partenariato economico e sociale, per non essere lasciata alla discrezionalità dei governi. L'autonomia e la concertazione rappresentano i pilastri di un corretto rapporto tra istituzioni e organizzazioni professionali agricole.
La scelta della concertazione è finalizzata anche a rimuovere le ricorrenti suggestioni volte a disconoscere le rappresentanze d'interessi quali interpreti diretti degl'interessi di categoria. In una società complessa, il pluralismo dei partiti ed il bilanciamento dei poteri istituzionali non sono sufficienti all'affermazione della democrazia in assenza dell'espressione organizzata degli interessi delle categorie sociali e produttive.
La riforma dello Stato in senso federalista non è solo un mutamento di ruolo o trasferimento di poteri e competenze, ma un'occasione per valorizzare risorse locali e per fare emergere il "protagonismo" degli agricoltori e delle loro rappresentanze. Per questo ribadiamo l'importanza della dimensione locale dello sviluppo e della "programmazione dal basso". Essa parte dal territorio, ma non costruisce sistemi isolati; si fonda sul principio della collaborazione tra le istituzioni e del partenariato con le categorie produttive. Lo stesso procedimento legislativo impone questo collegamento. Per questo devono essere definiti e regolamentati i rapporti tra il Tavolo agroalimentare e la Conferenza tra lo Stato e le Regioni. Le Regioni portano, a loro volta, alla Conferenza degli Assessori, il parere maturato nei rispettivi tavoli di concertazione. Ecco perché non è pensabile un modello di concertazione separato tra il livello nazionale e quello regionale.
Il principio di sussidiarietà deve essere attuato non solo tra i livelli dello Stato, ma anche nei confronti delle rappresentanze sociali. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, così come recita l'articolo 118 della Costituzione, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, Il principio di sussidiarietà deve essere concepito come integrazione tra le attività pubbliche e le iniziative del "privato sociale" al fine di favorire lo sviluppo dell'autodeterminazione del singolo e dei corpi intermedi, dovendo l'attribuzione delle funzioni interessare non solo i vari livelli di governo territoriali, ma anche le autonomie che garantiscono il pluralismo sociale e culturale. La sussidiarietà orizzontale è componente del successo della rappresentanza e dell'azione delle imprese protese alla multifunzionalità ed alla diversificazione. Non è ancora compiutamente diffusa, nel nostro Paese, la cultura della sussidiarietà. Un processo di riforma istituzionale in senso federalista dovrà, quindi, basarsi sui principi inscindibili dell'unità, del decentramento e della partecipazione sociale, dando luogo ad un sistema pluralista di autonomie istituzionali, funzionali, rappresentative sociali.
Agricoltura motore dello sviluppo delle aree rurali
L'attività agricola rappresenta, nei territori rurali, il nucleo intorno al quale si realizzano processi in grado di valorizzare numerose attività economiche del terziario e delle piccole industrie, dall'agriturismo all'artigianato alimentare. Il segno più evidente di questo fenomeno è che il territorio rurale mantiene la sua identità fatta di tradizioni, beni culturali, paesaggio, e la trasforma in opportunità economiche ed in una forza antagonista ai processi di emarginazione.
La vitalità dell'agricoltura e del territorio rurale è, per questo, interesse di tutta la società. Una politica di governo del territorio che ponga attenzione all'economia ed alle comunità rurali è la condizione per promuovere una crescita sostenibile e creare nuove opportunità di lavoro. La vitalità del territorio rurale è essenziale per l'agricoltura, così come l'attività agricola è essenziale per la vitalità del territorio rurale.
Sono, per questo, elemento del Patto le politiche comunitarie, nazionali e regionali finalizzate al superamento degli squilibri e capaci di esaltare la ricchezza sociale e produttiva presente nelle aree rurali. La rarefazione dei servizi, dai centri sanitari, scolastici, culturali, fino agli sportelli bancari, è il fenomeno che prelude alla progressiva emarginazione dei piccoli centri rurali. È necessaria una nuova stagione dei diritti che offra condizioni di pari opportunità a quanti possono dare un positivo contributo allo sviluppo, e sia capace di ricostruire una capacità d'attrazione delle aree rurali.
Le politiche di sviluppo delle aree rurali devono tenere conto delle esigenze specifiche e valorizzare le potenzialità offerte dalle comunità locali. La politica di sviluppo rurale deve essere attuata in collaborazione tra le istituzioni e la società civile, secondo il principio di sussidiarietà. Un banco di prova sarà la definizione del quadro strategico nazionale per la politica di coesione. Particolare rilevanza avranno i documenti strategici regionali e le linee di programma del Mezzogiorno alla cui elaborazione concorreranno le rappresentanze sociali.
Il riconoscimento della multifunzionalità dell'agricoltura è il punto di partenza delle politiche che dovranno dedicare attenzione alle funzioni ambientali dell'impresa agricola (dalle attività di manutenzione del territorio alla produzione energetica da fonti rinnovabili).
Le aziende agricole sono chiamate a nuove responsabilità di fronte alla società: alla domanda di alimenti si aggiungono nuove aspettative, l'occupazione, la qualità e la sicurezza alimentare, la protezione dell'ambiente, un equilibrato sviluppo territoriale. L'agricoltura multifunzionale è la risposta alle nuove aspettative della società: ad essa corrispondono imprese che, contemporaneamente, contribuiscono alla produzione agricola, ma anche alla protezione ed alla riproduzione delle risorse naturali, all'occupazione e ad uno sviluppo equilibrato del territorio. E' una visione dell'agricoltura per la quale la tutela ambientale, l'identificazione dei prodotti, i comportamenti etici non sono considerati vincoli, ma potenziali vantaggi economici per le imprese. In tale contesto dovranno essere riconosciute, anche sotto il profilo giuridico, le aziende operanti nei diversi ambiti della multifunzionalità.
Programmazione territoriale e sussidiarietà sono due leve alla base dello sviluppo locale: ciò significa essenzialmente creare opportunità per le imprese del territorio; favorire la coesione economica e sociale e migliorare la qualità della vita e del lavoro potenziando i servizi che garantiscono le condizioni materiali di base (acqua, luce, telefono) e favorendo l'accesso ai servizi sanitari, assistenziali, scolastici e culturali; promuovere le iniziative volte a ridurre l'effetto periferia di molte aree rurali (collegamenti e reti di comunicazione); favorire le attività produttive presenti sul territorio, attraverso la leva fiscale, ed i servizi alle imprese; valorizzare il ruolo della cultura e delle tradizioni locali come elementi costitutivi dell'identità delle popolazioni rurali.
Nei caratteri descritti sta la "specificità" dell'impresa agricola: diffusa, diversificata, organizzata. Ci interroghiamo sulla dimensione, oggi, della specificità dell'agricoltura e delle imprese agricole nelle politiche nazionali. L'impresa agricola di-spone di una copiosa legislazione speciale, nazionale e comunitaria, in diversi settori, fiscale, previdenziale, assicurativo, ambientale. D'altro canto, il sistema dei sussidi ha impedito o, talora, dissuaso molte aziende agricole dal ricorrere agli strumenti che la legislazione ordinaria ha, negli anni, messo a disposizione delle imprese per promuovere lo sviluppo, la crescita dimensionale, la presenza sul mercato in condizioni di competitività.
I negoziati Wto e le riforme della Pac hanno progressivamente accentuato la logica di mercato e di selezione delle imprese, e dunque ne hanno ridotto la specificità. Progressivamente solo le aziende che avranno capacità professionali ed organizzative sopravvivranno; le altre rischiano di entrare nell'area della marginalità e dell'abbandono. In questo scenario vogliamo caratterizzare la nostra azione per offrire condizioni di pari opportunità a tutti gli imprenditori.
Una politica, con alti contenuti sociali volta a tutelare le aziende deboli, non deve essere considerata alternativa a politiche che introducano nel nostro sistema produttivo forti stimoli competitivi, rispetto ai quali può verificarsi l'arretramento del peggiore, o del meno efficiente. In questo scenario, le aziende giovani, quelle orientate alla qualità ed all'innovazione potrebbero trarre i maggiori vantaggi.
Il nuovo Patto e la condivisione degli agricoltori
Le sfide di oggi hanno bisogno di risposte e di decisioni rapide, coraggiose ed innovative. Il protagonismo degli agricoltori va affermato, costruito e guidato. Il consenso e la partecipazione costituiscono lo spirito stesso di una rappresentanza che dia insieme forza alle scelte e chiarezza nel rapporto con gli associati.
La rappresentanza non è solo la capacità di sostenere, nel rapporto con le istituzioni, le domande degli associati. Essa è, anche, programma e progetti, ed insieme, mandato per la loro attuazione. Ciò vuol dire che un adeguato modello di rappresentanza richiede che le domande, i bisogni e le attese degli associati siano aggregati ed anche tradotti in decisioni: non basta il progetto e la volontà politica per rendere efficace un modello di rappresentanza; sono necessarie le strutture e gli strumenti per realizzare il progetto. Qui si collocano, tra l'altro, l'impegno a promuovere servizi avanzati (nel senso di promuovere il sistema dei servizi della Confederazione Italiana Agricoltori, ma anche favorire l'accesso degli agricoltori ai nuovi servizi) ed il nostro ruolo nella costruzione delle organizzazioni economiche.
Conoscenza, competenza e relazioni sono i modi per declinare il modello della rappresentanza. L'azione sindacale e l'attività di servizi costituiscono i due capisaldi dell'iniziativa delle organizzazioni agricole a tutela degli agricoltori. E', infatti, anche attraverso un sistema dei servizi che abbiano i caratteri della professionalità, della competenza, della puntualità e della tempestività che è possibile rispondere pienamente alle esigenze degli agricoltori.
Dobbiamo porci, con altrettanta attenzione, sia l'obiettivo di creare un servizio efficiente e competitivo, sia creare ed organizzare la domanda, nei settori innovativi, quali, per esempio l'assicurativo o finanziario. Anche questo è parte della proposta di "nuovo Patto". Organizzare, insieme, domanda e offerta di servizi, vuol dire, infatti, considerare come fatto inscindibile la rappresentanza e la capacità di creare un sistema di relazioni (con le istituzioni e con i soggetti che, a vario titolo agiscono nel sistema dei servizi) che è, in ultima analisi, il senso del nuovo Patto.
Considerazione conclusiva
La proposta del "nuovo Patto" impone a tutta la Confederazione Italiana Agricoltori di serrare le file. Tutti dobbiamo operare perché la nostra organizzazione sia più forte e capace di portare a successo la sfida che abbiamo lanciato innanzitutto a noi stessi. La nostra storia, di cui siamo orgogliosi, è un punto fermo per proseguire e guidare la nuova fase che abbiamo aperto, e con essa la crescita dell'agricoltura. Abbiamo l'ambizione di poter contribuire a costruire un nuovo grande capitolo della storia di una Confederazione che rappresenta un inestimabile patrimonio di cui fanno parte i nostri agricoltori, le nostre strutture diffuse nel territorio, le nostre migliaia di tecnici e dirigenti che operano con passione e professionalità, con funzioni e responsabilità diverse.
Abbiamo alle spalle un periodo pieno di difficoltà e problemi, di emergenze e trasformazioni che hanno fatto sentire i loro pesanti effetti sulle imprese e sulla nostra organizzazione. Abbiamo di fronte un periodo nel quale predominano le incertezze e segnato da crescenti pressioni concorrenziali.
Vogliamo un'agricoltura forte e imprese competitive capaci di produrre reddito per gli agricoltori e ricchezza per la nazione: ciò non è possibile senza un progetto ed una rinnovata e credibile politica agraria. Non possiamo affrontare le sfide solo basandoci su misure parziali capaci, nella migliore delle ipotesi, di aiutarci a fronteggiare ricorrenti emergenze. Le sfide si vincono se vi saranno decisioni rapide, coraggiose ed innovative coerenti con un disegno capace di guidare e rilanciare la nostra economia riconoscendo il contributo del settore agricolo.
Cinquanta anni fa, dirigenti contadini ebbero la grande intuizione di dar vita all'Alleanza dei Contadini, forti solo del proprio coraggio e del loro entusiasmo. Fu un evento storico che aveva come obiettivo mettere al centro l'agricoltura e la figura del coltivatore.
Oggi dobbiamo avere quello stesso coraggio ed entusiasmo. Abbiamo nuovamente l'occasione per fare sentire la nostra voce. Guidare il cambiamento, costruire il protagonismo degli agricoltori: questa è la sfida che abbiamo di fronte. È una sfida difficile. Ma dalla consapevolezza della difficoltà esce esaltata la nostra azione. Accettiamo questa sfida con la convinzione di essere all'altezza e di operare con successo e nell'interesse di tutti gli agricoltori. Accettiamo questa sfida con l'ambizione e la caparbietà che ci sono propri, con l'orgoglio di chi opera e crede nella Confederazione Italiana Agricoltori.
Una sfida nella quale dobbiamo trovare il giusto sostegno, non solo da parte della società nel suo complesso, ma anche e soprattutto degli agricoltori che, nonostante i gravi problemi e le difficoltà che affrontano quotidianamente nel loro lavoro, e con pesanti sacrifici, sono certamente in grado di svolgere un ruolo propulsivo. Ad essi ci rivolgiamo prioritariamente per sostenere il Patto, perché hanno grandi capacità, professionalità e risorse per vincere una partita che ormai si presenta in termini decisivi.
Premessa
I paesi dell'Unione europea celebrano, nel 2005, 60 anni consecutivi di pace. Il primo obiettivo dei fondatori è stato realizzato. È un fatto straordinario. L'Europa si pone, oggi, l'obiettivo di diventare, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.
Cogliamo un legame tra questi due avvenimenti, soprattutto oggi che la frattura tra la realtà e le visioni dell'Europa si è ampliata. L'agricoltura, con le regole della PAC che hanno anticipato l'idea del mercato e della moneta unica, ha rappresentato un laboratorio per la costruzione dell'Europa, entità politica ed economica insieme.
La nostra dimensione è l'Europa. L'economia globale ha bisogno d'istituzioni e di regole condivise. Misuriamo oggi quanto grande è ancora la distanza tra i processi di globalizzazione e le istituzioni sopranazionali che sono chiamate a governarla. I risultati dei referendum in Francia ed in Olanda sul Trattato costituzionale europeo hanno portato allo scoperto sia il malessere e la sfiducia di vasti strati di popolazione verso le istituzioni dell'Unione europea ed il processo d'integrazione, sia il malcontento verso i governi nazionali e la loro incapacità di affrontare i nodi della situazione economica e sociale e dell'immigrazione. Hanno fatto emergere il dilemma tra identità nazionali, molto forti e faticosamente costruite, ed un'identità europea ancora tutta da conquistare e realizzare. Per milioni di persone, l'Europa non è ancora considerata un'istituzione a loro vicina; ciò soprattutto a causa di un'inadeguata democratizzazione delle strutture. L'Europa non è esente dalla crisi di democrazia rappresentativa che investe tutti i paesi occidentali, alle prese con un mondo sempre più globale e sempre meno regolato. E' prevalsa la concezione di un'Europa come mercato, sostanzialmente incapace di raccogliere le inquietudini dei suoi cittadini, e contemporaneamente protesa ad un allargamento che l'ha, progressivamente, resa ingestibile.
Il progetto europeo ha subito una battuta d'arresto, ma sbagliano coloro che, per antico scetticismo o, peggio, per calcolo opportunistico, leggono in ciò la fine dell'idea di Europa politica ed il fallimento di tutto ciò che è stato fatto lungo quella strada, a partire dall'istituzione della moneta unica, l'euro. Sbaglia, soprattutto, chi persevera nell'attribuire all'Europa le colpe delle proprie inefficienze e dell'incapacità di varare le riforme strutturali necessarie per recuperare la perdita di competitività del nostro sistema produttivo.
L'unica strada percorribile, ora, è continuare il processo di ratifica. In questa posizione di coerenza, l'Italia ha una grande responsabilità, la stessa che, dopo la crisi del 1954, con il veto della Francia alla Comunità Europea di Difesa, la spinse ad ospitare la Conferenza di Messina che portò, nel 1957, alla firma del Trattato istitutivo della CEE. Una cosa è certa: un'Unione europea ferma al Trattato di Nizza, con la PESC quale massima espressione di politica estera, e con l'attuale assetto istituzionale, di fatto, rinuncerebbe a giocare un ruolo significativo, sia nelle relazioni transatlantiche, sia nello scenario internazionale. Sarebbe la vera sconfitta del progetto di costruzione di un'Europa utile ai cittadini, perché sarebbe ancora più difficile garantire i livelli di benessere e sicurezza che gli Stati nazionali sono sempre meno in grado di assicurare da soli.
L'Europa non deve rimanere paralizzata dalle sue paure. Essa deve affrontare con decisione, e con successo, i temi principali che ha di fronte. L'attuazione delle strategie definite dai Consigli di Lisbona e di Goteborg per la crescita e lo sviluppo sostenibile attraverso la cooperazione tra istituzioni nazionali e comunitarie, e le decisioni sulle prospettive finanziarie dell'Unione fino al 2013 saranno il banco di prova della credibilità delle istituzioni europee. Una soluzione di basso profilo, che portasse ad una riduzione dei finanziamenti per la coesione e gli investimenti per la competitività, avrebbe, come immediato effetto, un'ulteriore caduta del consenso all'Europa. Proporre la riduzione della spesa europea vuol dire, infatti, proporre di ridurre gli ambiti d'intervento dell'Unione; vuol dire minare tutto ciò che è stato costruito attorno al progetto di Costituzione europea.
È interesse dell'agricoltura e dell'Italia mantenere il tetto di spesa delle risorse per l'Unione e rafforzare le competenze comunitarie. Ciò potrà contribuire sia all'adeguamento del nostro potenziale d'innovazione, sia alla crescita delle regioni in ritardo di sviluppo.
È su questo tema che s'impone la massima chiarezza. Anche per questo confermiamo la nostra contrarietà all'ipotesi di parziale rinazionalizzazione della spesa agricola. Questa scelta accentuerebbe gli squilibri all'interno dell'Unione e la condizione di precarietà delle risorse finanziarie a disposizione dell'agricoltura. Abbiamo condiviso l'impostazione della riforma della PAC perché favorisce l'orientamento dell'agricoltura al mercato, ne abbiamo criticato i limiti, il consolidamento degli squilibri e le ancora scarse risorse destinate allo sviluppo rurale. Vogliamo che la PAC contribuisca sempre più e meglio a realizzare gli obiettivi di crescita dell'Unione europea: destinare quote degli aiuti a sostegno dei comportamenti e delle azioni orientati all'innovazione è il modo migliore e più efficace per difendere la PAC.
L'agricoltura assume la responsabilità, grande, di contribuire a costruire l'Europa come soggetto politico e, insieme, strumento che promuova lo sviluppo, offra maggiori garanzie di sicurezza ai cittadini, porti ad una reale modernizzazione dell'economia, riduca le sacche di povertà ed emarginazione dalle quali anche il nostro Paese non è esente.
L'agricoltura ha soddisfatto una quota significativa della domanda interna; oggi non esistono più barriere geo-politiche ai flussi di prodotti agricoli. L'agricoltura ha contribuito a porre un freno ai fenomeni incontrollati dell'esodo e dell'urbanizzazione; oggi costituisce un'occasione per migliaia di lavoratori dell'Est Europa e del Nord Africa. Nel quadro delle relazioni e della divisione internazionale del lavoro, l'agricoltura, nelle economie sviluppate, ha obiettivamente perso ruolo e peso nella composizione del prodotto interno lordo. L'agricoltura è stata considerata per un lungo periodo arma strategica nel conflitto tra Est ed Ovest del mondo; oggi è strumento per contribuire alla crescita del Sud del mondo. Nelle economie sviluppate, proiettate al terziario avanzato, una forte agricoltura, produttiva e competitiva, si affianca ai settori produttivi ad elevata tecnologia.
In questa dinamica collochiamo la proposta del nuovo Patto. La collochiamo con l'orgoglio di un settore che rivendica e assume una "responsabilità storica" di fronte alla collettività.
Abbiamo di fronte due principali interlocutori: le persone, che utilizzano i beni ed i servizi che l'agricoltura produce, alle quali ci lega l'antico Patto di lealtà; le istituzioni di governo e della rappresentanza, con le quali poniamo l'obiettivo di realizzare migliori livelli di benessere senza peggiorare la condizione di nessuno.
Poiché nulla è più come prima, anche i caratteri della nostra responsabilità mutano. Da quanto detto emerge ciò di cui parliamo:
- perché un Patto: la situazione dell'economia chiede a tutti un'assunzione di responsabilità su obiettivi condivisi per accrescere la competitività delle imprese e per il rilancio dello sviluppo;
- perché nuovo: sono mutati gli scenari e le condizioni di competitività;
- perché con la società: si rivolge all'insieme delle istituzioni di governo e della rappresentanza sociale e d'interessi.
Esso è rivolto in primo luogo ai cittadini, e non di meno alle istituzioni ed alle altre rappresentanze d'imprese e dei lavoratori. Ai cittadini, ai quali proponiamo un'agricoltura che pone la responsabilità etica tra le condizioni di successo, capace di soddisfare la domanda alimentare, di tutelare l'ambiente ed il territorio, di offrire prospettive di lavoro qualificato ai giovani. Alle rappresentanze delle imprese, per dare continuità alle intese raggiunte con i due documenti sul Mezzogiorno e sul rilancio dell'economia sottoscritti alla fine dello scorso anno. Al Governo, perché rispetti e dia continuità e contenuto agli impegni assunti al Forum di Parma ed al Tavolo agroalimentare del 2001, al Tavolo sulla previdenza agricola. Alle Regioni perché traducano le loro primarie competenze in materia di agricoltura in progetti per accrescere la competitività delle imprese, puntando sulla diffusione delle innovazioni, sulla formazione e sulla consulenza aziendale, sui servizi alle imprese e sul rafforzamento delle organizzazioni economiche degli agricoltori. Alle organizzazioni sindacali, perché il successo dell'agricoltura deriva anche dalla capacità di contribuire ad innalzare il benessere sociale. La proposta di Patto si rivolge alle rappresentanze agricole in Italia ed in Europa, perché riteniamo sia possibile e necessario trovare, nel rispetto delle identità, ed anche delle diversità d'idee, significative posizioni comuni su obiettivi di interesse per le imprese agricole.
L'antico Patto
Negli ultimi quindici anni del secolo scorso si è chiuso un ciclo storico per l'agricoltura europea. Si è esaurito l'antico Patto che aveva delineato la missione dell'agricoltura nel secondo dopoguerra: aumentare la produttività per rispondere al fabbisogno alimentare; essere strumento di coesione sociale nelle aree rurali; sostenere lo sviluppo attraverso un aumento della domanda di mezzi tecnici. Questa missione è stata favorita e sostenuta dalle politiche nazionali (la riforma fondiaria, il regime di contribuzione, i piani verdi e la legge quadrifoglio) e comunitarie (la PAC ed i negoziati GATT, nei due aspetti: sostegno del mercato interno ed elevato protezionismo). Quella fase ha registrato indubbi successi per l'agricoltura italiana ed europea. L'Unione europea è diventata il primo esportatore mondiale di prodotti agricoli. L'agricoltura europea non è fatta solo di commodities che competono nel mondo con la forza della quantità e dei prezzi, ma vanta, l'Italia in particolare, un giacimento di prodotti di qualità che non ha eguali nel mondo. Le imprese agricole hanno raggiunto elevati livelli di efficienza e produttività che, in molti casi, compensano i vincoli strutturali, dalla dimensione fondiaria alla limitata dotazione di capitali.
L'antico Patto ha anche evidenziato limiti. Non si è risolto il problema del riequilibrio territoriale (Nord-Sud, città-campagna, zone interne e marginali, di montagna e di pianura). Non sono stati colti in tempo i segnali dell'apertura dei mercati; atteggiamenti di chiusura protezionistica hanno negativamente condizionato le politiche, i comportamenti degli agricoltori, la stessa "credibilità" dell'agricoltura. Le politiche dei prezzi e dei mercati hanno sostenuto, per le principali commodities, aumenti di produzione ben oltre i fisiologici incrementi legati alle innovazioni tecnologiche. Ciò ha avuto, come effetto indesiderato, in taluni casi, un negativo impatto sull'ambiente, dovuto all'eccessivo apporto di prodotti chimici ed alle pratiche di monocoltura estensiva. Permangono squilibri tra settori e tra aree. I finanziamenti della PAC hanno privilegiato le regioni e le produzioni del Nord Europa. I differenziali di reddito e le condizioni sociali e civili nelle campagne rappresentano freni allo sviluppo. È mancata una politica nazionale capace di superare i punti di debolezza della nostra agricoltura (dalla questione fondiaria e generazionale, all'assenza di economie di rete), di valorizzarne i punti di forza (a partire dal valore delle produzioni di qualità), di sostenere il rafforzamento delle strutture aziendali.
Le imprese, nei settori meno tutelati dall'ombrello protettivo della PAC, affrontano ora la crescente concorrenza in condizioni obiettivamente più difficili.
Nella fase di cambiamento, che è durata circa venti anni, possiamo affermare con orgoglio che la Confederazione italiana agricoltori ha intuito le nuove esigenze della società europea ed i cambiamenti dello scenario internazionale. La parola d'ordine "dalla protezione alla competizione"; il deciso "no" alle quote fisiche alla produzione, sostenuto con la Marcialonga di Bruxelles; la scelta della qualità, "produrre meglio, produrre meno", sono il segno di un'organizzazione che ha saputo cogliere le novità ed avanzare conseguenti proposte in campo economico e sociale, a partire dalle tesi delle Conferenze sull'impresa, sui servizi e sulla competitività.
I cambiamenti e dunque i motivi del nuovo Patto
La liberalizzazione dei mercati ed i negoziati commerciali in sede WTO, l'emergere di nuovi protagonisti della produzione e del commercio mondiale, la diminuzione dei costi di trasporto e delle comunicazioni, le nuove tecnologie proposte dall'ingegneria genetica e dalla società dell'informazione ci hanno posto di fronte ad un processo di analoga intensità di quelli che diedero origine alle economie nazionali. Non abbiamo, tuttavia, un governo mondiale, responsabile di fronte ai cittadini, capace di sovrintendere al processo di globalizzazione con la stessa autorità con la quale gli stati nazione governano le rispettive economie. Abbiamo, in sostanza, una governance globale senza un governo globale.
Cambia la dimensione del "conflitto" in agricoltura: dalla questione fondiaria e dei contratti agrari ai rapporti di forza nelle filiere agroalimentari. Oggi, anche come effetto della liberalizzazione dei mercati, la competizione si dilata dalle filiere ai sistemi territoriali. In una situazione di accresciuta concorrenza, nella quale spesso prevale la competizione di costo, le filiere non riescono a produrre sufficiente ricchezza per tutti. I soggetti più forti (ieri l'industria alimentare, oggi sempre più la grande distribuzione) riescono a mantenere inalterati i margini di accumulazione trasferendo sull'agricoltura condizioni contrattuali (prezzi, termini di pagamento, costi logistici) particolarmente onerose che provocano l'erosione dei redditi degli agricoltori e riducono la loro capacità d'investire. Il risultato è che il vantaggio relativo di una parte si traduce in uno svantaggio per alcuni e per la collettività nel suo insieme.
Il sottosviluppo in molte aree del mondo frena il progresso dell'economia mondiale. La povertà non è solo carenza di risorse, ma ostacoli all'accesso ai benefici dello sviluppo. I meccanismi di sviluppo, avviati da alcuni paesi nel secondo dopoguerra, non sono stati capaci di innescare un equilibrato e generalizzato progresso nei paesi più poveri. Essi rischiano, considerata la scarsità di risorse naturali (a partire dall'acqua) e la fragilità degli ecosistemi, di aggravare le condizioni ambientali. Lo sviluppo del terzo mondo favorirà il processo d'integrazione delle economie, la globalizzazione dei mercati, il miglioramento delle relazioni internazionali e diventerà lo strumento principale di benessere e di pace. L'Italia agricola assume un ruolo importante per la sua collocazione geografica nei flussi di traffico tra l'Est e l'Ovest del mondo, per la consolidata storia di relazioni con i paesi della sponda meridionale ed orientale del mare Mediterraneo, per la somiglianza delle specializzazioni colturali, per la comune domanda di ricerca agronomica, per il comune obiettivo di creare una massa critica di prodotto per rispondere alla domanda dei paesi ad elevato reddito.
I consumatori, anche grazie all'aumento del benessere, sono più sensibili ai temi dell'ambiente, della salubrità, della qualità e della varietà degli alimenti. La qualità e la tipicità, il rispetto dell'ambiente, la tutela del paesaggio, l'etica della produzione assumono un peso sempre più rilevante nelle strategie d'impresa e diventano obiettivi delle politiche.
L'agricoltura, oggi, corrisponde solo in parte a questi cambiamenti. Essa, certamente, risponde alle "nuove sensibilità" della società. Non risponde in modo adeguato ai nuovi scenari della competitività, facendo registrare preoccupanti esempi di redditività negativa in molti comparti produttivi. Per anni l'ambiente intorno all'agricoltura è cambiato lentamente, permettendo agli agricoltori di adattarsi progressivamente; poi, all'improvviso, il cambiamento ha assunto velocità inimmaginabile, ponendo gli agricoltori nella condizione di inseguire i cambiamenti. Da qui derivano le incertezze ed il diffuso malessere nelle campagne.
Nel dopoguerra, le politiche hanno accompagnato e sostenuto la missione dell'agricoltura. L'opinione pubblica aveva una chiara percezione dei termini del problema. Oggi ciò non avviene con altrettanta linearità. Non vi è coerenza tra ciò che la società chiede all'agricoltura e ciò che la società fa perché l'agricoltura sia messa nelle condizioni di corrispondere alla domanda sociale.
Si diversifica la destinazione d'uso della terra, dall'attività agricola agli insediamenti industriali ed urbani, all'attività turistica e ricreativa, al mero investimento. Il patrimonio fondiario si contrae con l'allargamento dei centri urbani. Questa tendenza contrasta con la "ruralità efficiente e viva" che esprime valori sia produttivi, sia sociali ed ambientali. La rappresentanza agricola ed i Governi locali devono interloquire con l'obiettivo di difendere la destinazione agricola del territorio, riconoscendo le finalità produttive e di sviluppo delle aree rurali. Si ampliano gli interessi sul bene fondiario, con l'effetto di incrementarne i valori a livello insostenibile per chi si dedica all'attività agricola. Il costo della terra, in proprietà o in affitto, deve essere congruo rispetto ai benefici che provengono dall'attività produttiva e dal contesto territoriale.
Il mercato globale porta sulle tavole alimenti provenienti da ogni parte del mondo ed in ogni stagione. Le tecnologie offrono alimenti elaborati nei quali viene sempre meno l'identità del prodotto agricolo da cui originano. Nell'immaginario collettivo aumenta la distanza tra il cibo e la produzione agricola. L'uso improprio di marchi consolidati è, sempre più, forma di concorrenza sleale; ancora troppo debole è l'impegno per la definizione di norme internazionali di tutela delle denominazioni di origine.
In questa globalizzazione, che rende il prodotto agricolo sempre meno distinguibile nelle sue caratteristiche e nella sua origine, e rende l'impresa agricola sempre più sottoposta alla concorrenza, l'agricoltura è chiamata a rivendicare il suo ruolo nell'economia, ed il suo peso nelle strategie e nelle politiche di sviluppo. Essa, dunque, ridisegna la propria identità, che è fatta, principalmente, di insediamenti, cioè di persone e di luoghi. Nelle economie sviluppate il valore dell'agricoltura produttiva, non mera testimonianza storica, custode della tradizione e del paesaggio agrario, non si misura solo come componente del PIL, ma nella capacità di trasformare la ricchezza del prodotto agricolo, con la sua storia, la sua tradizione, la sua cultura, in una leva strategica che consenta agli agricoltori di mantenere elevati livelli di benessere, soddisfacendo bisogni collettivi.
Ecco i motivi del nuovo Patto: ricollocare l'agricoltura nelle dinamiche dello sviluppo; allineare missione dell'impresa agricola e politiche; proporre le imprese agricole come parte attiva di un sistema di relazioni a tutto campo, economiche, sociali, istituzionali.
Il Patto si sostanzia, da un lato, con la capacità dell'agricoltura di agire in un mercato concorrenziale, ponendo la responsabilità etica come componente della propria reputazione; dall'altro, con il riconoscimento del contributo dell'agricoltura al benessere sociale nella sua accezione più ampia: qualità della vita, biodiversità, ambiente, paesaggio.
Evidenziamo un nesso forte tra il Patto, il progetto e le politiche: il Patto vale perché è sostenuto da un progetto di agricoltura e perché propone politiche e comportamenti coerenti con tale progetto.
Poniamo in evidenza quattro aspetti:
- la dimensione delle politiche che si collocano nelle sedi internazionali delle relazioni e degli accordi multilaterali, nell'Unione europea, nello Stato, nelle Regioni e nel sistema delle autonomie locali;
- gli obiettivi delle politiche: migliorare le condizioni di redditività e sostenere le imprese nella sfida del mercato, creare un ambiente favorevole all'attività d'impresa;
- i riscontri delle politiche nei prossimi mesi: il DPEF, la legge finanziaria, la programmazione dello Sviluppo rurale, il programma nazionale di attuazione della strategia di Lisbona;
- le priorità:
- l'organizzazione economica: l'associazionismo economico, le relazioni di filiera, le interprofessioni, la promozione dei prodotti sui mercati, le denominazioni geografiche, i sistemi di qualità;
- l'innovazione ed il capitale umano: la formazione e la consulenza aziendale, la ricerca e la diffusione delle innovazioni, il sostegno dell'imprenditoria giovanile, il riconoscimento del ruolo crescente delle imprenditrici, il sostegno della pluriattività e della diversificazione produttiva, la diffusione di nuovi strumenti finanziari e servizi assicurativi;
- lo stato sociale e le regole: il sistema fiscale, previdenziale e contributivo, la sussidiarietà orizzontale e la semplificazione amministrativa;
le infrastrutture: il sistema irriguo, le direttrici di traffico, le reti di comunicazione, cioè l'insieme delle opere che qualificano il territorio e lo rendono fruibile alle attività economiche ed agli insediamenti umani.
I contenuti del Patto
Alla base del nuovo Patto poniamo un progetto di agricoltura:
- basata sull'impresa professionale;
- relazionale;
- motore dello sviluppo delle aree rurali.
Agricoltura basata sull'impresa professionale
Questo concetto sottende alcuni caratteri.
L'impresa diffusa sul territorio. Non è solo una questione di localizzazione. L'impresa agricola entra in relazione con soggetti ed istituzioni che operano in un territorio sempre più vasto. Essa si avvale delle conoscenze e dei valori presenti nel contesto rurale, ed è sempre più condizionata dall'ambiente che la circonda: dai fornitori di servizi al sistema delle reti (la viabilità e le comunicazioni) e della conoscenza (le istituzioni di ricerca, di formazione e di diffusione delle innovazioni), al sistema produttivo (le imprese della filiera). Un prodotto agricolo tipico porta con sé un pezzo della storia e della cultura del territorio che l'ha generato. Qui si colloca la "cultura del distretto" rurale, come luogo nel quale si realizzano processi innovativi che mettono insieme le capacità degli imprenditori locali e le conoscenze che provengono dall'ambiente esterno. Alla base del distretto vi sono processi spontanei di sviluppo che pongono il problema del coordinamento e del governo del processo di trasformazione. Una risposta è la creazione di "istituzioni intermedie" che, come espressione degli attori locali, s'inseriscono tra l'impresa ed il mercato e si candidano a svolgere una funzione di autogoverno dello sviluppo.
L'etica d'impresa come strategia di successo e non solo come vincolo. La reputazione nel mercato, la fiducia dei consumatori, la trasparenza dei processi produttivi costituiscono una componente importante del valore economico dell'impresa e del suo vantaggio competitivo. Qui si colloca il tema delicato: noi e gli organismi geneticamente modificati. Il dibattito che si è aperto in Italia ha trovato linfa nella diffusa domanda di sicurezza alimentare. Confermiamo il nostro impegno a centrare la nostra azione sui seguenti capisaldi: produzioni di qualità, cioè un'offerta differenziata, con alto contenuto di tradizioni e di servizio; sicurezza alimentare e principio di precauzione, cioè rispetto delle norme e dei principi della salute pubblica, informazione e tracciabilità; certezze per gli agricoltori, cioè regole per la coesistenza e sistema dei controlli, perché gli agricoltori siano messi in grado di programmare gli ordinamenti colturali; tutela della biodiversità e dell'ambiente, cioè recupero e salvaguardia delle varietà tradizionali che rischiano, per difficoltà produttive e di mercato, di scomparire dagli ordinamenti colturali, innovazione delle tecniche produttive orientate, tra l'altro, ad un più razionale uso della chimica; ricerca e diffusione delle innovazioni. Il nostro Paese è stato per lungo tempo all'avanguardia per il miglioramento genetico delle piante coltivate. Le varietà di grano duro uscite dai nostri laboratori di ricerca sono tra le più diffuse. Oggi questo patrimonio di conoscenze rischia di disperdersi. La ricerca deve essere sostenuta ed orientata per dare risposte alle domande che la nostra agricoltura pone: principalmente varietà resistenti ai parassiti ed agli stress termici ed idrici; ridurre la nostra dipendenza dall'estero di materiale genetico. Da qui la richiesta di un piano sementiero nazionale. Ancora una volta, come fu con la rivoluzione verde, i sentieri della ricerca biotecnologica si rivolgono, prevalentemente, a sistemi produttivi che ci sono sostanzialmente estranei. Per questo, consideriamo che gli ogm non servano alla nostra agricoltura.
La diversificazione delle attività e delle forme giuridiche. La nuova versione dell'articolo 2135 del codice civile prende atto che l'impresa agricola è un insieme di professionalità e specializzazioni, cioè un'istituzione in grado di valorizzare l'apporto economico e la capacità professionale dell'insieme dei soggetti che "vivono sotto lo stesso tetto". Pensiamo ai giovani ed alle imprenditrici che trovano nella diversificazione delle attività produttive motivazione e riconoscimento economico al loro lavoro in azienda. In questo quadro gli anziani possono giocare un ruolo significativo: titolari d'attività d'impresa, nelle zone ove maggiore è l'importanza della presenza dell'uomo per salvaguardare il valore storico e paesaggistico; partecipi di progetti di ricomposizione fondiaria nei quali si combinano l'apporto della terra dell'anziano proprietario, l'iniziativa professionale del giovane imprenditore, il capitale dell'istituzione finanziaria, una volta posto il progetto e non solo la garanzia reale alla base delle motivazioni di finanziamento.
L'impresa agricola si diversifica dalla produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli alla fornitura di servizi ad elevato contenuto sociale secondo modelli di gestione basati sulla sussidiarietà (servizi di prossimità, di assistenza domiciliare, di accoglienza e recupero); dallo svolgimento di attività economiche legate alla tutela del territorio e dell'ambiente (produzione di energia da fonti rinnovabili, manutenzione e gestione del patrimonio fondiario pubblico…) alle attività ricreative, a partire dall'accoglienza turistica. Ancora troppi sono, tuttavia, gli ostacoli burocratici che rallentano la diversificazione delle imprese, soprattutto nel caso dell'accesso agli appalti pubblici.
Agricoltura relazionale
L'impresa agricola evolve. L'evoluzione e la modernità dell'impresa non sono solo un fatto tecnico produttivo. Per troppo tempo il settore agricolo è stato costretto a visioni settoriali ed anguste. Bisogna uscire dagli steccati: l'impresa, il settore agricolo e le organizzazioni di rappresentanza debbono divenire protagonisti del sistema di relazioni economiche, politiche, culturali, istituzionali, sociali, nelle quali sono coinvolte. Questa proposta si lega al Patto alla pari del 1986: oggi quel concetto si modifica, si rielabora, non si applica più soltanto lungo la filiera, ma si estende al territorio,
Dobbiamo ragionare e operare in termini di sistema. Progressivamente si allineano i comportamenti, le strategie ed i bisogni delle imprese agricole e quelli dell'insieme delle piccole e medie imprese. I mercati dei prodotti e dei capitali, i rapporti con la pubblica amministrazione ed il sistema dei servizi all'impresa, la logistica, il marketing ecc. sono tutte funzioni comuni del mondo della piccola e media impresa. Questo allineamento delle strategie e delle domande di politiche impone un'azione concertata tra le organizzazioni di rappresentanza dell'agricoltura e degli altri settori nei confronti dei governi sui temi di comune interesse. Il successo del nuovo Patto sta principalmente nella nostra capacità di proporre, costruire e consolidare relazioni.
Le relazioni economiche. L'impresa evolve nelle relazioni di mercato. La nostra agricoltura è caratterizzata da un persistente gap organizzativo, che si traduce in una minore capacità di trattenere quote di reddito. L'inefficienza di talune filiere apre la strada a comportamenti speculativi che portano alla minima trasparenza dei processi di formazione dei prezzi ed alla diffusione di azioni malavitose. Le strade finora percorse si sono mosse nella logica della concentrazione dell'offerta. Essa non è, tuttavia, l'unica forma utile per rafforzare la presenza degli agricoltori sul mercato. Ad essa si affiancano nuove opportunità fondate sulla conoscenza e sui nuovi strumenti informatici di comunicazione e vendita, sulla diffusione dei marchi e dei sistemi di qualità, sull'organizzazione contrattuale, sul potenziamento delle strutture e dei servizi logistici. L'economia diventa più relazionale, è legata a fattori non di mercato, meno governabili con le tradizionali relazioni contrattuali e più basata su condizioni di contesto che favoriscono la cooperazione tra soggetti individuali e collettivi. Quest'evoluzione colloca l'impresa orientata al mercato in un sistema di relazioni nel quale interagiscono soggetti economici, industria di trasformazione e distribuzione, istituzioni scientifiche e di ricerca, con le quali intendiamo progettare la costituzione di poli d'eccellenza per la diffusione delle innovazioni, i soggetti erogatori di servizi, dei quali fa parte il nostro "sistema Cia".
Le relazioni sociali. Qui si collocano i rapporti con le altre rappresentanze d'impresa. Si sono progressivamente allineate le domande di politica del complesso delle piccole imprese. Cambia la dimensione della lobby. Da qui nasce la nostra adesione ai documenti per il rilancio dello sviluppo e sul Mezzogiorno sottoscritti insieme alle rappresentanze d'impresa alla fine dello scorso anno. Con quei documenti abbiamo inteso avviare un percorso comune che mira ad identificare obiettivi e strumenti di un'azione volta ad ottenere risultati concreti e verificabili, nella piena consapevolezza che le nuove sfide chiedono un impegno deciso delle forze sociali e produttive a confrontarsi e lavorare insieme in modo coeso e solidale. Quei documenti rappresentano, per noi, una scelta politica da perseguire con coerenza, e soprattutto da riempire di contenuti. Da questo punto di vista, le intese con le rappresentanze delle imprese sono una necessità finalizzata al successo competitivo del sistema Italia.
Qui si colloca la nostra iniziativa finalizzata a creare le condizioni per sviluppare azioni concertate tra le organizzazioni professionali agricole. Essa è, per noi, una necessità per difendere il valore dell'agricoltura e per rafforzare la capacità d'azione della rappresentanza agricola. Su questo intendiamo misurarci e lavorare per il progresso dell'agricoltura e degl'interessi di cui siamo portatori. Su questi obiettivi chiediamo alle organizzazioni agricole, Coldiretti e Confagricoltura di manifestare la loro disponibilità.
L'esigenza di allargare il fronte della nostra azione deve impegnarci a sviluppare una specifica azione verso la cooperazione e l'associazionismo di prodotto. Il nostro impegno è valorizzare l'esperienza svolta dalla cooperazione e dall'associazionismo ai quali va riconosciuto il merito di avere, pur con storie e forme organizzative diverse, svolto un ruolo positivo per l'agricoltura e la difesa del reddito degli agricoltori. Il nostro impegno a costruire e rafforzare queste esperienze come libera scelta degli agricoltori muove dalla convinzione che esse possono dare risposte ai tanti problemi delle nostre imprese che, in molti casi, non possono essere affrontati singolarmente.
Dobbiamo contribuire a rafforzare la fiducia verso i beni ed i servizi che gli agricoltori producono. Qui si pone il tema delle intese tra gli agricoltori ed i soggetti, dalle associazioni ambientaliste a quelle dei consumatori, che sono, in diversi modi e forme, coinvolti nei temi della tutela della salute e della qualità dei prodotti, della salvaguardia dell'ambiente e della difesa del territorio, della valorizzazione delle comunità rurali, della difesa delle tradizioni e dei giacimenti culturali dei quali le nostre campagne sono ricche.
Le relazioni istituzionali. Cambia lo scenario istituzionale di riferimento. I processi decisionali sono "delocalizzati" verso istituzioni sopranazionali, da un lato, e verso il territorio, le istituzioni regionali e sub-regionali dall'altro. Il processo di decentramento di compiti e funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali e funzionali delinea una nuova architettura istituzionale attorno alla quale si definiranno le strategie d'intervento. Ciò pone un problema di coerenza tra le scelte di politica generale ed i programmi attuati nelle singole Regioni. È una fase delicata ed ancora in transi-zione nella quale, a nuovi livelli di governo, corrisponderanno diversi livelli di partecipazione alle decisioni. È un processo non reversibile rispetto al quale dobbiamo rafforzare la nostra capacità di confronto a tutti i livelli decentrati: il sistema delle autonomie locali e delle relative strutture di rappresentanza, gli enti funzionali (dalle Camere di Commercio agli Enti di bonifica). Siamo convinti che, per promuovere lo sviluppo, siano necessari, da un lato, un'azione della Pubblica amministrazione rinnovata nei contenuti, negli strumenti e nella capacità di agire, coraggiosa nel delineare processi di delegificazione e nello snellimento delle procedure; dall'altro, un rapporto di partecipazione con le rappresentanze degli interessi.
La concertazione negli anni '90 fu, insieme, strumento di coesione, la responsabilità condivisa tra Governo e parti sociali, e sviluppo, il risanamento dei conti pubblici e l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro. La concertazione è stata messa in discussione: l'esecutivo ha dato priorità alla rapidità del processo decisionale rispetto alla ricerca del più largo consenso. Ciò è avvenuto, in particolare, con la legge finanziaria 2005 e con i provvedimenti per la competitività. Questo non è ammissibile quando si definiscono le condizioni e le prospettive di crescita del sistema delle imprese, che è, oggi, l'obiettivo prioritario che ci poniamo come condizione della ripresa economica del Paese. Certo, movimenti politici, governo ed organizzazioni di rappresentanza hanno compiti, responsabilità ed obiettivi diversi. Solo partendo dal riconoscimento di questa diversità, e rispettandola, è possibile un rapporto corretto tra Governo e sistema delle rappresentanze. La concertazione costituisce il metodo più efficace per regolare l'apporto originale ed autonomo delle organizzazioni rappresentative di interessi nella formazione delle scelte di governo.
La concertazione deve essere rilanciata, non come pratica per i periodi difficili, ma come scelta politica alla quale devono essere uniformate le azioni del Governo ed i comportamenti delle Organizzazioni di rappresentanza. Essa deve essere regolata, secondo gli schemi condivisi sul partenariato economico e sociale, per non essere lasciata alla discrezionalità dei governi. L'autonomia e la concertazione rappresentano i pilastri di un corretto rapporto tra istituzioni e organizzazioni professionali agricole.
La scelta della concertazione è finalizzata anche a rimuovere le ricorrenti suggestioni volte a disconoscere le rappresentanze d'interessi quali interpreti diretti degl'interessi di categoria. In una società complessa, il pluralismo dei partiti ed il bilanciamento dei poteri istituzionali non sono sufficienti all'affermazione della democrazia in assenza dell'espressione organizzata degli interessi delle categorie sociali e produttive.
La riforma dello Stato in senso federalista non è solo un mutamento di ruolo o trasferimento di poteri e competenze, ma un'occasione per valorizzare risorse locali e per fare emergere il "protagonismo" degli agricoltori e delle loro rappresentanze. Per questo ribadiamo l'importanza della dimensione locale dello sviluppo e della "programmazione dal basso". Essa parte dal territorio, ma non costruisce sistemi isolati; si fonda sul principio della collaborazione tra le istituzioni e del partenariato con le categorie produttive. Lo stesso procedimento legislativo impone questo collegamento. Per questo devono essere definiti e regolamentati i rapporti tra il Tavolo agroalimentare e la Conferenza tra lo Stato e le Regioni. Le Regioni portano, a loro volta, alla Conferenza degli Assessori, il parere maturato nei rispettivi tavoli di concertazione. Ecco perché non è pensabile un modello di concertazione separato tra il livello nazionale e quello regionale.
Il principio di sussidiarietà deve essere attuato non solo tra i livelli dello Stato, ma anche nei confronti delle rappresentanze sociali. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, così come recita l'articolo 118 della Costituzione, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, Il principio di sussidiarietà deve essere concepito come integrazione tra le attività pubbliche e le iniziative del "privato sociale" al fine di favorire lo sviluppo dell'autodeterminazione del singolo e dei corpi intermedi, dovendo l'attribuzione delle funzioni interessare non solo i vari livelli di governo territoriali, ma anche le autonomie che garantiscono il pluralismo sociale e culturale. La sussidiarietà orizzontale è componente del successo della rappresentanza e dell'azione delle imprese protese alla multifunzionalità ed alla diversificazione. Non è ancora compiutamente diffusa, nel nostro Paese, la cultura della sussidiarietà. Un processo di riforma istituzionale in senso federalista dovrà, quindi, basarsi sui principi inscindibili dell'unità, del decentramento e della partecipazione sociale, dando luogo ad un sistema pluralista di autonomie istituzionali, funzionali, rappresentative sociali.
Agricoltura motore dello sviluppo delle aree rurali
L'attività agricola rappresenta, nei territori rurali, il nucleo intorno al quale si realizzano processi in grado di valorizzare numerose attività economiche del terziario e delle piccole industrie, dall'agriturismo all'artigianato alimentare. Il segno più evidente di questo fenomeno è che il territorio rurale mantiene la sua identità fatta di tradizioni, beni culturali, paesaggio, e la trasforma in opportunità economiche ed in una forza antagonista ai processi di emarginazione.
La vitalità dell'agricoltura e del territorio rurale è, per questo, interesse di tutta la società. Una politica di governo del territorio che ponga attenzione all'economia ed alle comunità rurali è la condizione per promuovere una crescita sostenibile e creare nuove opportunità di lavoro. La vitalità del territorio rurale è essenziale per l'agricoltura, così come l'attività agricola è essenziale per la vitalità del territorio rurale.
Sono, per questo, elemento del Patto le politiche comunitarie, nazionali e regionali finalizzate al superamento degli squilibri e capaci di esaltare la ricchezza sociale e produttiva presente nelle aree rurali. La rarefazione dei servizi, dai centri sanitari, scolastici, culturali, fino agli sportelli bancari, è il fenomeno che prelude alla progressiva emarginazione dei piccoli centri rurali. È necessaria una nuova stagione dei diritti che offra condizioni di pari opportunità a quanti possono dare un positivo contributo allo sviluppo, e sia capace di ricostruire una capacità d'attrazione delle aree rurali.
Le politiche di sviluppo delle aree rurali devono tenere conto delle esigenze specifiche e valorizzare le potenzialità offerte dalle comunità locali. La politica di sviluppo rurale deve essere attuata in collaborazione tra le istituzioni e la società civile, secondo il principio di sussidiarietà. Un banco di prova sarà la definizione del quadro strategico nazionale per la politica di coesione. Particolare rilevanza avranno i documenti strategici regionali e le linee di programma del Mezzogiorno alla cui elaborazione concorreranno le rappresentanze sociali.
Il riconoscimento della multifunzionalità dell'agricoltura è il punto di partenza delle politiche che dovranno dedicare attenzione alle funzioni ambientali dell'impresa agricola (dalle attività di manutenzione del territorio alla produzione energetica da fonti rinnovabili).
Le aziende agricole sono chiamate a nuove responsabilità di fronte alla società: alla domanda di alimenti si aggiungono nuove aspettative, l'occupazione, la qualità e la sicurezza alimentare, la protezione dell'ambiente, un equilibrato sviluppo territoriale. L'agricoltura multifunzionale è la risposta alle nuove aspettative della società: ad essa corrispondono imprese che, contemporaneamente, contribuiscono alla produzione agricola, ma anche alla protezione ed alla riproduzione delle risorse naturali, all'occupazione e ad uno sviluppo equilibrato del territorio. E' una visione dell'agricoltura per la quale la tutela ambientale, l'identificazione dei prodotti, i comportamenti etici non sono considerati vincoli, ma potenziali vantaggi economici per le imprese. In tale contesto dovranno essere riconosciute, anche sotto il profilo giuridico, le aziende operanti nei diversi ambiti della multifunzionalità.
Programmazione territoriale e sussidiarietà sono due leve alla base dello sviluppo locale: ciò significa essenzialmente creare opportunità per le imprese del territorio; favorire la coesione economica e sociale e migliorare la qualità della vita e del lavoro potenziando i servizi che garantiscono le condizioni materiali di base (acqua, luce, telefono) e favorendo l'accesso ai servizi sanitari, assistenziali, scolastici e culturali; promuovere le iniziative volte a ridurre l'effetto periferia di molte aree rurali (collegamenti e reti di comunicazione); favorire le attività produttive presenti sul territorio, attraverso la leva fiscale, ed i servizi alle imprese; valorizzare il ruolo della cultura e delle tradizioni locali come elementi costitutivi dell'identità delle popolazioni rurali.
Nei caratteri descritti sta la "specificità" dell'impresa agricola: diffusa, diversificata, organizzata. Ci interroghiamo sulla dimensione, oggi, della specificità dell'agricoltura e delle imprese agricole nelle politiche nazionali. L'impresa agricola di-spone di una copiosa legislazione speciale, nazionale e comunitaria, in diversi settori, fiscale, previdenziale, assicurativo, ambientale. D'altro canto, il sistema dei sussidi ha impedito o, talora, dissuaso molte aziende agricole dal ricorrere agli strumenti che la legislazione ordinaria ha, negli anni, messo a disposizione delle imprese per promuovere lo sviluppo, la crescita dimensionale, la presenza sul mercato in condizioni di competitività.
I negoziati Wto e le riforme della Pac hanno progressivamente accentuato la logica di mercato e di selezione delle imprese, e dunque ne hanno ridotto la specificità. Progressivamente solo le aziende che avranno capacità professionali ed organizzative sopravvivranno; le altre rischiano di entrare nell'area della marginalità e dell'abbandono. In questo scenario vogliamo caratterizzare la nostra azione per offrire condizioni di pari opportunità a tutti gli imprenditori.
Una politica, con alti contenuti sociali volta a tutelare le aziende deboli, non deve essere considerata alternativa a politiche che introducano nel nostro sistema produttivo forti stimoli competitivi, rispetto ai quali può verificarsi l'arretramento del peggiore, o del meno efficiente. In questo scenario, le aziende giovani, quelle orientate alla qualità ed all'innovazione potrebbero trarre i maggiori vantaggi.
Il nuovo Patto e la condivisione degli agricoltori
Le sfide di oggi hanno bisogno di risposte e di decisioni rapide, coraggiose ed innovative. Il protagonismo degli agricoltori va affermato, costruito e guidato. Il consenso e la partecipazione costituiscono lo spirito stesso di una rappresentanza che dia insieme forza alle scelte e chiarezza nel rapporto con gli associati.
La rappresentanza non è solo la capacità di sostenere, nel rapporto con le istituzioni, le domande degli associati. Essa è, anche, programma e progetti, ed insieme, mandato per la loro attuazione. Ciò vuol dire che un adeguato modello di rappresentanza richiede che le domande, i bisogni e le attese degli associati siano aggregati ed anche tradotti in decisioni: non basta il progetto e la volontà politica per rendere efficace un modello di rappresentanza; sono necessarie le strutture e gli strumenti per realizzare il progetto. Qui si collocano, tra l'altro, l'impegno a promuovere servizi avanzati (nel senso di promuovere il sistema dei servizi della Confederazione Italiana Agricoltori, ma anche favorire l'accesso degli agricoltori ai nuovi servizi) ed il nostro ruolo nella costruzione delle organizzazioni economiche.
Conoscenza, competenza e relazioni sono i modi per declinare il modello della rappresentanza. L'azione sindacale e l'attività di servizi costituiscono i due capisaldi dell'iniziativa delle organizzazioni agricole a tutela degli agricoltori. E', infatti, anche attraverso un sistema dei servizi che abbiano i caratteri della professionalità, della competenza, della puntualità e della tempestività che è possibile rispondere pienamente alle esigenze degli agricoltori.
Dobbiamo porci, con altrettanta attenzione, sia l'obiettivo di creare un servizio efficiente e competitivo, sia creare ed organizzare la domanda, nei settori innovativi, quali, per esempio l'assicurativo o finanziario. Anche questo è parte della proposta di "nuovo Patto". Organizzare, insieme, domanda e offerta di servizi, vuol dire, infatti, considerare come fatto inscindibile la rappresentanza e la capacità di creare un sistema di relazioni (con le istituzioni e con i soggetti che, a vario titolo agiscono nel sistema dei servizi) che è, in ultima analisi, il senso del nuovo Patto.
Considerazione conclusiva
La proposta del "nuovo Patto" impone a tutta la Confederazione Italiana Agricoltori di serrare le file. Tutti dobbiamo operare perché la nostra organizzazione sia più forte e capace di portare a successo la sfida che abbiamo lanciato innanzitutto a noi stessi. La nostra storia, di cui siamo orgogliosi, è un punto fermo per proseguire e guidare la nuova fase che abbiamo aperto, e con essa la crescita dell'agricoltura. Abbiamo l'ambizione di poter contribuire a costruire un nuovo grande capitolo della storia di una Confederazione che rappresenta un inestimabile patrimonio di cui fanno parte i nostri agricoltori, le nostre strutture diffuse nel territorio, le nostre migliaia di tecnici e dirigenti che operano con passione e professionalità, con funzioni e responsabilità diverse.
Abbiamo alle spalle un periodo pieno di difficoltà e problemi, di emergenze e trasformazioni che hanno fatto sentire i loro pesanti effetti sulle imprese e sulla nostra organizzazione. Abbiamo di fronte un periodo nel quale predominano le incertezze e segnato da crescenti pressioni concorrenziali.
Vogliamo un'agricoltura forte e imprese competitive capaci di produrre reddito per gli agricoltori e ricchezza per la nazione: ciò non è possibile senza un progetto ed una rinnovata e credibile politica agraria. Non possiamo affrontare le sfide solo basandoci su misure parziali capaci, nella migliore delle ipotesi, di aiutarci a fronteggiare ricorrenti emergenze. Le sfide si vincono se vi saranno decisioni rapide, coraggiose ed innovative coerenti con un disegno capace di guidare e rilanciare la nostra economia riconoscendo il contributo del settore agricolo.
Cinquanta anni fa, dirigenti contadini ebbero la grande intuizione di dar vita all'Alleanza dei Contadini, forti solo del proprio coraggio e del loro entusiasmo. Fu un evento storico che aveva come obiettivo mettere al centro l'agricoltura e la figura del coltivatore.
Oggi dobbiamo avere quello stesso coraggio ed entusiasmo. Abbiamo nuovamente l'occasione per fare sentire la nostra voce. Guidare il cambiamento, costruire il protagonismo degli agricoltori: questa è la sfida che abbiamo di fronte. È una sfida difficile. Ma dalla consapevolezza della difficoltà esce esaltata la nostra azione. Accettiamo questa sfida con la convinzione di essere all'altezza e di operare con successo e nell'interesse di tutti gli agricoltori. Accettiamo questa sfida con l'ambizione e la caparbietà che ci sono propri, con l'orgoglio di chi opera e crede nella Confederazione Italiana Agricoltori.
Una sfida nella quale dobbiamo trovare il giusto sostegno, non solo da parte della società nel suo complesso, ma anche e soprattutto degli agricoltori che, nonostante i gravi problemi e le difficoltà che affrontano quotidianamente nel loro lavoro, e con pesanti sacrifici, sono certamente in grado di svolgere un ruolo propulsivo. Ad essi ci rivolgiamo prioritariamente per sostenere il Patto, perché hanno grandi capacità, professionalità e risorse per vincere una partita che ormai si presenta in termini decisivi.