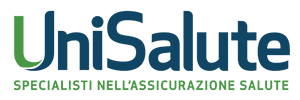Agrienergie - Dall'agricoltura un contributo per la produzione di fonti energetiche rinnovabili
AGRIENERGIE
Dall'Agricoltura un contributo per la produzione di fonti energetiche rinnovabili
Premessa
La questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche di sviluppo e delle politiche ambientali. Sono sempre più numerosi gli esperti internazionali che stimano una riduzione delle riserve complessive di petrolio con tempi più ridotti di quanto già previsto, soprattutto per effetto dell'incremento della domanda mondiale d'energia ( +60% entro il 2020) che nei paesi in via di sviluppo registra i maggiori incrementi. Ad esempio è stato calcolato che quando la Cina raggiungerà gli stessi consumi pro capite degli USA consumerà la quantità di barili di greggio pari all'intera produzione mondiale di petrolio registrata nel 1997.
In Italia la fragilità del sistema energetico è ancora più evidente, importiamo dall'estero oltre l'82% del nostro fabbisogno di energia, che è coperto in larga parte da combustibili fossili. La quota costituita dal riscaldamento domestico non va sottovalutata, essa rappresenta un quinto del fabbisogno energetico nazionale e a livello europeo se sommata alla produzione di vapore nel settore industriale, raggiunge una quota pari ad un terzo della energia richiesta.
Anche nel nostro paese da alcuni anni sono state attivate iniziative per incrementare l'uso e la produzione di energia da fonti rinnovabili anche se con risultati ancora non significativi rispetto alle potenzialità.
Il settore agricolo e forestale in questi ultimi anni sta acquisendo via via un ruolo sempre maggiore grazie al progressivo affermarsi di nuove tecnologie che, attraverso l'utilizzo di produzioni agricole e forestali dedicate, consente di produrre energia pulita e rinnovabile.
La gamma di combustibili di origine agricola destinati alla produzione di energia rinnovabile è articolata in:
q Combustibili solidi: biomasse agricole e forestali ( cippato di legno, Pellet, Legna da ardere, Briqette )
q Combustibili liquidi o biocarburanti: Bioetanolo, Biodiesel, Olio combustibile vegetale
q Combustibili Gassosi: Biogas da fermentazione di reflui zootecnici e biomasse vegetali .
L'insieme della produzione energetica derivante dal settore agricolo è definita BIOENERGIE o più opportunamente con il neologismo: AGRIENERGIE, perché direttamente riconducibili alle produzioni agricole.
1 Il quadro generale
1.1 Il "LEGNO ENERGIA" la prima fonte energetica rinnovabile d'Europa, la seconda in Italia.
l'idea che l'impiego del legno come combustibile sia poco diffuso non è esatta. Questa modalità, che è sicuramente la più antica, è ancora molto diffusa. Infatti, un'indagine condotta dall'ENEA qualche anno fa stima che circa 4,5 milioni di famiglie in Italia utilizzano la legna a scopo energetico a varia scala e che il mercato della legna da ardere si aggiri intorno ai 620 milioni di euro.
Il legno utilizzato a scopo energetico rappresenta in Italia una quantità stimata oltre 15 milioni di tonnellate che in termini energetici equivalgono a circa 4,6 milioni di tonnellate petrolio (Mtep).
Questo consumo non è radicato solo nelle regioni dell'arco alpino, ma è ancora più significativo nelle regioni del centro sud quali l'Umbria, l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata nelle quali si calcola mediamente un uso superiore ai 1500 kg per famiglia.
In Italia il legno-energia rappresenta il 27,54% dell'energia da fonti rinnovabili, seconda dopo l'idroelettrica ( 58,38%), distanziando notevolmente fotovoltaico, solare termico ed eolico che tutte assieme non superano il 1,55% ( dati 2001 Ises Italia 2003).
Nel corso degli ultimi anni le moderne tecnologie introdotte nella combustione del legno, nel suo controllo, nella alimentazione automatica dei combustibili legnosi applicate agli impianti per la produzione di energia termica, hanno fatto acquisire rendimenti sempre più alti, maggiore praticità, affidabilità, efficienza, sicurezza, programmabilità delle temperature e dei tempi di erogazione. Da alcuni anni sono commercializzati impianti per la produzione di calore che, utilizzando lo stesso sistema di distribuzione del calore già presente negli edifici esistenti (termosifoni, ventilconvettori, ecc), sono in grado di soddisfare le esigenze di riscaldamento degli ambienti e di produzione di acqua calda sanitaria, in modo facile ed efficace.
La novità più rilevante è rappresentata dai rendimenti che queste innovazioni consentono. La quantità di calore che un caminetto a fiamma aperta è in grado di diffondere nell'ambiente circostante non supera il 40%, ciò significa che in questo modo oltre il 60% di quella energia è dispersa all'esterno attraverso il camino; una stufa tradizionale a legna riesce a garantire una efficienza che non va aldilà del 50%. Le nuove tecniche di combustione riescono a raggiungere un rendimento che va dall'80 al 90% al pari delle caldaie a metano o a gasolio.
Queste caldaie di nuova concezione, sono costruite con criteri e standard qualitativi generalmente molto elevati, in molti casi il quadro di comando è gestito da un sistema computerizzato e alcuni modelli prevedono una sonda lambda che ottimizza il processo di combustione raggiungendo così alti livelli di rendimento ed emissioni molto contenute.
Anche la tipologia dei combustibili legnosi è cambiata, si va infatti da:
· impianti a pezzi di legna a fiamma inversa denominati anche a " gassificazione totale" più adatti alla scala domestica, a questa scala vengono utilizzate anche Briquette, cioè cilindri di legno densificato della dimensione di un tondello da ardere.
· impianti a legno cippato, vale a dire legno ridotto a schegge di piccole dimensioni alimentati in modo automatico con sistemi a coclea a spintore o a restrelli, questa tipologia viene impiegata a piccole, medie e grandi reti di teleriscaldamento, con questa modalità si possono riscaldare da un piccolo gruppo di abitazioni fino ad un intero paese con centinaia di utenze collegate.
· apparecchiature a pellet, cioè piccoli cilindretti di segatura pressata e trafilata che vengono utilizzati a tutte le scale, da piccole stufe per ambienti fino a grandi impianti di teleriscaldamento.
E' pur vero che la diffusione di queste moderne tecnologie non è ancora così ampia in Italia, ma seguendo il trend di sviluppo già presente in molti paesi europei ( in Austria gli impianti installati a varia scala di potenza e ad alto rendimento termico alimentati a combustibili legnosi sono oltre 50.000 ), anche in Italia queste nuove apparecchiature stanno incontrando via via sempre maggiore interesse.
La vocazione del legno a rappresentare una delle più significative fonti energetiche rinnovabili non viene adeguatamente considerata, ma il legno è il prodotto della fotosintesi clorofilliana costituita da una serie di complesse reazioni fitochimiche che, grazie all'energia proveniente dal sole, a partire da molecole estremamente diffuse come l'anidride carbonica e l'acqua, in presenza di sali minerali assorbiti dal terreno, consente alla pianta di realizzare una nuova sostanza organica composta fondamentalmente da carbonio ( 50%), ossigeno ( 44%), e idrogeno ( 6%), che combinati tra loro formano Cellulosa, Emicellulosa e Lignina.
Quando il legno è bruciato in modo ottimale, i cicli dell'energia e dei diversi componenti chimici che lo costituiscono si chiudono perfettamente: l'energia chimica conservata nel legno si libera sotto forma di luce e calore, l'acqua ritorna nell'atmosfera come vapore acqueo che poi diventerà pioggia, l'anidride carbonica assorbita ritorna nuovamente nell'atmosfera, i sali minerali ritornano al terreno sotto forma di ceneri. E' inoltre interessante osservare che il legno è una fonte energetica "CO2 neutrale" in quanto la parte di anidride carbonica emessa dalla combustione è la stessa fissata dagli alberi dalla fotosintesi, perciò rientra in atmosfera senza alterare il ciclo del carbonio, diversamente da quanto accade per i combustibili fossili, principali imputati dell'effetto serra.
Una buona gestione forestale ispirata ai principi della sostenibilità può rendere oggi disponibile una rilevante quantità di combustibili legnosi e allo stesso tempo produrre vantaggi ambientali, sociali ed economici, senza intaccare l'attuale patrimonio forestale ma anzi valorizzandolo. La costituzione di filiere produttive di legno energia gestite da imprese agricole e forestali creano occupazione, reddito e manutenzione del territorio, in una parola contribuiscono allo sviluppo locale.
Le esperienze di questi ultimi anni stanno a dimostrare che le potenzialità in questo ambito non sono soltanto presenti nei territori di montagna e collina ma anche nella pianura , infatti vi sono ottime opportunità di impiego energetico dalle produzioni legnose di filari e sistemi arborei lineari , nonché dalle potature delle colture arboree.
La Confederazione Italiana Agricoltori ha promosso la costituzione di AIEL Associazione Italiana per l'Energia dal Legno che ha lo scopo di promuovere e diffondere questa importante fonte energetica di derivazione agro-forestale. Ad oltre 3 anni dalla sua costituzione AIEL rappresenta uno dei principali interlocutori del settore, è convenzionata con numerose regioni ed agenzie per la promozione dell'innovazione in campo agricolo, collabora con le principali associazioni di settore a livello europeo.
IL RUOLO DEL LEGNO-ENERGIA IN EUROPA RISPETTO ALLE RINNOVABILI
Contributo percentuale delle fonti di energia rinnovabile alla produzione di
energia primaria nei paesi dell'Unione Europea (Observ'ER 2001)
1.2I BIOCARBURANTI (Biodiesel, Bioetanolo, Olio Vegetale Combustibile)
L'impiego e lo sviluppo di questi biocarburanti sono in più occasioni richiamate dalle politiche energetiche dell'Unione Europea . Il Libro Verde della Commissione " verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" fissa l'obiettivo di sostituire il 20% dei carburanti convenzionali con i carburanti alternativi nel settore dei trasposti stradali entro il 2020.
La direttiva 2003/30 in corso di recepimento dispone che gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia immessa sui loro mercati una percentuale di biocarburanti avendo come valor di riferimento il 2% calcolato sulla base del tenore energetico di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005. Per l'Italia l'obiettivo da raggiungere può essere pari a circa 9 milioni di ettolitri di biocarburanti da immettere sul mercato.
1.2.1 Il Biodiesel è una fonte di energia rinnovabile in forma liquida ottenuta da oli vegetali di colza, soia o girasole. Può essere utilizzato come sostituto del gasolio, puro o in miscela con quest'ultimo, come carburante nel settore dei trasporti e come combustibile per il riscaldamento senza modificare motori o caldaie.
Il Biodiesel è definito dalle specifiche internazionali CEN con la sigla FAME (Fatty Acid Methyl Esters) con le due differenti caratteristiche di combustibile per uso trazione (prEN14214-UNI10946) e riscaldamento (prEN14213-UNI10947)
La produzione italiana di Biodiesel è attorno alle 200.000 tonnellate annue a fronte di una produzione europea di circa un milione di tonnellate annue.
L'uso del Biodiesel, se comparato con quello dei combustibili di origine fossile, permette una riduzione delle emissioni gassose prodotte dai motori e ritenute pericolose per la salute. La CO2 prodotta durante la combustione di una certa quantità di Biodiesel è riutilizzata durante la fotosintesi delle colture destinate alla sostituzione di quella quantità di Biodiesel. In questo modo, il contenuto di anidride carbonica presente in atmosfera non cambia .
Studi indipendenti mostrano che, confrontando l'anidride carbonica emessa durante tutto il ciclo di vita del Biodiesel con quello del gasolio, si ha un risparmio complessivo medio di 2,5 tonnellate di anidride carbonica per ogni tonnellata di gasolio sostituito.
Il Biodiesel può contribuire a risolvere le problematiche di inquinamento locale; grazie alla presenza di ossigeno nella sua molecola (circa l'11%), la combustione risulta migliore, non contiene idrocarburi policicli aromatici, non contiene zolfo e permette una riduzione degli inquinanti e della pericolosità delle emissioni.Da uno studio su motore Diesel alimentato a Biodiesel dell'Health and Safety Institute (organo Sanitario Governativo Britannico equivalente al nostro Istituto Superiore della Sanità) risulta che , il particolato fine (PM10) viene ridotto del 58% con una diminuzione del 76% della parte più nociva, quella carboniosa (soot) in quanto più assorbibile durante la respirazione ed anche quella non riducibile dai sistemi catalitici di abbattimento. Il monossido di carbonio è ridotto del 58% ad alti carichi e i composti aromatici subiscono una diminuzione del 68% riducendo così l'impatto cancerogeno, mentre non si sono riscontrate variazioni sugli altri inquinanti non normati. Questi dati sono in lina con quanto riportato da studi americani convalidati dall'EPA (Environmental Protection Agency).
Il Biodiesel viene utilizzato nel settore trasporti come sostituto del gasolio in forma pura o miscelato.
Le aziende petrolifere utilizzano Biodiesel in miscela fino al 5% per le sue qualità lubrificanti, infatti nei gasoli desolforati è necessario aggiungere additivi per fornire la lubricity necessaria affinché possa essere compatibile con la pompa e gli iniettori dei motori Diesel. Il Biodiesel utilizzato come additivo consente di ripristinare le corrette caratteristiche di lubricity del gasolio.
Il Biodiesel come carburante può essere utilizzato sia puro che miscelato fino al 30% con il gasolio fossile. In Italia la commercializzazione del Biodiesel avviene nel mercato extra rete, per chi dispone di flotte di veicoli. L'impiego del Biodiesel ha delle ricadute positive sull'inquinamento soprattutto in ambito urbano e nelle zone di intenso traffico veicolare.
La legge finanziaria da poco approvata ha previsto tra l'altro una riduzione del contingente defiscalizzato di Biodiesel prodotto in Italia, passando dalle 300.000 tonnellate del 2004 alle 200.000 tonnellate per il 2005.
I PRODUTTORI DI BIODIESEL
CONSUMI BIODIESEL PER SEGMENTI DI MERCATO
IL MERCATO IN EUROPA
1.2.2 Il Bioetanolo,
Il bioetanolo può essere prodotto mediante un processo di fermentazione da biomasse ovvero da diversi prodotti agricoli ricchi di carboidrati e zuccheri quali i cereali, le colture zuccherine, gli amidacei e le vinacce.
Le materie prime per la produzione di bioetanolo possono essere racchiuse nelle seguenti classi:
o Coltivazioni ad hoc (mais, sorgo, orzo, bietola, e canna da zucchero);
o Residui di coltivazioni agricole e forestali;
o Eccedenze agricole temporanee ed occasionali;
o Residui di lavorazioni delle industrie agrarie e agro-alimentari;
o Rifiuti urbani.
In campo energetico, il bioetanolo può essere utilizzato come componente per benzine o per la preparazione dell'ETBE (EtilTerButilEtere), un derivato alto-ottanico alternativo all'MTBE (MetilTerButilEtere).
Può essere aggiunto nelle benzine per una percentuale che può arrivare al 20% senza modificare in alcun modo il motore o, adottando alcuni accorgimenti tecnici, anche al 100%.
Il processo di produzione di bioetanolo genera, a seconda della materia prima agricola utilizzata, diversi sottoprodotti con valenza economica (destinabili, a seconda dei casi, alla mangimistica, alla coproduzione di energia elettrica e calore ecc.).
la sua produzione mondiale stimabile tra 11 e 11,5 milioni di t/anno (di cui la stragrande maggioranza negli USA e in Brasile).
L'etanolo può essere miscelato, in percentuali variabili, direttamente nella benzina in osservanza alle normative locali: dal 20% e oltre del Brasile, tra il 5,7 e 10% degli USA, al 5% massimo dell'Europa, tanto per citare le più importanti.
L'alternativa più valida al problematico impiego diretto dell'etanolo è l'ETBE, un omologo dell'MTBE con caratteristiche tecnologiche e funzionali simili e di gran lunga migliori di quelle dell'alcool di provenienza.
L'ETBE non ha problemi di volatilità o di miscibilità con la benzina, possiede un numero di ottani (valore indicante il potere antidetonante di un prodotto sotto grande pressione ed ad alta temperatura) il cui indice elevato permette di aumentare il tasso di compressione, e di fatto, aumenta l'efficacia del motore. In quanto etere, contiene anch'esso ossigeno nella molecola che gli consente di contribuire al miglioramento delle emissioni veicolari di agenti inquinanti.
Il suo elevato costo di produzione e le materie prime coinvolte, sono tali da richiedere una opportuna scelta strategica dei governi. Per questo, si potrebbe dire che il bioetanolo è un prodotto "politico", la sua presenza sul mercato, nel quadro economico attuale, può derivare da una politica coerente in campo agricolo, finanziario, energetico e non ultimo ambientale.
Ancora oggi un litro di etanolo costa circa due-tre volte la benzina. Ciò richiede un adeguato sostegno finanziario a suo favore, normalmente costituito da una detassazione di elevata entità.
L'art. 22 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) ha dato la possibilità di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili attraverso uno stanziamento di 45,5 milioni di euro, in termini di minori entrate per l'erario, per defiscalizzare parzialmente il bioetanolo e l'Etbe.
In attuazione delle citate disposizioni e del regime fiscale previsto nella Legge Finanziaria, è stato emanato il Decreto del Ministero delle Finanze 96/2004 recante agevolazioni fiscali all'etanolo di origine agricola che stabilisce le modalità di attuazione della defiscalizzazione, rendendo finalmente operativo il progetto italiano sul bioetanolo. In particolare, all'art. 1 comma 1, si approva il progetto sperimentale, della durata di un triennio, "al fine di incrementare l'impiego di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale" attraverso l'utilizzo come carburanti, da soli o in miscela con oli minerali, dei prodotti di seguito riportati:
- bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
- etere etilbutilico (Etbe) derivato da alcole di origine agricola;
- additivi e riformulati, prodotti da biomasse, utilizzati come additivi per benzine e per gasolio, escluso il biodiesel.
La legge finanziaria 2005 ( L. 311/2004) nel prorogare il regime di defiscalizzazione ha previsto di aumentare lo stanziamento a 73 milioni annui , con una prospettiva di sostenere tale impegno economico per altri due anni.
1.2.3 Olio Combustibile Vegetale ( S.V.O.)
L' olio vegetale puro[1](Straight Vegetable Oil – SVO, Pflanzenöl), rappresenta una filiera che oggi risulta matura e consolidata (soprattutto in Germania).
L'olio vegetale puro può essere impiegato per scopi diversi:
- l'alimentazione di motori diesel statici per la produzione di energia elettrica ed energia termica in mini impianti cogeneranti (a partire da 9 kWe);
- l'alimentazione di motori diesel di automobili, autobus, motori nautici, trattori agricoli, etc…
A differenza del biodiesel, l'olio vegetale puro (SVO) comporta numerosi vantaggi, i principali sono:
- La produzione dell'olio vegetale puro è diretta (semplice pressatura a freddo dei semi delle piante oleaginose o eventualmente un'estrazione con solventi), mentre la produzione del biodiesel comporta numerosi passaggi di lavorazione intermedia (esterificazione con aggiunta di metanolo, purificazione, distillazione e stabilizzazione chimica) che oltre a dare alcuni problemi ambientali, riducono di molto la remunerazione del produttore primario.
- La produzione di biodiesel richiede grossi impianti industriali di trasformazione (elevati investimenti) che limita la remunerazione del produttore primario (agricoltore) al 15% del prezzo ottenibile dalla vendita del biodiesel; mentre la produzione di SVO può essere ottenuta direttamente nell'azienda agricola con semplici sistemi di pressatura e ciò permette di massimizzare il profitto per l'imprenditore agricolo.
- Il biodiesel non è adatto alla produzione decentralizzata e su piccola scala e questo comporta quindi una "dipendenza" degli agricoltori da parte del settore industriale.
- Il processo di produzione del biodiesel comporta la produzione di sottoprodotti di difficile smaltimento (glicerina).
- - Il metanolo (impiegato per la produzione del biodiesel) è quasi esclusivamente ricavato da fonti energetiche fossili.
- Il biodiesel ha un contenuto energetico inferiore all'SVO.
- Diversamente dall'SVO, il biodiesel richiede l'impiego di cospicui quantitativi d'acqua per il processo di purificazione in fase di produzione.
- Il prodotto di scarto della produzione dell'SVO è rappresentato da farine ricche di oli (5-10%), adatte all'alimentazione di animali da ingrasso (vitelloni, suini).
- - A differenza del biodiesel, l'olio vegetale puro può essere prodotto direttamente dall'azienda agricola in forma singola o associata, diventando così una fonte energetica locale e diffusa nel territorio rurale.
La tecnologia è da considerasi matura e affidabile; ad oggi esistono numerosi esempi applicativi in Germania, paese nel quale hanno sede numerose aziende produttrici di cogeneratori e di motori a olio vegetale puro, per il settore dei trasporti su gomma e per imbarcazioni (es. ELSBETT). Per il prossimo futuro la Germania, si è posta l'obiettivo di sostituire il 3% del fabbisogno di carburanti fossili destinati al trasporto privato con SVO. In Baviera solo negli ultimi due anni si contano circa 500 nuove automobili private alimentate direttamente a SVO.
Per la produzione di olio vegetale puro a scopo energetico sono adatte tutte le colture agrarie oleaginose ed in particolare la colza ed il girasole.
Per ovviare ai problemi dovuti alle basse temperature la tecnologia ha provveduto attraverso una preriscaldamento dell'olio prima di entrare in camera di combustione.
1.3 BIOGAS
Il biogas che all'inizio degli anni ottanta aveva suscitato molte aspettative per poi subire una brusca frenata per la scarsa resa economica degli investimenti, sta ritornando di attualità. Questo soprattutto grazie alle nuove tecnologie introdotte e all'esperienza maturata in questi anni soprattutto in Germania.
Per il 2002 la produzione di biogas nel paesi dell'UE si stima in 32 milioni di MWh, circa il 38% è biogas da discariche di rifiuti urbani ( observer 2003).
EuroObserv'ER stima per l'Italia una produzione di biogas nel 2002 di 155 ktep ( circa 1,8 milioni di MWh) , oltre un terzo è dovuta al recupero di biogas da discariche.
Un censimento del 1999 contava 72 impianti a biogas a liquami zootecnici in Italia, in larghissima parte impianti aziendali. La quasi totalità degli impianti è localizzata nelle regioni del nord. Alla fine del 2003 sono calcolati oltre 100 impianti dei quali 70 impianti semplificati a basso costo, realizzati sovrapponendo una copertura di materiale plastico ad una vasca di stoccaggio liquami zootecnici.
Recentemente si è mostrato interesse alla codigestione dei liquami con colture energetiche ( mais e sorgo zuccherino) con la concreta realizzazione di alcuni impianti di questo tipo.
2 Gli elementi di criticità
Scarsa informazione e comunicazione
Le informazioni che il sistema dei media diffondono sulle bioenergie o agrienergie sono decisamente scarse, anche se in realtà esse rappresentano da sole oltre il 50% di tutte le rinnovabili in Europa. In Italia il raffronto tra tutte le energie rinnovabili vede ancora in testa le fonti derivate dal settore agricolo che pesano per oltre il 30% ( 29% legno-energia, 0,56% biocarburanti, 1,10% Biogas) rispetto all'energia solare che ( dati ENEA 2002) non supera il 0,10 % , l'energia eolica che è pari a 1,81%, l'idroelettrica che per tradizione nel nostro paese pesa il 55% grazie agli impianti presenti soprattutto nell'arco alpino.
Quindi, malgrado l'evidenza l'attenzione dei programmi televisivi , riviste, giornali è soprattutto concentrata sull'energia solare , sull'energia dal vento, e talvolta anche sull'idrogeno.
Convenienza economica
Tutte del energie rinnovabili e quindi anche le agrienergie devono fare i conti con la competizione delle fonti fossili ( petrolio, gas naturale, carbone) e dell'energia nucleare.
La convenienza economica delle rinnovabili , nonostante le pesanti accise che gravano su gasolio e benzina, rappresenta un ostacolo serio alla loro diffusione. Senza una chiara politica di incentivazione e promozione le agrienergie , come le altre rinnovabili stentano a svilupparsi in modo adeguato.
Nonostante ciò alcune filiere energetiche cominciano a dimostrare la loro capacità competitiva, sia per l'aumento progressivo del prezzo del petrolio e del gas naturale, sia per la maggiore efficienza che la nuove tecnologie stanno dimostrando. In particolare la filera "legno- energia soprattutto per la produzione di energia termica e nella cogenerazione, attraverso l'impiego di nuove e moderne apparecchiature ha messo in evidenza interessanti vantaggi economici. Analogamente anche l'impiego di olio vegetale puro a scopo energetico e gli impianti per la produzione di biogas di ultima generazione, sulla base delle più recenti esperienze austriache e tedesche, stanno dimostrando significativi successi economici.
Il rapporto con le industrie di trasformazione
Il processo di produzione di Biodiesel e Bioetanolo avviene attraverso le industrie di trasformazione che, di fatto ne controllano il mercato e acquisiscono la parte più rilevante del valore aggiunto. Attualmente il mondo agricolo ha una scarsa capacità contrattuale anche perché finora non ha saputo costruire nel territorio una vera e propria filiera produttiva che sappia quindi negoziare rapporti economici più vantaggiosi e costanti nel tempo.
La vicenda del biodiesel in Italia è emblematica delle scarse ricadute per i produttori agricoli nazionali. Infatti la gran parte di questo biocarburante viene prodotto da materia prima agricola importata, tant'è che molti impianti di trasformazione sono stati costruiti proprio in prossimità dei porti. Quindi i vantaggi che i provvedimenti di defiscalizzazione previsti nelle ultime leggi finanziarie ( 200.000 tonnellate per il 2005) dispongono, non vanno agli agricoltori italiani, se non in minima parte.
Quanto al Bioetanolo vige la preoccupazione che le sostanziose defiscalizzazioni previste in finanziaria ( 73 milioni di euro all'anno per tre anni) servano principalmente a ridurre le scorte invendute di vino e a trasformare i sottoprodotti degli zuccherifici e del settore agroindustriale. Starà anche nella capacità delle associazioni agricole di attivare e proporre e negoziare con le distillerie, filiere energetiche territoriali da colture dedicate ( barbabietole, sorgo, mais, frumento, ecc) sulla base di contratti certi e remunerativi.
Normative
Tutto il settore delle agrienergie necessita di normative su:
-Standardizzazione della qualità dei combustibili , occorre cioè definire norme sulle caratteristiche di questi prodotti , il loro potere energetico, i contenuti, le emissioni prodotte, ecc, in modo da creare un mercato trasparente e fornire garanzie ai consumatori.
- Tecnologie che impiegano questi combustibili per produrre energia, che considerino le innovazioni introdotte e che diano certezza sui livelli di efficienza energetica, anche attraverso la loro certificazione.
Risorse
Le risorse disponibili a livello nazionale per incentivare e promuovere lo sviluppo delle agrienergie non sono rilevanti ma soprattutto non sono inserite in un quadro organico finalizzato . Esse trovano origine da provvedimenti e iniziative diverse in campo ambientale, agricolo, e dell'innovazione tecnologica.
Il Programma Nazionale Biocombustibili promosso dal MIPAF nel 2004 ha attivato 1,9 meuro , una cifra decisamente contenuta, se si considera che è stata " spalmata" tra le venti regioni.
Formazione professionale
Questo settore ha bisogno di un percorso formativo lungo tutta la filiera: produzione colture dedicate, produzione dell'energia, installazione e manutenzione delle tecnologie.
3 Le proposte della CIA al Governo
3.1 il pieno riconoscimento delle IMPRESE AGRIENERGETICHE, espressione della multifunzionalità
Sia per ragioni ambientali legate alla necessità di ridurre il consumo di combustibili fossili ( Protocollo di Kyoto), che per ragioni economiche in ragione degli aumenti del costo del petrolio e del gas naturale che si prevede continueranno ad aumentare, l'interesse e la crescita delle imprese agricole verso le colture a scopo energetico e la produzione di energie rinnovabili è di grande attualità. In effetti le iniziative in tal senso si registrano sempre più numerose.
Dalle esperienze più significative realizzate dai paesi del nord Europa ( Austria e Germania), emerge che il maggior valore aggiunto in questo campo si ottiene quando l'imprenditore agricolo non si limita a produrre le materie prime ( legno, semi oleosi, liquami zootecnici, ecc) ma quando gestisce direttamente la produzione e la vendita di energia termica ed elettrica.
Ad esempio l'esperienza austriaca denominata " Holz Energie Contracting" cioè il contratto legno - energia , che prevede la realizzazione di piccole reti di teleriscaldamento di proprietà di agricoltori che a partire dalla propria abitazione , riscaldano le altre abitazioni dei vicini privato o albergatori, vendendo ad essi energia termica, attraverso un contratto messo a punto con l'intesa delle autorità locali e le organizzazioni agricole.
In altri casi sono sorte cooperative agri energetiche che sono proprietarie degli impianti a biogas che vendono l'energia elettrica immessa in rete. Ancora, altre imprese agricole associate che producono olio vegetale puro e lo consumano come carburante per una flotta di 100 trattori e 500 automobili.
Alcune iniziative in tal senso sono sorte anche in Italia, ed altre ancora ne nasceranno, anche per le opportunità che il sistema del "disaccoppiamento" del premio PAC mette in gioco.
In virtù del principio della multifunzionalità, in passato sono nate le aziende agri turistiche, le fattorie didattiche, le agri faunistiche. Oggi stanno nascendo le imprese agri energetiche, cioè le imprese agricole che oltre alla coltivazione e produzione di materie prime energetiche, producono e vendono energia termica ed elettrica.
Secondo il nuovo art. 2135 del codice civile (modificato dall'art. 1 d.ls. 18 maggio 2001, n. 228) che disciplina la figura dell'imprenditore agricolo, sono attività agricole anche quelle connesse .. "dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali".. . Ne deriva che produrre e vendere energia da parte dell'imprenditore agricolo che, a tale scopo trasforma i prodotti della propria azienda, è una attività agricola.
Questo principio dal punto di vista civilistico è molto importante ma non risolve ancora tutti i problemi.
E' necessario ottenere un provvedimento legislativo, che riconosca in pieno anche dal punto di vista fiscale, normativo e operativo la nuova figura di IMPRESA AGRIENERGETICA.
3.2 le risorse e le politiche per il sostegno del settore
Nell'ambito delle nuove opportunità per le imprese agricole è necessario promuovere e sollecitare un provvedimento quadro per incentivare e sostenere la nascita di imprese agrienergetiche e che metta a disposizione le risorse necessarie con una programmazione pluriennale certa.
Occorre inoltre garantire in modo programmato per i prossimi anni, un adeguato "plafond" di riduzione delle accise per tutti i biocombustibili prodotti dai nostri imprenditori agricoli singoli ed associati.
4 Le iniziative della CIA per lo sviluppo del settore
La CIA in questi ultimi tre anni ha avviato positivamente alcune iniziative importanti in questa direzione, infatti ha promosso la nascita di AIEL Associazione Italiana per l'Energia dal Legno che, per l'attività sviluppata, è diventata una delle principali associazioni italiane del settore. L'associazione oltre ad occuparsi del settore delle biomasse legnose, sta ampliando la propria attività anche nel campo delle altre agrienergie.
E' necessario proseguire e sviluppare iniziative nel campo della formazione professionale, della informazione, divulgazione e consulenza tecnica nel territorio al servizio degli agricoltori, per la costituzione di efficienti filiere agrienergetiche.
[1]«olio vegetale puro»: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni. (art 2 c.2j DIR 30/2003/CE)